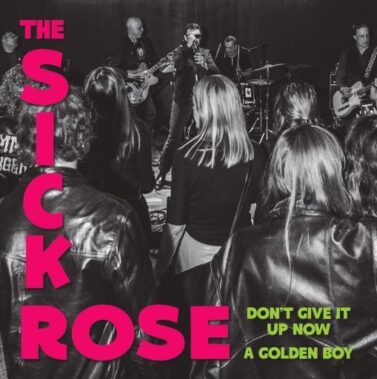Un disco dei Chemical Brothers recensito su InYourEyes, sì. Perché a volte bisogna uscire dal seminato, cercare di non fossilizzarsi troppo a livello musicale (che quasi sempre, di conseguenza, è sinonimo di chiusura culturale e poca elasticità mentale) fare dei giri fuori dalla propria comfort zone e misurarsi con altri generi e altri mondi diversi dal rock ‘n’ roll (anche se poi, a ben vedere, non sono mica così distanti: le interconnessioni tra R’N’R e musica elettronica, negli ultimi sessant’anni di storia della musica popolare, ci sono sempre state e sono innumerevoli, dal sincretismo illuminato del Krautrock tedesco agli esperimenti di precursori del synth-punk come i DEVO, i Suicide o gli Screamers, all’esplosione su larga scala del post-punk e della “new wave” a fine Seventies, fino ad arrivare alla scena “MADchester” di fine Eighties, ai più recenti sottogeneri dance-punk, al filone egg punk e ai punti in comune tra cultura rave e quella punk) che in realtà, agli occhi e alle orecchie di un ascoltatore sveglio e senza troppi pregiudizi, è un falso problema, vista la trasversalità che il duo di disc jockeys e producer inglesi Ed Simons e Tom Rowlands ha sempre incontrato presso i gusti del pubblico mondiale, che sin dai loro inizi a metà anni Novanta (abbandonato il moniker Dust Brothers) ha abbracciato la loro alchimia che privilegia un crossover tra mondi apparentemente inconciliabili e musica elettronica ballabile e “danzereccia” che, però, non ha mai disdegnato puntate, collaborazioni (Bobby Gillespie, Bernard Sumner, Noel Gallagher, Richard Ashcroft, Beck, Hope Sandoval, Tim Burgess) manipolazioni e campionamenti sonori (ad esempio i sample di “Sympathy for the Devil” degli Stones nella versione dal vivo di “The private psychedelic reel” o di “Starman” di Bowie in “Star Guitar“, o i Beatles di “Tomorrow never knows” e “Revolution 9” campionati sin dagli esordi, o ancora gli Who di “Baba O’Riley” in “Escape Velocity” e altri) presi in prestito dall’universo “rock” del passato, riuscendo ad arrivare a piacere a entrambi i lati della “barricata” e dimostrando che, se c’è la volontà e si propone “good stuff“, a prescindere dalla musica proposta (a parte, ovviamente, le piaghe irrecuperabili della “trap music”, del reggaeton e della musica neomelodica) tante barriere e confini si possono abbattere senza doversi per forza snaturare o “sputtanare” (e mi riferisco soprattutto alla becera mentalità intransigente dei “duri e puri”, anch’essa purtroppo trasversale) e anzi, spesso è anche divertente mischiare le carte.
L’otto settembre, su Virgin EMI Records (e per una volta sorvoliamo su un disco pubblicato su una multinazionale) è uscito “For That Beautiful Feeling“, decimo studio album ufficiale dei nostri (un traguardo niente male, per “due tizi” che agli inizi degli Nineties non avrebbero mai pensato di diventare famosi a livello mondiale) giunto quattro anni dopo la buona prova di “No Geography” (e anticipato a fine aprile dal singolo “No Reason“, che conteneva anche un brano poi non inserito nella tracklist finale, “All of a sudden“, un trip techno che si riallacciava al passato, con un beat martellante, un efficace riff di tastiere electro e una freakout vibe in grado di far rilasciare salutari endorfine) e non è l’unica novità riguardante il tandem Rowlands-Simmons in questo 2023, perché in cantiere c’è in programma anche l’autobiografia definitiva degli eterni ragazzi di Manchester, intitolata “Paused in cosmic reflection“, la cui uscita è prevista a fine ottobre e nella quale verrà raccontata, ovviamente, la storia e l’avventura dei Chem Bro’s.
Una premessa sincera: il sottoscritto non si reputa affatto un esperto di electronic dance music, breakbeat, acid house, trance, big beat, techno et similia, pertanto approccia alla materia in maniera assolutamente profana, pur tuttavia apprezzando i Chemical Brothers da diversi lustri e reputando i primi tre Lp del progetto, “Exit Planet Dust“, “Dig Your Own Hole” e “Surrender” il migliore materiale mai inciso (e quello più legato alla scena underground) dai due britannici che, in seguito, a parte qualche scivolone troppo scontato (parere personale) come “Galvanize“, “The Salmon dance” o “Do it again“, ha quasi sempre mantenuto un accettabile livello di evoluzione qualitativa di album in album, nonostante un successo “commerciale” sempre più di massa che, di fatto, ha inevitabilmente smussato i lati più spigolosi della loro formula. Ma chi mastica da decenni la club culture può garantire sulla bontà e la bravura delle performance offerte da Ed e Tom alla consolle e ai synth (e la dimensione ideale per vederli all’opera è, logicamente, nei concerti che fanno durante i tour in giro per il mondo, vere e proprie esperienze sensoriali di suoni e colori in cui la parte musicale e quella della stage visuals-scenografia grafica da palco, curata in modo maniacale e impeccabile, si fondono, generando un impatto visivo e sonico decisamente coinvolgente e contagioso, capace di dare vita a un rito collettivo che trascina, per almeno un paio d’ore, migliaia di persone a lasciarsi trasportare dal flusso di un energico sabba lisergico) che si sono fatti la loro bella gavetta nei locali tra remix on the fly e suoni creati in tempo reale e assemblati sul momento, senza fingere né imbrogliare con robe premixate, e qui inoltre va sfatato un altro mito: quello del dj che non fa una beata minchia e “non suona i dischi” come un vero musicista. In realtà, se fatto bene e a livello professionale, anche quello del disc jockey è un mestiere d’arte, perché richiede ore e ore di allenamento ai vinili (e anche ai cd, i tanto bistrattati compact discs, ormai anche loro assurti a strumento vintage con quattro decadi sul groppone) e di costante applicazione perché non si può improvvisare il proprio stile, altrimenti l’amante della musica che ha occhio e orecchio ti sgama subito. Anche il mettere i dischi a tempo e creare una sequenza logica tra una canzone e l’altra è suonare musica, inventarne di nuova utilizzando porzioni di composizioni altrui o mixando live i beat strumentali a proprio gusto per comporre nuova musica di sana pianta, e bisogna fare tanta pratica per sviluppare il proprio modo di far suonare il mixer e imparare a miscelare, fare cutting, giocare con le frequenze e apprendere le tecniche dello scratch, del beat juggling, del beatmatching e della disciplina del turntablism che è una vera e propria arte da funamboli del giradischi: il resto è solo roba da cialtroni modaioli che fanno i fighi in playback col materiale preregistrato e possono prendere in giro solo gli sprovveduti.
I Chems aprono le danze con una intro robotica che ripete ossessivamente il titolo del full length, e che dopo circa un minuto sfuma e ci fa entrare nel vivo del (rave) party, quando si dipana il brano di punta del lotto, l’euforica “Live again“, che vede il featuring della cantante parigina Halo Maud, e subito diventato in instant classic del repertorio live, e dotato di una forte connotazione “anni Novanta”, non una operazione nostalgica ma un recupero di certe atmosfere, condite da liriche ottimistiche, che hanno reso i Fratelli Chimici autentici top players della scena big beat insieme a Fatboy Slim e i Prodigy. Si procede con l’altro pezzo forte del long playing, il succitato singolo “No Reason“, in bilico tra post-punk e funk (che cita un sample vocale proveniente dal 1979, contenuto in “Courts of Wars” dei Second Layer di Adrian Borland) che già questa estate aveva saputo ritagliarsi un suo spazio nei live set, riscaldando a modo i dancefloor, mentre con “Goodbye” (anch’essa con vocals rielaborate dal brano soul di Teresa Harris and The Gene Parker Quintet del 1980, “Good-bye“) si esplorano dimensioni retro-futuristiche che si riallacciano al big beat degli esordi, ma aggiornate coi mezzi tecnologici del 2023, e ci addentriamo nella parte centrale dell’Lp che è, senza dubbio, quella più riuscita e meglio messa a fuoco, orientata verso un viaggio psych allucinato, tra il groove scintillante black disco à la Chic sotto effetto dell’MDMA e fritto dai synth di “Fountains“, il beat poderoso basso/batteria di “Magic wand” (che campiona una sequenza vocale del pezzo soul “Nothing from nothing” di French Coffey) e i travolgenti bassi di “The weight” che rimandano piacevolmente al periodo “Dig Your Own Hole”. Un disco dei CB non è tale se non presenta almeno una collaborazione con musicisti noti, e allora ecco il ritorno di Beck per un nuovo duetto, “Skipping like a stone“, che però, a conti fatti, risulta essere il momento più debole dell’opera, col suo taglio troppo radio-friendly. La parte finale vede la già edita “The darkness that you fear“, uno dei tre singoli rilasciati prima dell’uscita di FTBF, e quest’ultimo comparso addirittura nel 2021, ammantato di una melodia dream pop dal feeling speranzoso, poi le casse tornano a infiammarsi con “Feels like I’m dreaming“, quasi sette minuti di strabordante techno, già efficacemente collaudati dal vivo in estate, col titolo reiterato come un mantra che rilascia drops e botte di quelle che stendono e fanno ribollire di entusiasmo le piste da ballo, un ultimo sussulto prima della chiusura affidata alla title track che vede tornare alla voce Halo Maud, rallenta il ritmo, che si fa dolce ed estatico, perché al netto di tutto, “Love is all“, come amano ribadire Rowlands e Simons al termine delle loro esibizioni: la traccia necessaria per raffreddare gli infuocati spiriti nel post-party.
In questi tempi bui a livello globale e, soprattutto, a livello locale, nel nostro “ridente” Paesello alla periferia dell’impero atlantista, “governato” da una imbarazzante accozzaglia destrorsa, forte coi deboli e debole coi forti, e che, tra i primi “provvedimenti” presi, ha varato una “legge” volta a colpire i rave party (che poi, diciamocelo chiaro una volta per tutte, utilizza solo pretestuosamente i raduni tra gli amanti di un certo tipo di musica e i loro ritrovi “illegali”, celando, dietro la comoda foglia di fico dei ggggiovani komunisti nullafacenti che bivaccano, si ubriacano, si fanno di bamba e spacciano la ddddruoga alle feste fatte di “rumore assordante”, la reale intenzione di ostacolare e punire tutte le forme di aggregazione tra persone, anche quelle davvero più scomode per il Potere borghese costituito, come gli scioperi lavorativi antipadronali, e dunque mirando a impedire/eliminare definitivamente il diritto alla protesta politica e non, ma lo nasconde furbescamente dietro il finto problema di ordine pubblico dei “festini pericolosi” e degli “alternativi” sballati e “fuori controllo” da manganellare e rieducare sulla retta via “sovranista” della triade dio-patria-famiglia, perché i mass media mainstream, in questo modo, trovano il capro espiatorio perfetto per fare indorare la pillola liberticida a una sempre più incattivita e ignorante opinione pubblica) un disco come “For That Beautiful Feeling“, seppur confezionato con una buona dose di mestiere, arriva come una ventata di salvifico ossigeno per chi non è stanco di lottare per un mondo migliore e culturamente multipolare nella sua diversità e non si è ancora arreso all’idea di una società distopica dominata solo da brutture orwelliane e aberrazioni “autarchiche” e dannosamente nazionalistiche (ma che in tema di politica estera sono in continuità col passato di spudorato servilismo dell’obbedire ciecamente all’imperialismo yankee). E allora, non lasciate disperdere il valore sociale dello stare insieme e andare ai concerti e alle feste per ascoltare musica e creare una rete di contatti e affinità con decine, centinaia o migliaia di persone. E’ questo il “beautiful feeling” che va preservato più di ogni altra cosa al mondo.