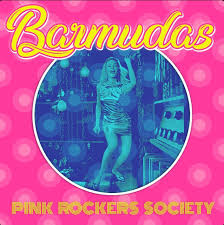Lo scorso 21 ottobre si è svolta presso lo Slaughter di Paderno Dugnano la quinta edizione del Doom Earth Fest, una rassegna che è diventata ormai un punto fisso per gli appassionati del doom estremo, organizzata come sempre da Alberto Carmine (alias Morpheus, fondatore e motore della pagina FB Doom Heart), anche quest’anno coadiuvato dai musicisti appartenenti band death doom bresciana (Echo): una collaborazione che, da quando è stata avviata, ha consentito di unire forze e risorse per poter portare nomi sempre più importanti al cospetto del pubblico italiano.
Questa volta il bill era, se possibile, ancor più competitivo, soprattutto per il ritorno nel nostro paese dei Clouds, a cinque anni dal concerto di a Roma di supporto agli In Mourning, e la prima apparizione in Italia dei Pantheist, una delle band storiche del funeral doom; inoltre destava un certo interesse poter vedere in versione live i Remina di Heike Langhans (ex-Draconian) e Mike Lamb, i Formalist, band che unisce le forze di due pezzi da novanta della scena estrema italiana come Ferdinando Marchisio (Forgotten Tomb) e Michele Basso (Viscera ///, Malasangre), e infine i Somnent di Giovanni Vigliotti, musicista americano di chiare origini italiane, che hanno avuto l’onore e l’onere di aprire questa bellissima serata.
Il sound dei Somnent è un death doom melodico che però è piuttosto lontano dallo stile nordeuropeo, andando piuttosto a prendere ispirazione e sensazioni dagli Antimatter, in particolare nelle parti più intimiste cantate in clean in cui il bravo Giovanni utilizza una timbrica che ricorda non poco quella di Mick Moss.
Trattandosi di un progetto solista, dagli Stati Uniti il leader è giunto con il solo bassista Shane Dohman, per cui a completare la band dal vivo hanno provveduto due membri dei Ghostheart Nebula, Nick Magister (chitarra) e Panta Leo (batteria); nonostante i possibili problemi di coesione il set è stato assolutamente convincente, ma al riguardo non avevo dubbi sia per la bravura dei musicisti “supplenti”, sia per la bontà dei due full length finora pubblicati, oltre che per aver già potuto constatare di persona l’operato dei Somnent nello scorso febbraio sul palco del festival doom belga Haunting the Castle.
A seguire è stato il momento dei Formalist, la band che rispetto alle altre era quella stilisticamente più lontana dai canoni stilistici tipici del funeral death doom atmosferico; infatti, il sound offerto nei due notevoli full length finora pubblicati è uno sludge drone corrosivo e privo di alcuna connotazione melodica.
Se tutto ciò può aver in qualche modo spiazzato alcuni spettatori più inclini sonorità meno estreme, va detto che la prestazione è stata di grande spessore; i Formalist sono una realtà in grado di scaraventare sull’audience questa forma musicale in maniera potente, precisa e intensa, ed è un peccato che molti abbiano scelto di stare fuori dal locale invece di dare comunque un ascolto, oltre a garantire un meritato e adeguato supporto (sull’argomento tornerò alla fine di questo resoconto).
La salita sul palco dei Remina ha come prevedibile riportato parecchia gente all’interno dello Slaughter, intanto perché la loro proposta era la più immediata del lotto, cosa tutt’altro che inattesa essendo incentrata su una vocalist come la sudafricana Heike Langhans, ben nota nella scena per la sua lunga militanza nei Draconian, in un progetto formato assieme al compagno neozelandese Mike Lamb (Sojurner, Lysithea, tra gli altri).
Anche i Remina hanno fatto ricorso a musicisti italiani per poter suonare dal vivo (Giovanni Feroldi, basso, anch’esso dei Ghostheart Nebula, Mauro Ragnoli, chitarra, dei co-organizzatori (Echo), e Riccardo Floridia, batteria, già con Lamb nei citati Sojourner) ma, in questo caso, non si trattava di una primizia avendo già partecipato con questa conformazione a diverse date fuori dall’Italia; un line-up ben consolidata e rodata ha dato la possibilità ai Remina di offrire un set coinvolgente e molto apprezzato dal pubblico, anche appunto alla luce della fluidità di un sound esaltato da una delle migliori cantanti della scena gothic doom.
L’ingresso dei Pantheist ha cambiato in maniera decisa le atmosfere e i toni della serata, intanto perché parliamo dell’unica band il cui sound era basato sostanzialmente sulle tastiere, strumento d’elezione del leader e fondatore Kostas Panagiotou; come molti sapranno (e come viene anche descritto nella parte che vi ho dedicato nel mio libro), i Pantheist, ora di stanza nel Regno Unito ma in realtà fondati negli anni novanta in Belgio, sono stati tra i precursori del funeral doom in quella porzione d’Europa per poi spostarsi lentamente verso sonorità più progressive giungendo, a un certo punto della loro carriera, al punto da non poter esse più incasellati nello stesso doom metal nel senso più canonico del termine.
Gli ultimi anni, soprattutto con l’ultimo splendido full length Closer to God, hanno segnato il ritorno a certe sonorità degli esordi anche se rivedute e adeguate alla contemporaneità; nello specifico il lavoro in questione contiene chiare influenze morriconiane e d’altronde il Maestro italiano è da sempre una delle fonti d’ispirazione per Panagiotou che, unendovi la pesantezza del delle partiture Doom, ha creato un connubio in grado di rendere quest’ultimo lavoro una delle opere migliori uscite negli ultimi anni.
I Pantheist dal vivo sono semplicemente un godimento per le orecchie e anche per gli occhi, visto che il buon Kostas, col suo abito talare e la tastiera Roland piazzata al centro del palco, si rivela un personaggio in grado di trasformarsi in grande protagonista nell’interpretazione dei brani di sua composizione, nonostante la modestia e l’affabilità che lo contraddistinguono fuori dalla scena.
Il momento clou della serata indubbiamente erano quei Clouds che sono diventati nel corso degli anni il progetto principale di Daniel Neagoe, musicista emerso prepotentemente nei primi anni dello scorso decennio con gli Eye of Solitude; infatti, i Clouds erano nati inizialmente come un progetto una tantum, volto a riunire diversi musicisti europei della scena doom di caratura internazionale, per poi proseguire con tale formula, visti i notevoli riscontri ottenuti, fino a diventare una band vera e propria formata esclusivamente da musicisti rumeni.
Lo stesso Daniel, rispetto a quando ebbi occasione di vederlo all’opera in quel di Roma cinque anni fa, oggi appare in tutto e per tutto un’altra persona, intanto perché i problemi alla schiena di cui ha sofferto negli ultimi anni lo hanno costretto a perdere qualche decina di chili ma, soprattutto, ciò che è maggiormente cambiato è il suo impatto scenico: il Neagoe statico sul palco e concentrato quasi esclusivamente sulla propria prestazione vocale si è trasformato in un frontman capace di coinvolgere il pubblico con un fare quasi istrionico senza che, per questo, venga scalfito l’enorme potenziale evocativo e con esso le emozioni che grondano da ogni nota della musica dei Clouds. La band (in cui va rimarcato il peculiare operato di Andrei Oltean con i suoi strumenti a fiato) ha sciorinato gran parte dei propri migliori brani attingendo maggiormente agli ultimi due lavori Durere e Despărțire, toccando vette di spasmodico lirismo nelle magnifiche Empty Hearts e A Father’s Death (un toccante brano che Daniel ha scritto in memoria del padre scomparso alcuni anni fa).
Piuttosto inusuale si è rivelato il commiato dei Clouds visto che, in occasione della conclusiva Deepen Wound, Daniel ha chiamato sul palco a interpretare vocalmente il brano alla loro maniera alcuni musicisti/fans che erano nelle prime file: un epilogo che ha ben espresso il senso di gratitudine e il legame indissolubile creatosi tra la band e gli spettatori. Purtroppo, le cose belle sono destinate a finire e questo è stato l’ultimo momento di una serata memorabile (complice anche l’incombere di un DJ set a seguire, peccato).
Come avevo anticipato in precedenza apro una parentesi per rimarcare alcune cose che non mi sono piaciute e che esulano dall’aspetto prettamente musicale; in primis, ho riscontrato per l’ennesima volta quel malcostume che spinge molti degli spettatori (paganti) a ignorare l’esibizione di alcune delle band: mi rendo conto che nel corso di un evento della durata di 5-6 ore qualcuno voglia prendersi una pausa più o meno lunga, ma è stato evidente che nel corso di alcune esibizioni il pubblico era più che dimezzato rispetto ad altre.
Si tratta di una critica benevola, anche perché la mera partecipazione merita più un ringraziamento che non la stigmatizzazione, ma con i numeri alquanto risicati di questo tipo di serate la presenza, anche solo fisica, per riempire qualche vuoto diviene doppiamente importante; il senso della mia argomentazione è “siamo già appassionati di un comparto musicale di nicchia e in quanto tali appartenenti a una specie in via di estinzione, se poi ci mettiamo a fare distinzioni tra i sotto-sotto generi non se ne esce”.
Meno benevola, invece, è la critica che mi permetto di muovere nei confronti di chi magari sui social network chiede a gran voce supporto per la propria band, salvo poi non mettere in pratica nei confronti degli altri quanto auspicato: è innegabile che la partecipazione, oggi come in passato, si è rivelata di gran lunga inferiore alle previsioni più ottimistiche, tenendo conto anche del potenziale bacino d’utenza. Infatti, partendo dal presupposto che gli appassionati a grandi linee possono essere questi a livello numerico, quello che è mancato sono proprio i musicisti che si dedicano a generi contigui al funeral death doom e sono attivi nella regione, per un ammontare stimabile ad almeno un altro centinaio di persone (alcuni c’erano, ma la maggior parte? Forse avranno scelto di andare all’Alcatraz a farsi perculare dai Nanowar Of Steel…); anche in questo caso non si tratta di un’accusa bensì di una riflessione ad alta voce che dovrebbe spingere proprio chi si lamenta dell’andamento della scena o delle poche presenze ai propri concerti ad essere il primo a partecipare, magari innescando così un circolo virtuoso.
Diversamente, finché tutti preferiscono fare altro o stare a casa, i veri appassionati devono solo sperare che chi organizza questo tipo di concerti (in Italia, per contarli le dita di una mano bastano e avanzano) non getti la spugna a fronte di costi che, con una partecipazione esigua, non possono essere in alcun modo coperti. Anche per questo, non rimane che esprimere un sentito ringraziamento a chi si è adoperato per regalare ore di grande musica dal vivo e a chi lo vorrà fare in futuro.
* Le fotografie che immortalano le band sul palco sono di Jennifer Badalotti.