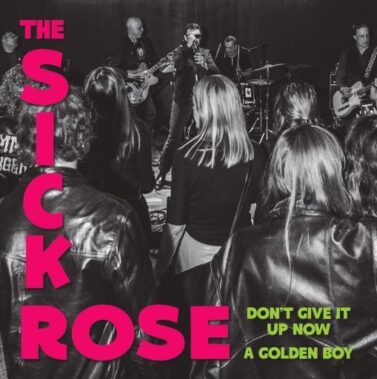Con buona pace dei ragazzi di “Trainspotting“, alla fine essere scozzesi, in fondo, non è poi così merdoso, se si pensa che in quelle terre, circa quaranta anni fa, germogliò una scena indipendente minimalista jangle/guitar/bedroom/twee/dream/noise pop che ci ha regalato gruppi come Vaselines, Pastels, Shop Assistants, Primal Scream (o almeno, quelli pre-“Screamadelica”) e altre band meno note, ma ugualmente parte di un macrogenere (brillantemente raccolto nelle compilation “C86“) i cui tratti caratteristici risiedevano in un’idea concettuale fondata su un approccio primitivo, DIY e lo-fi alla materia musicale, basata su canzoni (generalmente della durata compresa tra i due e i tre minuti) con strutture melodiche pop deturpate da strati di feedback e distorsioni, una formula che a fine anni Ottanta/inizio Novanta raccolse entusiastici consensi soprattutto nell’universo indie rock statunitense (con gli “endorsement” ricevuti da Calvin Johnson della scena punk di Olympia e, specialmente, da Kurt Cobain che adorava i Vaselines e i primi album dei Teenage Fanclub, altra formazione indie/alternative scottish). Insomma, sarà pure stata “aria fresca che non cambia uno stracazzo di niente” – parafrasando ancora Mark Renton e soci – ma ha comunque delineato e definito un certo modo (sonoro ed estetico) di declinare il rock ‘n’ roll (proseguendo nel solco tracciato dalla rivoluzione “politica” del punk rock) riportandolo alla sua essenza e spogliandolo di orpelli virtuosistici e onanismi di tecnica strumentale.
Di quella scena scozzese, sicuramente le figure di spicco e gli esponenti più importanti sono stati – e continuano a esserlo – i Jesus and Mary Chain, capitanati dai fratelli Jim e William Reid, che partendo dai dintorni di Glasgow a metà Eighties, dopo gli inizi sulla Creation Records del mitico Alan McGee (che li aveva notati e lanciati) arrivarono a sconquassare il mondo dell’indie britannico col loro folgorante Lp d’esordio “Psychocandy” che ha fatto scuola col suo concetto di rumorismo che si faceva melodia, con armonie pop affogate in un muro di suono chitarristico stordente. Dopo quell’album spartiacque (che aveva consacrato i JAMC come una tra le band più influenti della storia del rock ‘n’ roll, nonché precursora della scena shoegaze mondiale) i nostri hanno fatto parecchia strada, tra ottimi dischi (“Darklands“, “Automatic“, “Honey’s dead“) peccati di gioventù (soprattutto errori di valutazione discografica che hanno portato a dispute giudiziarie con le major) eccessi e problemi personali tra fratelli che causarono, nel 1999, un momentaneo scioglimento, poi interrotto nel 2007 con la ripresa delle attività che, dieci anni più tardi, avrebbe visto l’uscita di un Lp ufficiale a quasi due decenni di distanza dall’ultimo studio album (“Munki“) con la comparsa di “Damage & Joy“.
Esauriti i problemi contrattuali con le multinazionali, per i Jesus and Mary Chain si è aperta una nuova fase con la firma, due anni fa, per la label indipendente londinese Fuzz Club Records, che ha segnato un nuovo inizio per i fratelli Reid, finalmente liberi di incidere materiale per una etichetta “a misura d’uomo”, che ha investito tanta pazienza ed energia su di loro, spinta dall’entusiasmo di avere nel roster una band che ha ispirato tutti i gruppi che hanno lavorato con Fuzz Club e che rappresenta un patrimonio musicale e culturale da tramandare. Dopo una serie di ristampe del catalogo e la pubblicazione del disco dal vivo “Sunset 666“, il primo frutto sostanzioso della collaborazione tra gruppo ed etichetta inglese si è concretizzato, senza dubbio, nell’uscita di questo nuovo long playing, “Glasgow Eyes“, ottavo lavoro sulla lunga distanza dei nostri, che avevano iniziato a registrare nuovo materiale poco tempo prima che esplodesse la pandemia da covid-19, che aveva ritardato il processo di creazione delle canzoni, per poi riprenderlo dopo due anni di assenza forzata, completando le incisioni, appunto, a Glasgow.
A quaranta anni dai loro esordi, e risolti i dissidi tra fratelli-coltelli (o comunque tenuti al minimo, e di certo aiuta il fatto di vivere lontanissimi: uno in America, l’altro in Inghilterra) e coadiuvati dall’attuale line up (Mark Crozer al basso, Scott Von Ryper alla chitarra e Justin Welsh alla batteria) questo nuovo full length si apre subito con un duetto femminile nell’energico apripista “Venal joy” che, tra synth e distorsioni, vede come guest vocalist Fay Fife: uno schema simile, ma più cadenzato e dai risultati non brillantissimi, si ripete nella successiva “American born“, forse uno dei momenti più deboli e prevedibili del disco, mentre interessante è l’esperimento di elettronica dark in “Mediterranean X film“. Ma è senza dubbio il singolo “jamcod” il pezzo più esemplificativo del nuovo corso dei Reid, fondendo l’elettronica col caratteristico guitar sound grezzo e le consuete armonie vocali dei fratelloni. “Discotheque” è un’altra piccola chicca dell’Lp, con le sue ritmiche motorik robotiche à la Neu! impastate e fritte nel post-punk da rockoteca, a cui fa seguito il convincente drone stonato di “Pure poor“, una sorta di ballad dissezionata e allucinata. C’è spazio per un divertissement in “The Eagles and The Beatles“, che oscilla tra ritmi che sembra citare la celeberrima “I love rock ‘n’ roll” (nella versione di Joan Jett) e liriche goliardiche che tirano in ballo i Rolling Stones (Mick, Keith, Bill, Charlie and Brian Jones) i Beach Boys, Bob Dylan, gli Small Faces e i Sex Pistols (ai quali i fratellozzi furono paragonati, dalla stampa musicale, agli inizi della loro parabola artistica, a causa delle provocazioni e del “caos premeditato” con cui i Reid incendiarono le fantasie di pubblico e addetti ai lavori). “Silver strings” si regge ancora su un’anima sintetica che pervade anche la seguente “Chemical animal“, che si riallaccia al passato col suo beat di Spectoriana memoria che può far richiamare alla mente classici come “Just like honey” e “Some candy talking”. La parte conclusiva dell’opera è affidata a “Second of june” (altra semi-ballad, stavolta non ispiratissima), l’allegra – e con improbabili/involontari echi di Judas Priest – “Girl 71” che vede un’altra ospitata alla voce (quella di Rachel Conti, partner di Jim Reid) e “Hey Lou Reid“, altra boutade che suona come un omaggio a Lou Reed (manco a dirlo, e con tanto di gioco di parole tra Reed e il cognome Reid di Jim e William) e ai Velvet Underground, per poi stopparsi a metà percorso e diventare quasi un brano degli Spacemen 3.
Un ritorno a casa? A parte il rimando alla terra natia e alle propre radici, sì e no. Perché il consueto maelstrom di melodie, feedback e noise controllato c’è ancora (anche se in maniera meno marcata rispetto al passato) ma in “Glasgow Eyes“, concepito per essere una ripartenza e un secondo capitolo che si apre nel percorso musicale dei Jesus and Mary Chain, sono presenti massicce influenze elettroniche di band come Suicide, Kraftwerk et similia (un mondo che ha da sempre affascinato i Reid brothers) oggi non più “tenute a bada” ma rese parte integrante del loro processo compositivo che, nonostante quaranta anni di scombinata avventura sul groppone, si basa sempre su un approccio creativo spartano e senza fronzoli, rimasto simile a quello dei primi album (soprattutto “Darklands”, che fu registrato con l’ausilio della batteria elettronica) ora aperto, però, anche a nuove soluzioni sonore, sebbene in linea con l’evoluzione discografica dei Reid, che quest’anno hanno in uscita anche una autobiografia e un documentario. Di certo questo semi-ritorno alle radici ha offerto, senza tema di smentite, il miglior materiale pubblicato dall’ensemble scozzese – al netto del temporaneo scioglimento – da venticinque anni a questa parte. E a sessant’anni può essere naturale (e fisiologico) non avere più la sfrontatezza e l’irriverenza sonica dei vent’anni, ma il dolce frastuono resiste ancora alla barbarie del tempo-mondo canaglia e, per adesso, va bene così.