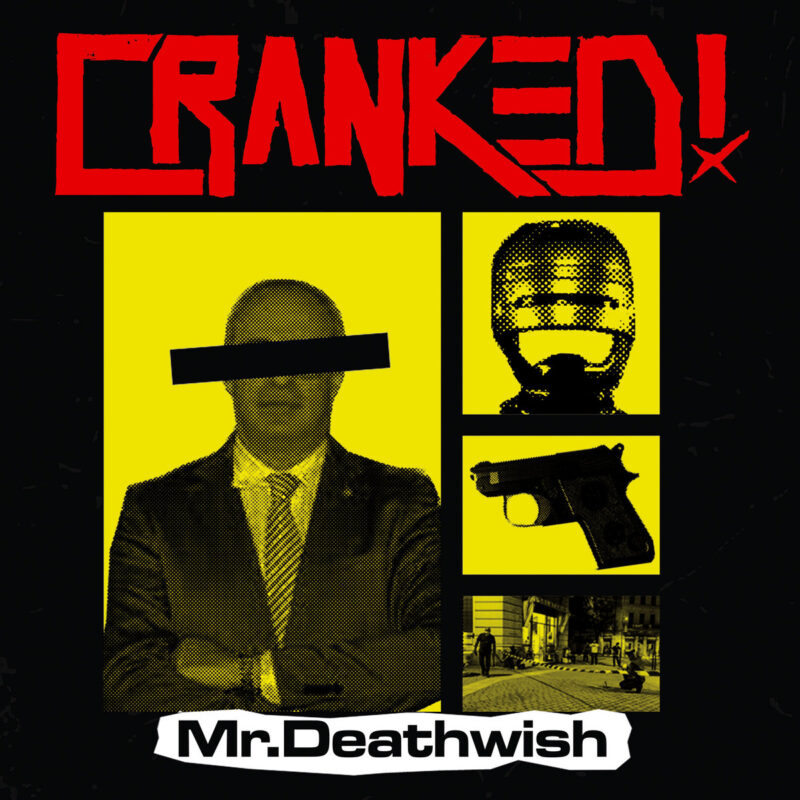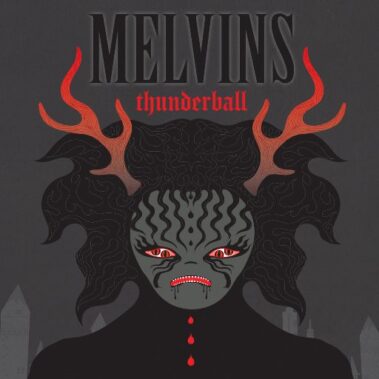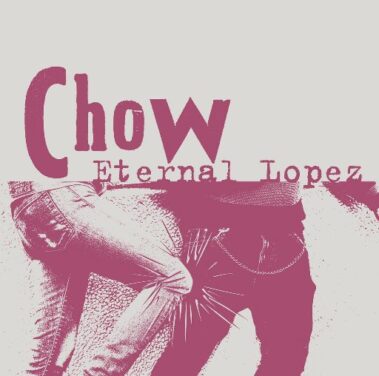Meglio mettere subito le cose in chiaro: è impossibile ascoltare questo disco con lucidità e distacco emotivo, quando non ci si è ancora ripresi dalla terribile notizia che ne ha preceduto l’uscita. Metabolizzare il lutto per la recente, improvvisa e prematura scomparsa di Steve Albini, frontman e fondatore degli Shellac (nonché imprescindibile punto fermo e di riferimento per la scena rock ‘n’ roll underground e la musica indipendente mondiale) è impresa ardua e richiederà parecchio tempo per essere accettata: eppure, tra lacrime, necrologi, commemorazioni, aneddoti, esempi di rettitudine morale nel suo essere musicista e recording engineer, e gli insegnamenti preziosi su etica lavorativa DIY di cui far tesoro come eredità artistica e spirituale, la vita deve andare avanti, e forse il modo più suggestivo per celebrare il ricordo di una persona stimata e amata da (almeno) qualche milione di persone, e ringraziarla per quanto ci ha donato (morendo praticamente sul posto di lavoro, in quegli studi di registrazione di Chicago che sono stati il suo orgoglio e la sua corazza per difendersi dalla merda del mainstream discografico e dal business delle multinazionali assetate di profitto) è quello di far suonare i suoi album, anche se fa male dover constatare che “To All Trains“, sesto Lp degli Shellac, è e resterà l’ultimo con materiale registrato dal (e col) suo factotum ancora in vita.
Assemblato dopo una genesi che ha richiesto un lustro, e registrato insieme ai fidati Bob Weston al basso e Todd Trainer alla batteria, con “To All Trains” Albini aveva rimesso discograficamente in pista il trio di Chicago dopo un silenzio durato dieci anni (tanti ne erano passati dall’uscita del penultimo lavoro sulla lunga distanza, “Dude incredible“) interrotto solo dalla pubblicazione, nel 2019, della raccolta di John Peel sessions “The end of radio” (mentre mai si era arrestata l’attività live dei nostri, ogni anno presenza fissa e costante al Primavera sound festival in Spagna) regalandoci dieci nuovi brani, dai suoni cristallini e messi a punto in maniera impeccabile, per una godibilissima mezz’ora di consueto indie/post-HC/noise rock di ottima fattura (e, come sempre, precisa e implacabile la sezione ritmica fornita da Weston e Trainer) oggi inevitabilmente ammantati, col senno di poi, di una cappa oscura grondante di tristezza, che fa di questo long playing un testamento sonoro della band e del suo líder máximo.
Dalla muscolare apripista “WSOD” alla martellante “Girl from outside“, dalla punitiva “Chick new wave” (impregnata di Nineties post-hardcore) allo spoken word HenryRollinsiano in “Tattoos“, dalla severa e decadente “Wednesday” alla saltellante “Scrappers“, dall’essenziale e stripped-to-the-bone “Days are dogs” alla elaborata “How I wrote…“, da “Scabby the rat” che sembra quasi un sardonico divertissement à la Mark E. Smith, alla conclusiva “I don’t fear hell” (titolo che, alla luce della morte di Albini, suona beffardamente profetico) in questo album è racchiusa e condensata tutta l’essenza di Steve Albini e del suo dissonante genio che ancora tanto avrebbe potuto darci, se solo un cazzo di infarto non ce lo avesse portato via in età ancora relativamente giovane. Fuck off. Ciao Steve, speriamo che questi treni ti abbiano condotto verso altri mondi in cui potrai istruire le specie aliene su come suonare rock ‘n’ roll abrasivo e come si registrano i dischi senza scendere a compromessi con l’orco capitalista: nel tuo ricordo continueremo ad ascoltare (e scrivere di) musica, e grazie per tutta la straordinaria legacy musicale e filosofica che ci hai lasciato.