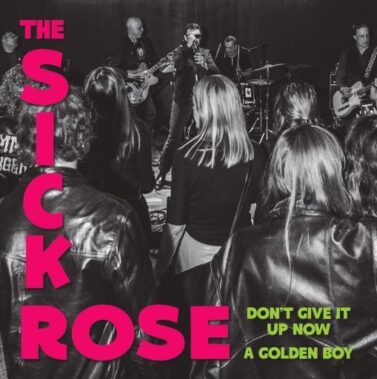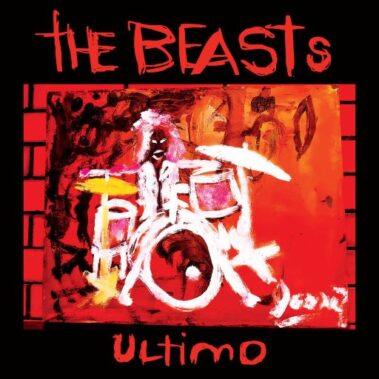Quattro tizi dalle ambigue intenzioni che ti fissano, un decadente contesto di provincia americana, un edificio dall’aspetto sinistro e inquietante, e un titolo, “L’ultima casa” – italianizzato – che farebbe pensare che in quella dimora (come in una sorta di novello Bates Motel) si nasconda roba brutta e insana. E’ questo lo scenario che sembra evocare la copertina di “Last house“, terzo studio album dei garage rockers californiani Th’ Losin Streaks, uscito agli inizi di quest’anno su Slovenly Recordings e arrivato a sei anni di distanza dal precedente “This band will self-destruct in T-minus“.
Ma, invece di Norman Bates, questo “motel” sonoro è gestito-suonato dai quattro tipi succitati: Mike Farrell (chitarra, voce e cori), Tim Foster (voce e chitarra), Stan Tindall (basso e cori) e Brian Machado alla batteria, con gli ultimi tre già reduci da altre esperienze gloriosamente perdenti come quella dei Trouble Makers (e del garage-fuzz-punk-lo-fi di un disco come “The great lost Trouble Makers album“) e sulle scene da ben tre decenni. E da un jukebox sgarrupato potranno farvi ascoltare (in cambio del vostro sangue, chiaramente) i quindici brani contenuti in “Last house“, un long playing che si muove sulle coordinate di un garage rock/freakbeat/mod compatto e solido – devoto a Who, Kinks, Monks, Graham Day, Billy Childish, Fleshtones, Fuzztones – che non disdegna contaminazioni surf rock (come nel caso di “Dyer Lane“, a proposito di pescare nel torbido, e nella conclusiva “Mangalore“).
Registrato in California insieme a Tim Green, il disco del combo di Sacramento è ispirato al folk rock, a Link Wray (la cui influenza sembra evidente nello strumentale “The slink“) Sonics, Downliners Sect, Stones, bassi EKO, organi Vox Super Continental, chitarre Silvertone Supro, armoniche Hohner Marine Band, e a livello lirico ha preso spunto dagli eventi della vita a livello personale (amore, decisioni sbagliate, delusioni di ogni tipo, separazioni, crisi, invecchiare e lo scorrere del tempo) e da ciò che accade a livello globale (l’assurdità dei politicanti, l’atrocità delle guerre, scenari distopici apocalittici) e tra assalti R’N’R all’arma bianca (l’iniziale “I mean you“, “Me’n’ Z“, “Like to be your man“, “Shiver and shake“, “Cake and ice cream too“, “Rue de Montreuil” ) title track in cui il ritmo si fa più cadenzato e con un mood vocale cazzone/caciarone che può rimandare ad alcune cose dei Kiss dei Seventies (“Last house on the block“) garage fuzz in piena regola (“Secret love“) o caratterizzati da una parte finale a tinte lugubri da horror movie (“Cooler heads“) frat rock (“Well I never“) e ballad per cuori di panna da cantare ai falò estivi in spiaggia (“For a while“) i nostri trovano anche modo e spazio per incidere un omaggio al mai abbastanza celebrato Fred Cole e ai suoi Weeds/Lollipop Shoppe, dei quali hanno reinterpretato il ruspante Sixties garage rock di “It’s your time“.
Meglio centomila persone a un concerto degli AssiDissì nelle arene o cento persone a un live set dei Losin Streaks in un localaccio scalcagnato? Per dirla con Mark Arm: più grande è la massa, minore è il quoziente di intelligenza (e competenza) e quindi la risposta va da sé. Se volete ancora sostenere la musica e il rock ‘n’ roll indipendenti/underground, siete capitati sul disco di una delle band che fa al caso vostro, per tutti gli altri c’è Norman Bates che (giustamente) vi ammazza direttamente alla reception se gli dite che ascoltate Diggèi Ringo e il corporate ruoooock di Virgin radio.