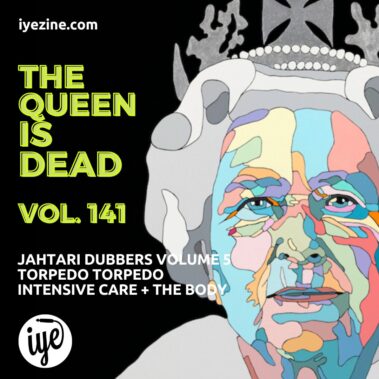Se dovessi esprimere un giudizio sulla riuscita del Primavera Sound 2014 basandomi sul suo inizio e sulla sua fine, potrei tranquillamente attestarmi sulla parola “disastroso”.
Disastrosa e infelice è infatti la scelta di far esibire nel pre-festival del mercoledì i Brian Jonestown Massacre nell’angusta Sala Apolo, piuttosto che nello scenario dell’Arc de Triomf come nella precedente edizione.
Il risultato è che solo pochi fortunati riescono ad essere selezionati al termine di una fila chilometrica, peraltro sotto l’incipiente arrivo di una perturbazione che scaricherà tutta la sua violenza nel pomeriggio successivo, facendo entrare nel panico organizzazione e pubblico e deliziando i venditori ambulanti di ponchos anti pioggia.
Pioggia che comunque sarebbe stata più piacevole della prima esibizione di Sky Ferreira, che in pessime condizioni psicofisiche mi fa preferire l’area ristoro al suo live vuoto e impalpabile.
Il finale di festival invece è un po’meno tragico ma altrettanto fastidioso: sempre all’Apolo il duo canadese Chromeo si produce in un electro funk cafone che cerca di fare il verso ai primi lavori della Ed Banger infarcendoli di un repertorio di trashate manieristiche inconcepibili tra cui spiccano, su tutti, selfie con le ragazzine in prima fila, faccine sexy da calciatore di serie B in vacanza sotto grandi Wayfarer, e braccia perennemente alzate con annesso gesto di corna/rock ‘n’ roll. Rock ‘n’ roll che, fortunatamente, si vede bene dal passare per le vicinanze dei Chromeo.
Tolti questi spiacevoli episodi ai margini temporali del festival, la tre giorni barcellonese nel salotto buono del Parc del Fórum ha invece mostrato sempre di più le meraviglie di cui pochi festival al mondo sono capaci. File praticamente inesistenti, nonostante il record di 190 mila persone e 350 concerti, una nuova disposizione di palchi che fa camminare un po’ di più ma permette una maggiore fruizione degli spazi per le esibizioni e delle contigue zone ristoro.
GIOVEDI 29 MAGGIO
Si parte con i Pond: gli psichedelici australiani convincono a pieno nella loro caleidoscopica esibizione pomeridiana, tra vortici di chitarre e bizzarre incursioni pop.
E’ presto l’ora di dirigersi verso i due palchi grandissimi, l’Heineken e Sony, che uno di fronte all’altro si sfideranno, alternandosi temporalmente, nell’ospitare i grandi nomi.
Nel Sony si inizia con St. Vincent: Annie Clark è perfetta, nel suo mirabile sfoggio di assoli, voce melancolica, movenze robotiche. Forse troppo perfetta, però, troppo fredda e più concentrata verso sé stessa che prodiga di lasciarsi andare verso il pubblico.
La palla passa ai Queens of the Stone Age, che ormai sono headliner ovunque, e Josh Homme pare stia più a suo agio nei main stage che nel divano di casa sua. Dalla fulminante partenza con You Think I Ain’t Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire e No One Knows, fino a A Song For the Dead, passando per le impeccabili esecuzioni della nuova If I Had a Tail e I Sat by the Ocean, i bad boys americani sbancano il palco Heineken con un set monolitico e sempre incalzante, senza nessuna sbavatura.
Il palco lasciato da Annie Clark è ora pronto per gli Arcade Fire, sui quali c’è ormai ben poco da aggiungere. Forse la band più acclamata e rappresentativa degli ultimi dieci anni, ormai uno show da stadio magniloquente e stroboscopico, che certamente ha perso in introspezione ma ha guadagnato in grandiosità. Scaletta incentrata sui brani di “Reflektor”, ma che attinge molto al passato più remoto, addirittura producendosi in tutte e tre le Neighborhood. Devo essere sincero: più ammiro del vivo Butler e soci, più mi duole constatare quanto il pathos e la drammaticità degli esordi vengano soffocati da facce di cartapesta, confetti, soluzioni carnevalesche e di grande impatto, da viral marketing, che inevitabilmente relegano in secondo piano quello che mi ha sempre entusiasmato, la loro essenza più “hippie”, da collettivo orchestrale e agreste.
Il contrasto appare ancora più forte quando dopo i tre precedenti bagni di folla raggiungo il palco Vice per i Touché Amoré. Un’esplosione di hardcore, postcore e screamo accecanti e viscerali, permeate di trame vocali adolescenziali, graffianti, che di tanto in tanto lasciano spazio a parti più intime e dinamiche.
Il giorno dopo ho accennato al cantante che hanno vinto loro, nella mia classifica del primo giorno di festival, ma nella sua sorridente educazione si è accigliato in un’espressione come “si vabbè, mi stai prendendo per i fondelli”. Invece era esattamente quello che ho sentito. I gruppi del genere ti stanno più vicino, ti parlano, nella loro non perfezione. E c’è qualcosa di molto più poetico in questo, rispetto ad un’esibizione “da stadio”. Li immagini in un garage in un sobborgo di qualche città sperduta, e poi finalmente in un palco dall’altra parte del mondo, buttando fuori sudore e passione ad ogni nota. E te li ricordi per un pezzo, più dei grandi nomi.
VENERDI 30 MAGGIO
Gli Slowdive sono tutto tranne che una band riformata per raccattare due spiccioli. E’ il perfetto inizio di serata, in cui capisci che la somma delle parti vale mille volte di più dei singoli contributi strumentali. Chitarre monocorde che si abbeverano dalla stessa fonte dei My Bloody Valentine e dei Ride, e il cui collante perfetto è la pacificante familiarità della voce di Rachel Goswell, tra minimali sezioni ritmiche e feedback sfibranti. E finale da brividi con When the Sun Hits, She Calls e la cover Barrettiana Golden Hair.
Anche i War on Drugs convincono, con le dovute proporzioni rispetto agli Slowdive, nel loro synth pop rarefatto, intriso di riverberi e denso di melodie di Springsteeniana memoria.
Sullo stesso palco, poco dopo, arrivano i Deafheaven. E’ il loro momento d’oro, la presa di coscienza che l’album “Sunbather” abbia definitivamente trasceso i confini tra il Black Metal e le metriche più accessibili del post rock. Si parte proprio da qui, dai tre brani iniziali, Dream House – Irresistible – Sunbather, passando dalle urla strazianti di George Clarke, affogate negli strumenti, fino ai momenti più intimi di arpeggi acustici, tra escalation apocalittiche ed echi di chitarre shoegaze. Sotto il palco pare che domini un sentimento unico, condiviso. Il muro di suono assordante prodotto dal quartetto californiano si traduce in un rombo primordiale, e ancora più eterea ed impalpabile è la gestualità estrema del leader della band all’interno di una atmosfera totalizzante. Uno che sembra possa morire, urlandoti quelle cose, senza che gli importi più di tanto.
La difficile ripresa da un live di tale portata è affidata a Chk Chk Chk, Factory Floor e Laurent Garnier.
Si passa dal dance punk dei primi, come al solito delle macchine da live, all’ipnotico trio londinese di stanza DFA, che convince tra battute secche in 4/4 e loop soffocati, per finire in bellezza con un inaspettato Laurent Garnier, che davo già per sepolto ed invece seppellisce me e tutto il pubblico rileggendo con un dj set pazzesco la storia dell’elettronica degli ultimi vent’anni, a cavallo tra breakbeat, electro alla Modeselektor e splendide incursioni nell’ elettrofunk.
SABATO 31 MAGGIO
Il pomeriggio inizia con una delusione, per una prova purtroppo sconcertante dei Television. Cerco di nascondermi la verità per un buon quarto d’ora, additando la pessima riuscita del concerto a fonici, palco grande, pozzanghere, e altre amenità varie. La verità è una sola: i Television non ci sono più, e quello a cui ho assistito è stata una farsa. Avrei preferito ricordarli diversamente, avrei preferito non esserci.
E allo stesso modo mi aspettavo tanto, tanto di più dai Volcano Choir di Justin Vernon e soci, che suonano anche bene, ma non riescono a commuovere come invece hanno fatto nel meraviglioso disco d’esordio.
Scappo quindi ad ammirare quello che per me è l’evento principale del festival, e non ne resto affatto deluso. I Godspeed You! Black Emperor hanno iniziato la loro lunga maratona barcellonese.
Ho letto da poco una simpatica definizione di post-rock: “suonare accordi semplicissimi in maniera lentissima”. Avrei voluto aggiungere anche “il miglior modo di godersi la pioggia quando invece ci si aspettava il sole”. Qui non piove più, ma è come se lo facesse: cinque canzoni cinque in due ore di spettacolo: pretenzioso e stucchevole, per qualsiasi altro gruppo al mondo. Non per i sette canadesi. Arpeggi, rumori, un set rarefatto che perfeziona dinamiche cameristiche. Ascendenze progressive minacciose, che prefigurano, nei visuals retrostanti, lande desolate, in un apocalittico futuro post bellico oltre l’uomo. Ripetitività armoniche che non scoppiano mai completamente, al contrario di illustri colleghi come Mogwai e Explosions in the Sky. Nessuno sfogo emotivo, ma sospiri e dettagli nascosti e continui rimandi che lasciano l’ascoltatore esterrefatto, immobile. Viene anche difficile applaudire alla fine dei brani. Si rimane intontiti, spaesati. Questo sono i Godspeed You Black Emperor al Primavera Sound, semplicemente il miglior concerto del festival.
E’ l’ora dei miei amatissimi Nine Inch Nails, che rivedo dopo quindici anni dal tour di “The Fragile”. Trent Reznor ha messo su quindici chili buoni, ma dimostra ancora un impatto da fuoriclasse, e in una lunga scaletta che ripercorre venticinque anni di carriera senza un attimo di respiro, tra momenti più riflessivi e pacati dei lavori più recenti e le incalzanti The Great Destroyer e Head Like a Hole. Finale scontato quanto commovente con Hurt cantato all’unisono col pubblico e la sensazione, ancora una volta, di avere assistito a qualcosa di grande.
La conclusione del festival è affidata ai Foals, che suonano pochissimo ma con la consueta intensità: Prelude, Total Life Forever e My Number deliziano il pubblico in un crescendo di sinth e chitarre, Providence e Spanish Sahara allentano il tiro nella parte centrale, e nel finale Yannis si produce in un lungo crowdsurfing su Two Steps Twice chiudendo stupendamente il festival.
L’ultima chicca, la ciliegina sulla torta del festival, la regala la coda domenicale dei Cloud Nothings alla Sala Apolo (si, poco prima dei sopracitati Chromeo).
Da alcuni spezzoni di live ascoltati in rete, avevo l’idea che la band dell’Ohio suonasse un po’ leggera rispetto al disco, avesse insomma meno impatto del lavoro in studio. Mi sbagliavo di grosso: il concerto si trasforma ben presto in un evento, mi pare di rivivere per la prima volta i fasti dei Green Day di Kerplunk e Dookie. Costruzioni semplici e riff da college rock si scontrano con giri di batteria hardcore punk, mentre Dylan Baldi canta di amori persi, opportunità da cogliere al volo, di teenager che sognano chiusi nella propria stanza. Ogni canzone è un racconto, la storia di quelli che urlano sotto il palco. I Cloud Nothings diventeranno un gruppo grandissimo, non può essere diversamente.
E’ il regalo più bello, il congedo da un Primavera Sound sempre più maturo, sempre più vario, sempre più adulto, anche se confezionato in un bel pacchetto fighetto e modaiolo che fa tanto hype ma a cui, a chi ama le transenne, importa ben poco.