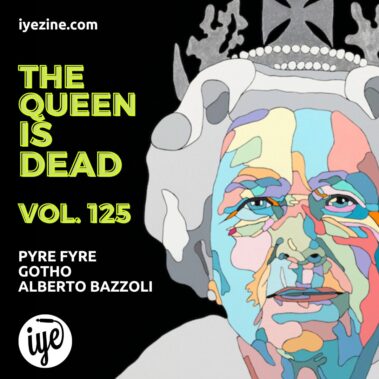Il Live Music Club di Trezzo sull’Adda ha ospitato in data 4 settembre 2016, lo zoccolo duro dell’espressione alternativa femminile di fine Ottanta assieme alle “cugine” Babes in Toyland e Gits: le L7, realtà ricostituitasi un paio d’anni fa nel team che tutti quanti ricordano (Suzanne Gardner e Donita Sparks a percuotere le chitarre, più Jennifer Finch e Demetra Plakas in sezione ritmica).
Il locale fu rinnovato nel 2007, per questo motivo potremmo supporre un allargamento dello spazio vitale e musicale. Tant’è vero che, tra i vari show annunciati nei posters affissi per il pittoresco vialetto d’accesso al blu neon, balzava all’occhio una serata intitolata Zarro Night con, hear ye, hear ye, schiuma e limoni duri, per seguire un’etica alla “non facciamoci mancar nulla”. Ah, e la prossima data per nientepopodimeno che i Killing Joke (13 novembre).
Affluenza regolare, in progressione come al solito; s’è deciso di rompere il ghiaccio con gli Acid Muffin, che non avevo mai sentito prima e che hanno all’attivo un (quasi) LP di prossima uscita e una bella e pestata cover di War Pigs. Tutto molto bello, se volete tanto bene a Eddie Vedder, ma assicuratevi che, dopo aver udito echi di Creed qua e là nel cantato emotivo e molto postgrunge, lui sia ancora disposto a contraccambiarvi. Pezzi suonati sentitamente, Marco Pasqualucci oltre ad essere in bolla con la voce è un manico e il batterista Andrea Latini m’ha ricordato molto il primitivismo di Scott Asheton nel modo di picchiare animalesco mescolato alla bestialità di Dale Crover, eppure non sono riuscito ad avvertire questo power trio indigesto come la loro ragione sociale farebbe supporre. Digressivo sicuramente, seppur non nel versante lisergico: due o tre pezzi, fra cui quello con cui si sono presentati (che è decollato a dovere), erano effettivamente troppo lunghi, un po’ debordanti. Volo il selfie finale col pubblico per evitarmi accuse di populismo, intellettualismo, fascismo, eccetera.
Discorso un po’ diverso sono i White Miles, duo forse tirolese, forse del Madagascar, che in questa occasione s’è difeso strenuamente ed anzi, con la sua proposta di White Stripes imberbi, Big Business e Runaways, sì che mi sono sentito calato nei locali putrescenti dello stato di Washington dei primi ’90. Conoscono Courtney Love, dicono di fare stoner blues e io ci credo: attacchi monolitici, potenti, stop secchi ed imprevisti e voce femminile ruvida, poco indulgente sulla melodicità nell’esprimersi, in degno matrimonio (!) con la propria chitarra, monocorde e arroventata. Bella scoperta, anche perché la cantante Medina Rekic s’è dimostrata a proprio agio e a briglia sciolta sul palco, vuoi per esorcizzar la timidezza, vuoi perché c’ha l’argento vivo. Grande batterista Hansjorg Loferer, questa volta più pendente sul versante Crover con l’attitudine di un Keith Moon meno leggiadro e più brutale, se mi si passa il paragone. Il mio consiglio è di assaporarseli dal vivo, rendono il doppio che su disco.
Arriviamo quindi alle regine della festa, puntuali sul palco con quella manciata di minuti d’attesa per pompare quanto basta e quindi pronte al massacro con la marcia femminista di Deathwish. La Sparks, la Finch (non posso non citare il suo basso col Crimson Ghost) e la Plakas si sono dimostrate nient’altro che potenti, tre cinquantenni che prendevano idealmente a testate chiunque avesse osato definirle “anziane” con un’ora e venti di headbanging e salti invasati per tutto il palco, che, in tasca al Music Club, ha fornito loro tutto lo spazio d’espressione di cui han sempre voluto disporre. Ciò che ha focalizzato la mia attenzione in diversi momenti è stata la Gardner, l’artefice delle canzoni più minimali e brade, con meno compromessi: una sorta di Greg Ginn al femminile, esagitata e stolida, come una caffettiera in ribollio, che torturava e massacrava l’aria coi mattoni volanti dei suoi riff che ben s’impastavano ai giri noise inquadrati e più ricchi di glissando della Sparks. Scaletta ricca di oldies but gold (Shove, Shitlist, Everglades, Crackpot Baby, la sopracitata Deathwish, l’encore finale con Pretend We’re Dead) tutti suonati come potevano fare quando Brett Gurewitz le mise sotto contratto. La maniacale distorsione delle chitarre saturava la stanza nel migliore dei modi; il palpitare tonante del basso come un incedere di stivali militari propelleva i tamburi a passo di carica scuola Budgie, tutto quanto infiocchettato da un tris di voci che ha conservato la forza espressiva dei bassifondi californiani. Nonostante l’età e le vite “settate” le L7 riescono ancora a farsi prendere sul serio, forse in virtù della lungimiranza dei loro testi, soprattutto del loro cavallo di battaglia Pretend, che se all’inizio poteva suonare come un biglietto da visita, ora ha il sapore della reiterazione. Le donne salveranno la musica, non sono il primo a dirlo e non sarò l’ultimo.