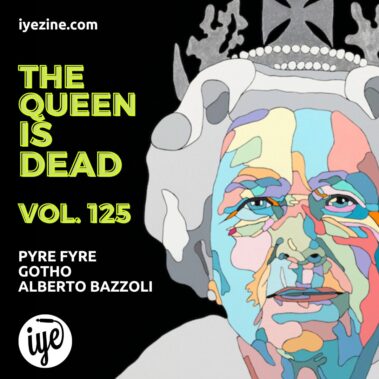All’indomani della legge 180, nel 1979, Franco Basaglia tiene quattordici conferenze in Brasile che verranno raccolte e pubblicate nel volume Conferenze brasiliane, un’opera che oggi, per celebrare i quarant’anni della cosiddetta “legge Basaglia”, Cortina sceglie di pubblicare in una nuova edizione che rappresenta un’occasione per fare il punto sulle contraddizioni che caratterizzano ancora oggi l’assistenza psichiatrica.
Le conferenze di Basaglia trovano nel Brasile terreno fertile perché in quegli anni diventa teatro di grandi lotte per la democrazia, tra le quali trova spazio un grande movimento per la riforma psichiatrica, sostenuto dallo stesso psichiatra italiano che, meno di un anno prima, ha visitato gli istituti psichiatrici brasiliani e ha raccolto le denunce di numerosi operatori sulle condizioni inumane in cui versavano gli internati di alcuni manicomi.
Franco Basaglia è stato uno psichiatra e neurologo, oltre che professore e militante antifascista durante gli anni della contestazione, già dagli studi impegnato nel tentativo di integrare l’impostazione medica di matrice positivista, tanto affezionata all’osservazione dei sintomi oggettivi della malattia, con quella di stampo fenomenologico-esistenziale, più attenta alla soggettività della stessa.
Ciò che fin da subito appare evidente leggendo Conferenze brasiliane è che l’opera di Basaglia, così come tutta la sua vita sono state all’insegna della lotta di classe, una lotta che coinvolge come minimo due classi: una che vuole dominare e l’altra che non vuole lasciarsi dominare. All’interno di un manicomio lo scenario non è molto differente: nella fattispecie la classe dominante è costituita da coloro i quali dispongono dei mezzi per il trattamento dei poveri folli, mentre la classe di coloro che non vogliono lasciarsi dominare è costituita dai folli, e questo è tanto più vero quanto più il folle versa in una condizione di miseria e di repressione.
Se, infatti, chi può sopravvivere economicamente ha anche la possibilità di esprimere la propria sofferenza esistenziale e, dunque, la propria soggettività, accedendo a reali forme di terapia, chi non possiede i mezzi economici può esprimere soltanto la sofferenza della sopravvivenza all’interno di un manicomio.
Da queste considerazioni risulta chiaro come, non solo, uno psichiatra si trovi inevitabilmente in una posizione di privilegio e di potere rispetto al folle, ma anche come quest’ultimo, per poter uscire dalla sua condizione di follia, debba innanzitutto prendere coscienza della propria repressione ed emanciparsi dalla condizione di miseria, che rende impossibile scoprire la follia.
Altro importante ruolo sembra esser giocato dalla società, poiché nella maggioranza dei casi il folle viene rinchiuso nell’istituzione manicomiale proprio per rispondere al desiderio di libertà della società e non alle necessità del folle. Una volta entrato in manicomio il folle cessa di esser tale e diventa un ammalato ed ecco che qualcosa di assolutamente irrazionale viene improvvisamente trasformato in razionale, controllabile, innocuo per la collettività.
Lo psichiatra italiano spiega, quindi, che il reinserimento nella comunità da parte del folle, per poter essere efficace, dovrebbe esser preceduto da una presa di coscienza da parte della società della malattia mentale come manifestazione della miseria, spesso causata dalla miseria stessa e di cui il manicomio è espressione.
“Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece questa società accetta la follia come parte della ragione, e quindi la fa diventare ragione attraverso una scienza che si incarica di eliminarla. […] Il problema è come disfare questo nodo, come andare al di là della “follia istituzionale” e riconoscere la follia là dove essa ha origine, cioè nella vita.”
A distanza di quarant’anni, sebbene la legge 180 abbia sancito la fine dell’istituzione manicomiale e di alcune pratiche disumane, come l’elettroshock, altre ancora, come la contenzione meccanica giustificata dallo “stato di necessità”, sopravvivono. I fattori in gioco sono indubbiamente tanti (disparità territoriali, tagli alla spesa sanitaria e ricorso a massicce terapie farmacologiche, solo per citarne alcuni) e concorrono in modalità e con pesi differenti a complicare il quadro dei pazienti e delle loro famiglie e a risolvere la questione secondo una logica che mira sempre più spesso alla riduzione dell’autonomia del paziente, che viene ancora una volta reso oggetto della malattia.
È per questi motivi che, oggi più che mai, la lettura di Conferenze brasiliane, è necessaria per ricordarci che “[…] l’impossibile può diventare possibile. Dieci, quindici, venti anni addietro era impensabile che il manicomio potesse essere distrutto. […] Ma, in tutti i modi, abbiamo dimostrato che si può assistere il folle in altra maniera, e questa testimonianza è fondamentale. Non credo che essere riusciti a condurre una azione come la nostra sia una vittoria definitiva. L’importante è un’altra cosa, è sapere ciò che si può fare. È quello che ho già detto mille volte: noi, nella nostra debolezza, in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere. È il potere che vince sempre; noi possiamo al massimo convincere. Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo, cioè determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare.”