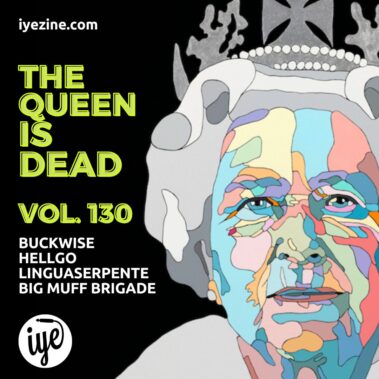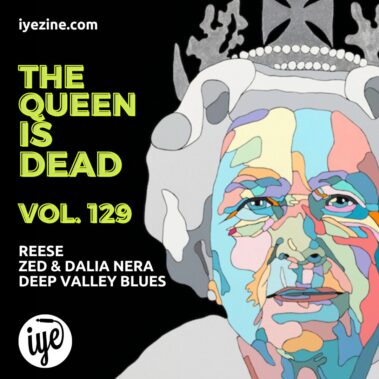Già con gli Institute se ne aveva avuto un sentore: quell’Anarcho-Punk più votato alla creatività, alla commistione e a suoni più secchi e molto meno saturi, rispetto alla sua frangia Crust, stava tornando;
i figli degli Zoundz, dei Subhumans, degli Omega Tribe e dei nostri I Refuse It, stavano mettendo le basi per un nuovo, insperato, ritorno.
Così è accaduto che nel 2020 son spuntati fuori questi Straw Man Army, progetto del Batterista degli Hardcorers Kaleidoscope, con un disco “Age of Exile”, che fece gridare al miracolo:
i suoni secchi, già citati all’inizio, le percussioni minimali, un notevole senso melodico e un cantato perfettamente comprensibile (veicolare il messaggio in una forma immediatamente più vicina anche all’ascoltatore estraneo a certi lidi) ne facevano un disco irresistibile e, nonostante una difficile reperibilità (nel 2021 la londinese La Vida es un Mus ne ha curato la versione europea), finì nelle top list di fine anno di molti.
Se questo nuovo SOS avrà lo stesso risultato e seguito, ancora non saprei dire (mica per altro, siamo a inizio Maggio, nella vita come in musica può ancora succedere di tutto), ma posso già dirvi con certezza che scegliere un ipotetico “migliore” tra questo e il suo predecessore mi risulta già esercizio piuttosto ardimentoso e, no, non è per l’entusiasmo del momento:
SOS non conta sul fattore sorpresa, tipo fulmine a ciel sereno, come Age of Exile, ma suona con tutta l’autorevolezza del disco di spessore e di ottima fattura ed ispirazione.
Un disco che inizia con un sentore di elettronica ambientale e echi Post Rock (la suggestiva intro SOS 1) già fa intuire quanto certe idee, seppure mediate da un in arrangiamento tipicamente Punk Rock, siano in realtà foriere di procedimenti di natura intellettuale e politica mirati all’apertura mentale di chi ascolta:
un procedimento già sentito in vecchi album dei Crass, delle Poison Girls e dei Karma Sutra, ma che qui trova nuova linfa e motivazione;
nei primi due pezzi, Human Kind e State of the Art, si respira già una creatività stimolante, proiettata a capofitto più nell’etica artistica del Punk Rock che nei suoi soliti e immediatamente riconoscibili canoni stilistici: ritmiche minimali ma riconducibili quasi più allo swing che al classico quattro quarti sostenuto, chitarre ai limiti del pulito e vicinissime al post punk.
Anche nella ben più tirate e antemiche “Faces in the Dark” e “Underland” si coglie una tendenza più all’arrangiamento minimale che alla classica furia hardcore fatta di chitarre sature e percussioni serrate; eppure i due pezzi girano di brutto, scuotono ed entusiasmano ma è più voglia di riflessione quello che lasciano che furia e rabbia: quando il pacifismo militante si fa tecnica esecutiva in musica.
La solennità, corredata da un clima ai limiti dell’epico, di un pezzo come Day 49 è l’attimo di pace necessario dopo le due sfuriate di cui sopra: rallentare, raccogliere le forze, riflettere, pianificare, ripartire…la politica, quella vera, lontana da parlamenti, governi e sedi di partito, così si fa: una sincera e motivata militanza, basata sulla costruzione di situazioni e cambiamenti sociali necessari e non sulla ricerca di facili consensi a mezzo di slogan e indici puntati verso nemici immaginari.
Fuggono lo slogan gli Straw Man Army ma parlano, col cuore, ai cuori di chi, in questi due anni, si è sentito solo, abbandonato, soverchiato da un’arroganza imperante e supportata dalla politica istituzionale…e nel fare ciò ci regalano due piccole gemme di punk rock autoriale:
Millenarian Man e Simple Cure son due capitoli struggenti, ai limiti di una Dark Wave risicata all’osso, estratti dalla vita di tutte e tutti noi.
Il synth accennato di Simple Cure non può lasciare indifferenti, per empatia, per sentimento, per amore… un giro di pianoforte, malinconico, trasognato, onirico, introduce un pezzo, Jerusalem Syndrome, ansioso, dove le parole si rincorrono con la musica, forsennata, spietata, generando un senso di urgenza, come se si volesse dire molto in pochissimo tempo:
abbiamo poco tempo per comunicare, esprimerci, tradurre il nostro pensiero in parole, farci capire, completamente assorbiti da orari, scadenze, appuntamenti; questo brano da voce all’incomprensione, all’incomunicabilità…
se, d’altra parte, Age Of Exile era un’acuta riflessione sul colonialismo, uscito in perfetta battuta con la Minneapolis del Black Lives Matter e le statue degli schiavisti lasciate affogare in acqua, SOS si propone proprio come un’indagine sull’essere umano contemporaneo, le sue paure, il suo subconscio:
Jerusalem Syndrom si rivela come uno dei manifesti, nel suo equilibrio continuo tra tesi, ritmo ed esposizione, dell’intero disco.
Il finale del disco è affidato in prima battuta a “Beware” una ballata crepuscolare che si sostiene su di un ostinato di chitarra in palm muting ed un’altra dai fraseggi fragili e accennati; la voce qui si fa rilassata, calma, presa in una narrazione che non è più conflitto ma il suo completo opposto: pace, riflessione, amore.
Sul finale, tuttavia, il pezzo si apre, la voce declama, tutto si schianta per riavvolgersi e tornare sull’inizio…The Right to Be riprende le atmosfere dell’intro SOS I a inizio disco e le sviluppa in una dolce melodia malinconica e strumentale: nel “diritto ad esistere” non c’è argomentazione che tenga, tutti siamo detentori di questo diritto, per nascita e sangue, e nessuno può portarcelo via…che non ci sia un testo a spiegarcelo dimostra come questo concetto si esaurisca, nella sua veridicità, solo nel titolo: un dato acquisito che si giustifica solo nella musica…
l’arte, la forma d’espressione più alta dell’essere umano, è la motivazione che dovrebbe spingerci oltre in ogni attimo che viviamo, lottiamo, perdiamo e ci rialziamo per vivere, lottare e perdere ancora e ancora e ancora, fino a quando, magari un giorno, torneremo ad essere padroni di noi stessi e non più consumatori e consumati, sfruttatori e sfruttati, massacratori e massacrati…