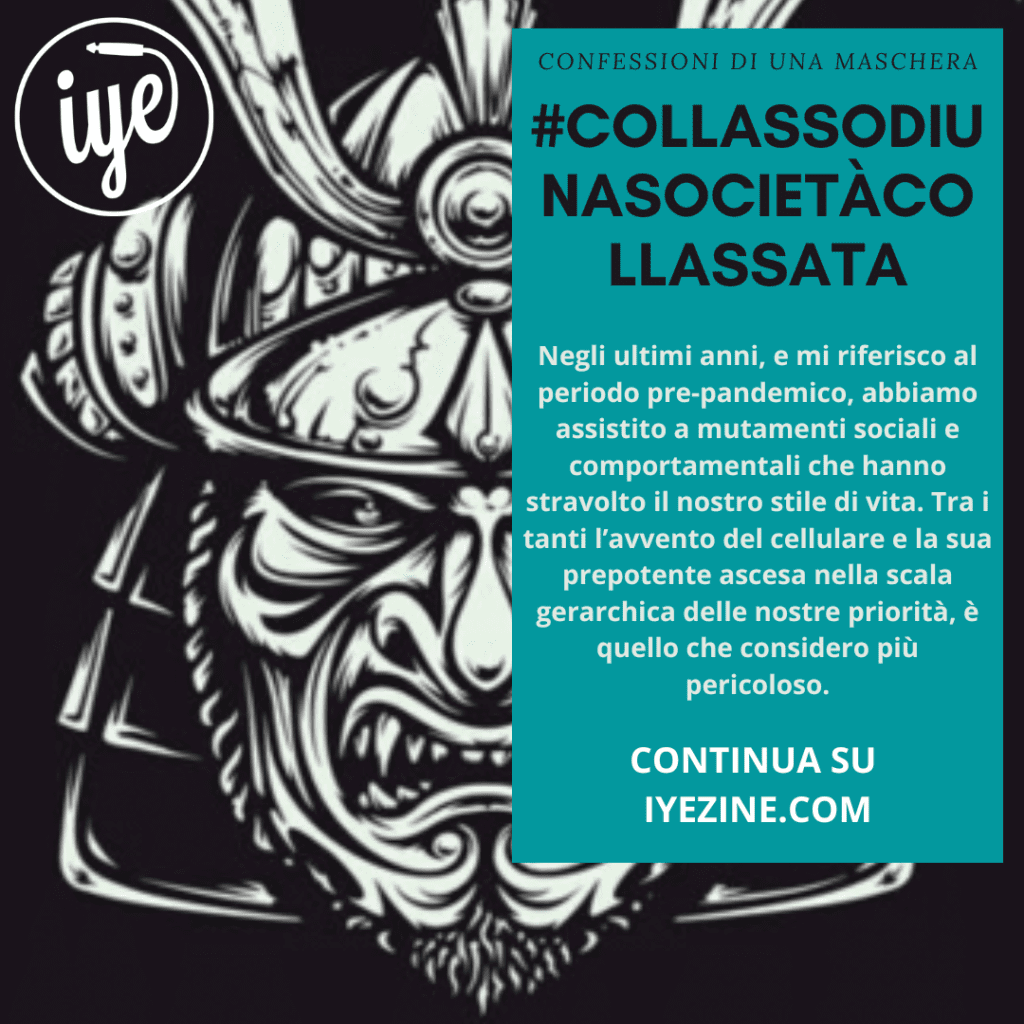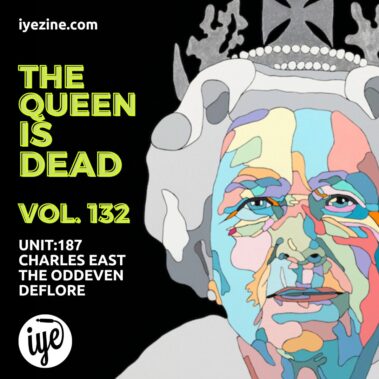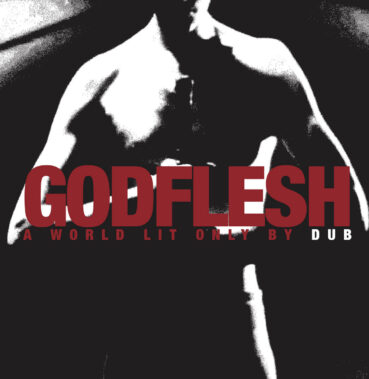Parlo spesso di quelle che sono le dinamiche che più da vicino mi coinvolgono, non perché le reputi più imminenti di analisi rispetto alle altre, ma proprio perché mi trovo nella condizione di doverle affrontare quasi quotidianamente. E sono conseguentemente, per me, quelle da cui mi è più difficile provare a staccarmi. Torno quindi nuovamente a ciò che vivo in ambito sanitario come preponderante, e torno a star male al pensiero di quello che sta accadendo. In realtà l’ambiente ospedaliero è consono alla narrazione giusto per il fatto che è lì che vivo la maggior parte della mia vita, e al tempo stesso resto convinto che si tratti di dinamiche che si possono sovrapporre in qualunque altro ambito, lavorativo e non.
Stiamo assistendo al collasso della sanità, e lo avvertiamo nel momento in cui ci rendiamo conto che è in atto un collasso della sanità mentale come causa principale del fenomeno. Mi spiego meglio. Se la sanità è al collasso non è solo colpa dei tagli trentennali che solo adesso danno i loro frutti, ma anche di un atteggiamento figlio di una incapacità di elaborazione e di razionalizzazione da parte del personale sanitario. In pratica, se tutto va in merda, in fondo la colpa è anche nostra. E non solo perché negli anni non ci siamo opposti alle politiche deliranti di chi ha trasformato le unità sanitarie in aziende sanitarie, facendo quindi diventare il denaro l’elemento cardine intorno a cui strutturare il tutto. Siamo colpevoli perché non ci rendiamo conto che i nostri comportamenti attuali siano da censurare.
È in atto a livello sociale una pericolosa epidemia, che sta facendo e farà ben più danni del covid-19.
C’è un’alienazione collettiva di cui pochi sembrano essersi accorti. Un’alienazione che porta il nome di NOMOFOBIA (letteralmente traducibile con “Sindrome da disconnessione”). Il nomofobico è il nuovo malato inconsapevole dei nostri giorni, e possiamo individuarlo come colui che ha l’insana paura di rimanere sconnesso dal contatto di rete di telefonia mobile, che ricerca in modo compulsivo il contatto esasperato con l’apparecchio tecnologico, indipendentemente dal contesto in cui viene a trovarsi. E, tornando al mio contesto operativo, quello sanitario, il problema è ancor più grave, viste le dinamiche che una patologia del genere può determinare come conseguenze immediate e a lungo termine.
Non si tratta di figure professionali che debbano necessariamente essere reperibili 24h su 24, ma di persone che hanno perso il contatto con la realtà, e che manifestano comportamenti caratterizzati da un uso eccessivo del cellulare in luoghi e situazioni poco pertinenti, in cui si richiederebbe ben altra concentrazione e ben altri comportamenti.
Il nomofobico è alienato, in modo inconsapevole, e compulsivo nel pensiero e nell’azione. Mi rendo conto che per la maggior parte di chi sta leggendo questo possa suonare come un eccesso di fiscalità e che si potrebbe congedare il tutto archiviandolo con un italianissimo “lo facciamo tutti”. Ma non è così. Il primo sintomo di questa che possiamo chiamare “sindrome nomofobica” è proprio la negazione. E al tempo stesso, sottovalutare il problema non ci aiuta a superarlo. La tecnologia si è appropriata delle nostre vite e lo ha fatto in modo subdolo, facendoci credere che fossimo noi ad avere sempre e comunque il controllo della situazione mentre in realtà stava avvenendo il contrario.
Anche gli statunitensi, da sempre attenti, vista la loro sfera sociale degradata, consumista e divisiva, hanno coniato un termine apposito per cercare di inquadrare il problema. E hanno scelto l’acronimo FOMO, cioè Fear Of Missing Out, paura di rimanere esclusi. Negli ultimi anni, e mi riferisco al periodo pre-pandemico, abbiamo assistito a mutamenti sociali e comportamentali che hanno stravolto il nostro stile di vita. Tra i tanti l’avvento del cellulare e la sua prepotente ascesa nella scala gerarchica delle nostre priorità, è quello che considero più pericoloso.
La mia paura nasce e si alimenta nel momento in cui provo a far notare questo atteggiamento a chi mi sta intorno e ricevo soltanto feedback negativi. Manca nella controparte a cui mi rivolto la capacità di razionalizzare la situazione in atto, e ogni tentativo di parlare dell’argomento non porta a nulla. È come scontrarsi contro un muro, resta sempre in piedi. Trovo raccapricciante pensare che ci siano persone che considerano “normale” per non dire legittimo e del tutto giustificato usare il cellulare durante le attività assistenziali in ospedale. Eppure è così. Accade davvero e non si riesce ad arginare il fenomeno.
Vedo persone muoversi come automi, con posture vincolate al rapporto “fisico” con il proprio cellulare, come dentro il celebre “Zombi” di Romero, film illuminante come pochi altri, a cui forse non abbiamo dato sufficiente importanza. Al tempo credevamo che il modello statunitense, quello dei centri commerciali non avrebbe mai sfondato in Italia. Abbiamo visto tutti com’è andata a finire. E anche in questo caso, gli esempi derivanti dalle altrui esperienze non sono serviti a nulla, e nulla ci hanno insegnato. Torno spesso a parlare del mio devastante impatto con la società giapponese nel lontano 2008. Impatto tanto tragico quanto illuminante. Al mio arrivo a Tokyo, appena arrivato in metropolitana restai congelato per quello che mi ritrovai davanti agli occhi. Milioni di persone che nello stesso istante scendevano con me sottoterra (e sono davvero milioni, tenendo conto delle oltre tredici linee della Toei e della popolazione cittadina) in un silenzio incredibile. Tutti con il capo piegato sul cellulare, senza guardare nulla e nessuno intorno. Eravamo in due soltanto a guardare quello che stava accadendo. Tutto il resto dei viaggiatori era assente. Nemmeno in chiesa sono mai riuscito a percepire un silenzio così coeso come quello. Potevo sentire il cuore battermi nel petto.
Sono passati 14 anni e ci siamo allineati anche noi. E, come detto, pericolosamente, perché la nostra affiliazione alienata avviene a tutti i livelli. Compreso quello sanitario in cui occorre un diverso approccio, su tutta la linea. Invece, continuo a vedere esseri umani, o quel che ne resta, catatonicamente schiavi di dispositivi palmari incapaci di razionalizzare le conversazioni in atto, dando la priorità a ciò che accade sul cellulare. La tanto sbandierata “socializzazione” virtuale ha in realtà prodotto un isolamento senza precedenti.
Ho anche pensato, forse per chiamarmi ulteriormente fuori da queste dinamiche, che si tratta di un fenomeno che colpisce maggiormente la fascia che va dai 15 ai 35 e che quindi col tempo si possa auspicare una regressione dello stesso. Ma credo che si tratti solo di un vano tentativo di prenderne le distanze. Quello che più mi spaventa di queste nuove generazioni (sanitarie e non) è la loro propensione a vivere la realtà virtuale come prioritaria e preponderante rispetto al contesto in cui sono collocati fisicamente, a tutto ciò che li circonda. Sono del tutto incapaci di dedicarsi ad una qualsiasi attività scindendo l’uso del cellulare da quello a cui si stanno dedicando. Eppure credo che basterebbe una minima dose di buon senso (soprattutto in ambito sanitario) per capire che ci si trova in luoghi dove l’utilizzo dei dispositivi sarebbe vietato non tanto dalle normative vigenti ma dall’intelligenza.
Abbiamo deragliato, in modo forse definitivo. E il mio tentativo di chiamarmi fuori, che non deve, ripeto, essere visto come “aristocratico”, ma come un grido disperato di allarme, potrebbe essere arrivato troppo tardi.
Altre puntate di Confessioni di una maschera