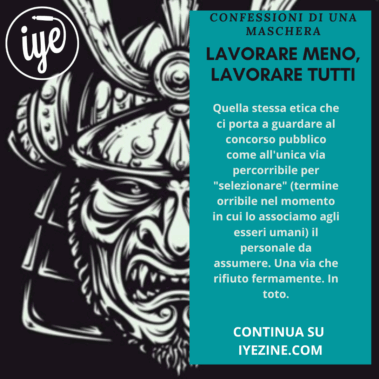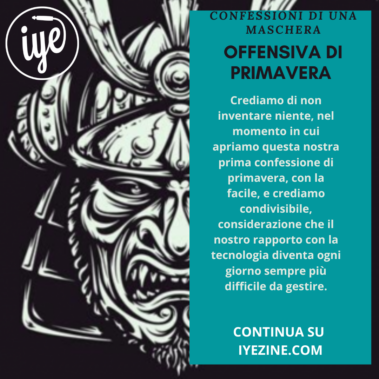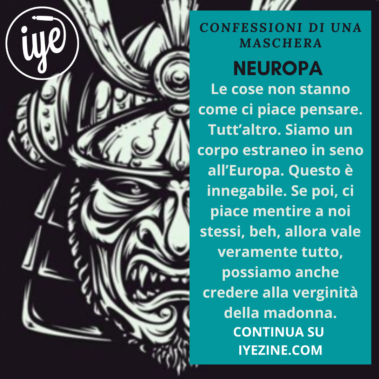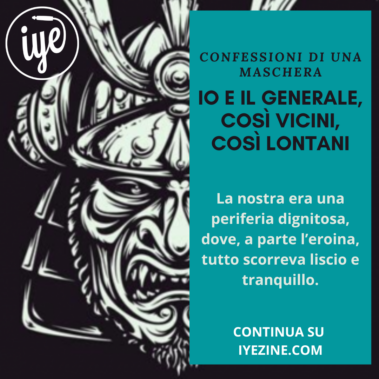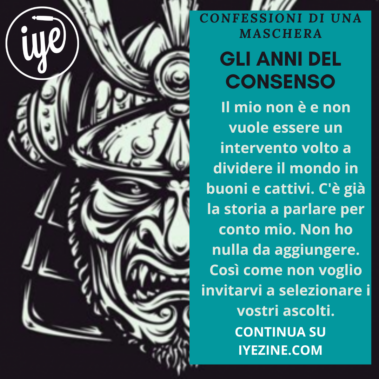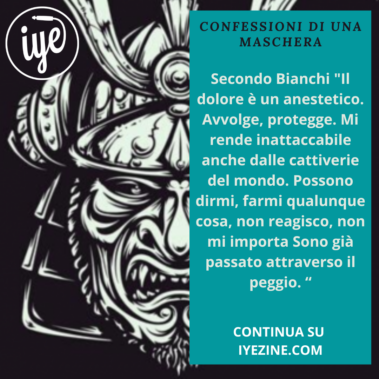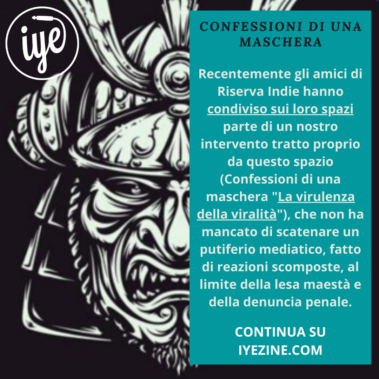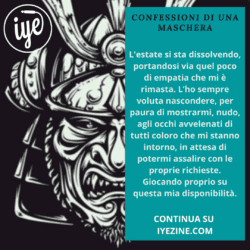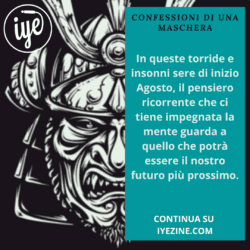Confessioni di una maschera “Donne che odiano le donne”
Un’analisi amara sulle ultime elezioni in Toscana e sul clima d’odio esploso online contro Antonella Bundu. Non conta l’esito politico, ma il degrado culturale e sociale che la rivoluzione digitale ha messo a nudo: razzismo, sessismo, assenza di pensiero critico.