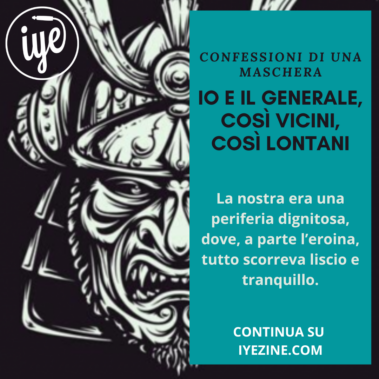::confessioni di una maschera:: “il mediterraneo è un lago, e io voglio vivere sull’altra sponda, quella meno nobile” maggio MMXXIV Penso di essere giunto a un punto di svolta improcrastinabile. Continuare a lavorare in sanità, in italia (scritto volutamente minuscolo), nel duemilaventiquattro, non è più sostenibile. La deriva che abbiamo preso sta mettendoci con le spalle al muro. L’idea che si stia andando verso un sistema prevalentemente privatistico, sulla falsa riga di quello statunitense, è un qualcosa che ritengo impossibile da accettare. Per tutti coloro che ancora non ne se fossero accorti, stiamo viaggiando a vele spiegate verso la privatizzazione della Sanità Pubblica, e, come sempre, è il Nord, quel cazzo di Nord che produce (consuma e crepa), che forte di questa sua aumentata autostima pensa di poter, anzi di dover dare l’indirizzo da seguire al resto del paese, erigendosi a esempio virtuoso. In questa nostra corsa a rotta di collo verso l’ignoto che sta assumendo le forme del peggiore incubo, credo che l’unica possibilità per non andarsi a schiantare sia quella di scendere dal treno indirizzato verso la modernità, e fare il percorso inverso. Lasciar perdere il Nord e la sua folle idea di sanità, e guardare al Sud, all’antitesi per eccellenza, per un ritorno, e una riscoperta delle nostre origini, di tutto quello che c’era prima, e che abbiamo dimenticato in un clic. Se, davvero, voglio restare ancorato a questo mio lavoro che, tra le altre cose è anche l’unico che so fare, non ha più alcun senso restare qui e accettare, più o meno passivamente, sia come singolo, che come categoria, questo ennesimo (e forse decisivo) flirt con un modello di sviluppo che mi ostino a non accettare. Ciò che ci propongono come “il migliore dei mondi possibili” è un appuntamento con la morte (quella interiore) che sento di dover rimandare ancora. Quale l’alternativa? Andare a fare l’unica cosa che so fare, laddove ancora abbia un senso darsi agli altri. Dove si possa parlare di soddisfazione, dove la gratificazione sia tutto tranne che economica, perché, se c’è una cosa che ho sempre avuto ben chiaro, e che non ho mai nascosto (prima di tutto a me stesso), è il grande insegnamento dei miei primi trenta anni in sanità. E cioè che la retribuzione mensile sia, tra le tante, la gratificazione meno ambita. Ma non c’è solo questo. Non posso non essere sdegnato dalla deriva sociale che abbiamo intrapreso. Tutto questo proliferare di dinamiche fintamente “politicamente scorrette”, sottintendono un razzismo sottotraccia che lavora e si insinua a tutti i livelli, sul modello di quel fascismo “per bene, di facciata” di cui parlavo nei mesi scorsi. Ho assistito anche di recente al ripetersi di episodi spiacevoli che hanno evidenziato la tendenza a guardare agli “altri” con disprezzo, in modo subdolo, e quindi per me ancor più inaccettabile, proprio perché fatto senza il coraggio di chi difende le proprie idee. Non ho avuto problemi a denunciare l’accaduto ai vertici del mio presidio sanitario, e non ne avrò in futuro. Per me perseverare con l’idea che la rimozione del politicamente corretto, equivalga a sdoganare qualsiasi tipo di nefandezze è inaccettabile, soprattutto se viene da un medico, come è capitato a me. Per assurdo, alla fine, in frangenti come questo, chi finisce per avere la peggio passando dalla parte del torto, è chi come me denuncia, e urla la propria rabbia. Perché alla fine chi ha torto non è chi discrimina per ragioni etniche, ma chi alza la voce per stroncare questi atteggiamenti. Se io non posso sentirmi libero di gridare il mio schifo in faccia a un razzista, non perdo tempo in discorsi inutili, mi levo dal cazzo. In un mondo che tollera questo tipo di atteggiamento non c’è spazio per me. Continuo a dirlo, e non mi stancherò mai di farlo, il silenzio è complicità. Questi sono atteggiamenti che vanno stroncati sul nascere, sempre, e in modo deciso, senza tolleranza. A qualunque costo. Indipendentemente dalle conseguenze a cui finiremo per andare incontro. La libertà e il rispetto non sono negoziabili, soprattutto se riguardano persone che hanno lasciato il loro paese, hanno attraversato il Mediterraneo, e si sono rivolti a noi sanitari nel momento del bisogno, quando la salute ha per loro incontrato un problema non risolvibile in autonomia. Io non ho paura di lottare per queste persone, così come non ho paura di quello che potrà accadermi nel momento in cui mando in culo un medico razzista che reitera i suoi atteggiamenti discriminatori. Al contrario, ho paura nel momento in cui non agisco in questo modo, nel momento in cui mi accorgo che tutto questo è diventato la quotidianità, che abbiamo smesso di indignarci, nel momento in cui non prendo le parti dei meno fortunati. È qui, quando perdo la voglia di lottare, che rischio di trasformarmi in quello che ho sempre cercato di combattere. Non ho problemi a urlare il mio schifo in faccia a queste persone, e non mi importa la scala gerarchica. La mia etica non è quella del regolamento interno, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, ma quella di tutti coloro che vogliono restare vivi in un mondo di morti che camminano. E qualora questo non (mi) fosse possibile, non ho problemi. Prendo le mie cose, e (me ne) vado laddove posso finalmente tornare a respirare serenità. Non sento la necessità di dover lasciare mosso da compassione verso queste persone. Se vado è perché ho voglia di ridare dignità a chi l’ha persa, di dare concretezza a chi ha messo da parte la speranza, per aiutare a riorganizzare le forze e razionalizzare le risorse. Anche perché abbiamo troppo velocemente scordato che sull’altra sponda del Mediterraneo le risorse abbondano, ma finiscono per essere ostaggio prima e vittime poi di una disorganizzazione che non può non spingere alla fuga. Non è un mistero (per chi ha la faccia tosta di mantenere gli occhi aperti) che laggiù gli operatori sanitari di qualunque livello e competenza, sono costretti ad abbandonare le proprie terre per una carenza strutturale endemica, che castra sul nascere il futuro. C’è un surplus di domanda di lavoro che si scontra con l’impossibilità di assunzione per carenze economiche. In altre parole “ti assumo ma devi lavorare gratis perché non ho i soldi per pagarti.” Ma non prima di aver almeno provato a ricalibrare il quadro delle priorità e dell’etica, riportando al centro dell’attenzione la dignità e il rispetto per le persone, per i loro valori, religiosi e culturali. Proprio per questo sento ancora più forte la mia necessità di andare a cercare la bellezza nelle “distanze” e nelle “diversità”, in quella contaminazione che ritengo alla base di tutto quello che accade su questo disastrato pianeta. Parliamo di persone che si trovano ad affrontare problematiche che sono risibili rispetto a quelle che si sono messe alle spalle, vittime di guerre, carestie, catastrofi naturali, e non ultimo della fame. Una comunità che metta da parte tutto questo nel momento in cui approccia un altro essere umano non è degna di esistere. Non riesco a capire come sia possibile oggi non capire che serve un rinnovamento, un cambiamento culturale che coinvolga ognuno di noi, in modo concreto, definito e standardizzato. È finito il tempo dei ragionamenti di pancia e dell’improvvisazione. È una sfida che però ha una sua non meno importante componente che guarda al lato pratico delle cose, alla concretezza. Un percorso che non potrà essere che lungo e difficoltoso, ma che soprattutto non è più rimandabile. Non so se riusciremo a salvare il Sistema Sanitario Nazionale, ma so che per farlo non possiamo prescindere dall’aumento delle risorse, con conseguente aumento non solo delle retribuzioni, ma anche del numero degli assunti, della possibilità di accedere agli aggiornamenti gratuiti per tutti, e via dicendo. In tutto questo è impensabile che siano ancora i presidenti delle regioni le figure deputate a queste decisioni. Presidenti che non hanno alcuna esperienza sul campo, e che guardano ai bilanci ancor prima che alla salute. Presidenti che sono troppo spesso espressione di una visione partitocratica della cosa pubblica. Si torna sempre al solito vecchio errore che ha messo in moto tutto quanto. Il passaggio da Unità Sanitarie Locali ad Aziende Sanitarie Locali, in onore a sua maestà il denaro. Ne consegue l’ovvietà, e cioè che un Sistema Sanitario Nazionale di stampo privatistico non può prescindere dal guardare agli azionisti e alle loro necessità, ancor prima – o anziché – delle necessità della popolazione malata. Il privato, anziché tendere alla prevenzione per ridurre la spesa, non può che guardare all’aumento delle prestazioni, e conseguentemente del fatturato. I cittadini contano solo se sono malati, in grado di produrre profitto. Per cui possiamo ammalarci ma solo di alcune patologie. Di questo passo, soprattutto se dovessimo davvero andare verso l’autonomia differenziata a livello regionale, le disparità non potranno che aumentare, determinando un’ulteriore forbice nelle condizioni di accesso al diritto alla salute. L’idea di guardare alla sanità come a un “mercato retto dalla libera concorrenza” è folle. La salute non si commercia, questo dovrebbe essere chiaro. Ma a ben guardare, visto quello