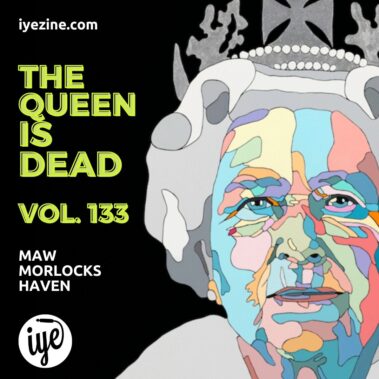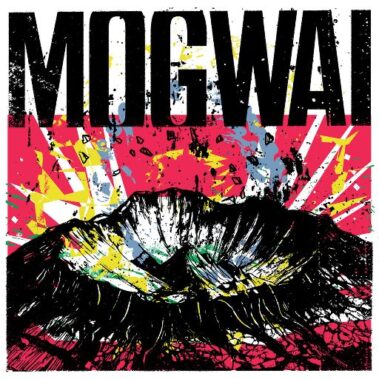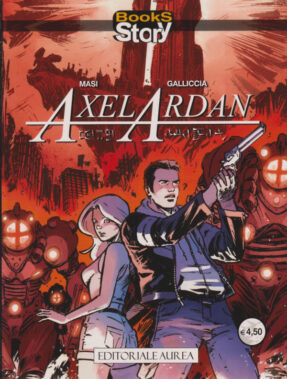Sui social, in TV e sui giornali non si parla d’altro, e la vera notizia è che molto probabilmente la notizia non c’è. Il Blue Whale, sarebbe un insensato gioco online in cui il concorrente deve sostenere prove assurde tra cui quella di suicidarsi. Leggenda (metropolitana) narra che già 130 ragazzi siano morti in Russia pur di non perdere al gioco ed ora in Italia è psicosi perché si temono malsani atti di emulazione. L’ideatore del Blue Whale, Philipp Budeikin, si sarebbe consegnato alle autorità russe ed avrebbe giustificato la sua creazione come uno strumento in grado di selezionare gli “scarti biologici”, ossia gli individui più deboli ed inconsistenti, che avrebbero contaminato la società con le loro fragilità.
Per quanto nel corso dei giorni il Blue Whale sia stato declassato da trend topic a probabile fake news, le parole del suo creatore fanno riflettere e riportano alla mente quando le fragilità che inducevano al gesto estremo, non venivano viste come le debolezze umane di alcuni reietti della società, ma facevano scrivere canzoni accorate e struggenti. Tossicodipendenza, depressione e atti autolesionistici hanno rappresentato, dagli anni 60 in poi, un connubio indissolubile con la musica, soprattutto con quella più triste ed inquieta.
È così che il “male di vivere” ha spinto Chris Cornell ad impiccarsi, lo scorso 18 maggio a Detroit dove si trovava per un concerto con i Soundgarden. Il suo nome è solo l’ultimo di lunga e macabra lista: esattamente 37 anni prima Ian Curtis, frontman dei Joy Division, si uccise nello stesso modo. Il malessere che portò Curtis ad impiccarsi gli permise di scrivere album meravigliosi e tormentati come Closer e Unknown Pleasures (disco inflazionato dal merchandising selvaggio per colpa di una copertina troppo elegante) e di dirci che chi lo avrebbe fatto a pezzi sarebbe stato l’amore. Lo stesso amore che discretamente legava Dalida e Luigi Tenco, belli e malinconici, insieme sul palco di Sanremo a cantare Ciao Amore Ciao la stessa sera che Tenco si sparò un colpo di pistola alla tempia in hotel. Dalida, in un altro hotel, a Parigi, cercò di emularlo un mese dopo ma fu salvata dall’intervento di una cameriera. Ci riprovò vent’anni dopo cenando coi barbiturici nella sua casa di Montmartre. La seconda volta non fallì. Kurt Cobain fu più severo con se stesso e scelse di spararsi in bocca con un fucile a pompa che si era fatto comprare dal cantante degli Earth, suo “amico”; lo trovarono tre giorni dopo nella serra di casa sua, a Seattle, e per identificarlo dovettero prendergli le impronte digitali. Prima di premere il grilletto scrisse una lettera al suo amico immaginario Bodda, in cui diceva «Io sono troppo un bambino incostante, lunatico! Non ho più nessuna emozione ed è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente».
Come può una persona così fragile e coraggiosa da spararsi nel palato, inghiottire una confezione di sonniferi o impiccarsi, essere considerata uno scarto biologico? È possibile che si stia “deromanticizzando” anche una cosa intima come il suicidio e soprattutto l’inquietudine che c’è dietro? Perché i ragazzi preferiscono giocare al Blue Whale (a patto che esista) allo scrivere canzoni strazianti?
Molto probabilmente l’infelicità di una persona che decide di togliersi la vita è dettata anche da motivazioni sociali, come ad esempio la mancata integrazione in una società nevrotica e disattenta, che non riesce ad essere premurosa coi suoi figli più giovani e insofferenti, lasciando che la loro pena diventi noia di vivere. Il suicidio da tempo non è più considerato solo un atto individualistico (Durkeihm lo teorizzò centoventi anni fa) ma realizzare che i fattori sociali che possono spingere al suicidio di massa non fanno più nemmeno scrivere belle canzoni mi rattrista. Forse scarico Blue Whale.