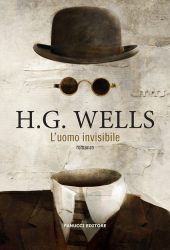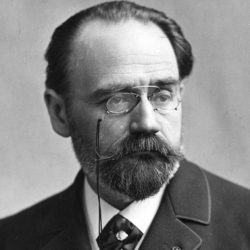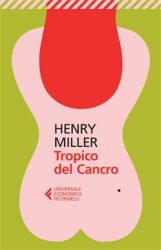“Sala 8” di Mauricio Rosencof, edito da Nova Delphi Nella Sala 8 dell’ospedale militare arrivano i prigionieri ridotti in fin di vita, per essere rimessi in sesto e di nuovo rimandati nella sala delle torture, oppure alla “soluzione finale”: un luogo senza possibilità di futuro, dove il tempo è fermo e il destino già deciso. La voce narrante è quella di un desaparecido che si muove proprio in questo spazio spettrale raccontandoci la terribile condizione delle vittime dell’ultima dittatura militare uruguaiana, private della loro stessa umanità da un regime deciso ad annientare ogni traccia, come se non fossero mai esistite. Potrete leggere passaggi come questi: • Omero aveva immaginato un atto di crudeltà. E lo era. Achille, dopo aver ucciso Ettore, volle trascinare il suo corpo davanti alle mura di Troia dove i suoi genitori, sconsolati, piangevano il valoroso guerriero, sangue del loro sangue. Ma l’ira di Achille, che aveva provocato anche la morte del suo amico Patroclo, ebbe un tempo, un limite. Diciamo un limite etico perché, alla fine, il corpo di Ettore era stato restituito alla famiglia per il rito funebre e l’ultimo addio. Omero non avrebbe mai concepito che Achille, il suo Achille, potesse spingere oltre la sua crudeltà. Per esempio, facendo sparire il cadavere di Ettore, buttandolo giù da un aereo, o cose del genere, con l’intento di far soffrire Priamo ed Ecuba in eterno, alla ricerca dei resti del figlio. No, non poteva immaginarlo, perché anche i guerrieri hanno una morale, un’etica, e una dose di umanità che abbiamo tutti, chi più, chi meno. Dunque, perché cazzo non sto con mia madre? • Possa mia madre riavermi perché io sia, perché sia qualcosa. Che dia riposo a quanto resta di me e che giace su di una barella, accanto ad altri anch’essi adagiati su barelle di ferro, nella stanza in cui raffreddano le birre. Vorrei sentirle dire: “Figlio, figlio mio.” E che le mie ossa le sussurrassero, scricchiolando: “Mamma.” E’ quanto manca per completare il mio essere. Amen. • (…) “compagno” (…) etimologicamente significa “colui con cui si condivide il pane.” • Gli conficcarono un manganello nel culo, fino al manico, dopo una tortura di quelle pesanti, chiedendogli: “Ti è piaciuto, negro? (…) Te lo muovo?” Ma a quel punto squillò la tromba del rancio, e avevamo fame. “Andiamo” disse uno. “Lo lasciamo così?” chiese l’altro. “Tiralo fuori, ne sentirà la mancanza. Dai, presto, si fredda la polenta.” Tolsero il manganello di scatto, si creò un vuoto e insieme al bastone estrassero venti centimetri di intestino. Una fatica staccare le viscere dal manganello ma alla fine ce la fecero. • Da qualche parte mi butteranno, fossa, forno, fondale marino, vattelappesca. “Cercami in giro, mamma. Cercami in giro.” • Era un uomo semplice, grigio, credente. Ma non in una religione qualunque. Faceva parte di una di quelle congregazioni che dispensavano perle di saggezza: “Dio è amore”, “smetti di soffrire”, il che non dipende né da te né da Dio. Dipende dal prossimo. Attenzione. • Conosco molte storie sulla mia vita come pane. Sono stato condiviso, tagliato, sminuzzato, mi hanno messo il nastro da pacchi sugli occhi, tre giri di nastro, mi hanno legato col fil di ferro, quieto, duro, mi hanno dovuto togliere dal bidone perché, a mollo, la mollica diventava poltiglia e si afflosciavano i giri di fil di ferro. (…) Mi hanno spezzato il cantuccio con le tenaglie, mi hanno lasciato senza crosta, mi hanno ridotto in briciole. Poi le hanno spazzate e, di sicuro, le hanno buttate sulla piazza d’armi dove immagino che passerotti e piccioni abbiano fagocitato i miei resti. Quello che è rimasto è andato a finire nella Sala 8. • Non c’è niente di peggio della sete: senti una fitta al petto, hai la gola secca, ti fanno male i reni. Non si salvano neanche le unghie. Mi avevano tenuto senza “acca due o” per pura ripicca, perché una volta non ero riuscito a trattenermi e avevo lasciato andare il fiotto, bagnando (…) il mio materasso. Ma esagerarono. Persi volume, le mie ossa erano diventate friabili come grissini, e non avendo più saliva in bocca non potevo rispondere “sissignore” e, per questo, mi colpivano rompendomi le ossa. • (…) non c’è guardiano che controlli i sogni. • Sul cancello del campo di sterminio di Auschwitz c’è una scritta in ferro battuto: “Il lavoro rende liberi.” Chi ha inventato quel motto? Un filosofo? Un’agenzia di pubblicità? O è una frase per arringare le folle sulle barricate? Chi può dirlo! Ma certo chi l’ha ideato aveva un certo talento. Era un uomo pensante. E un grande figlio di puttana. • Il radio-romanzo suscitava illusioni, creava sogni, accendeva fantasie. Riusciva a consolare. Ti faceva sentire parte di un mondo, ragazzo. Un mondo. È proprio questo che ora ci manca. • I ricordi sono come le fiamme dei cerini. (…) amico mio, non esiste nessun ricordo, nessuna fiamma di cerino che, per quanto resista, non si spenga, sia pur lentamente. Cos’altro aggiungere? Dirigente del Movimento di Liberazione Nazionale uruguayano (movimento Tupamaros), l’autore di questo libro viene fatto prigioniero nel 1972 e, a partire dal settembre 1973, tenuto in isolamento per undici anni, ostaggio della dittatura militare; Rosencof verrà liberato solo dopo tredici anni di prigionia, nel 1985. Marco Sommariva