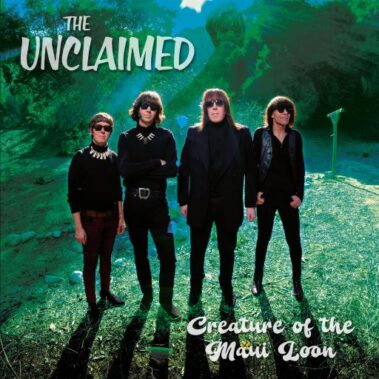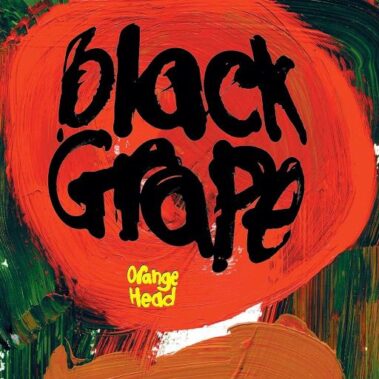Spiazzante. Non pensiamo esista aggettivo più appropriato per descrivere il nuovo album (il secondo del suo percorso da solista) di Kim Gordon. La ex bassista/chitarrista/cantante dei Sonic Youth è infatti tornata a inizio marzo, a cinque anni dall’esordio in proprio, “No home record“, con un nuovo capitolo della sua parabola artistica ormai completamente affrancata dal (glorioso) passato nella Gioventù Sonica, “The collective“, pubblicato su Matador Records. La frontwoman e artista multidisciplinare newyorchese/losangelina rinnova il sodalizio col producer Justin Raisen (già al lavoro anche con John Cale e Yeah Yeah Yeahs, tra gli altri) e da ormai diversi decenni ha iniziato a sperimentare con sonorità ostiche nei suoi progetti discografici solistici e/o paralleli ai SY (Body/Head, Free Kitten, la all-female band Harry Crews, Mirror/Dash, Glitterbust e il side-project/supergruppo Ciccone Youth) alimentando la combustione tra avant-elettronica e noise rock, ma in “The collective” (registrato nella natia Los Angeles) ha deciso di osare ancora di più, spingendosi fino all’azzardo di un crossover musicale-concettuale che ingloba no wave, abstract hip hop, rumorismo noise e contaminazioni trap. Ho scritto “TRAP”? Sì, avete letto bene: trap (ma niente a che vedere con Sfera Ebbasta, Tedua, Shiva altre baracconate all’italiana o all’americana, soprattutto a livello di testi) oltre all’ammissione, nei credits del full length, di aver fatto ricorso all’Intelligenza Artificiale nella composizione delle liriche di alcune canzoni. Un esperimento a metà strada tra i Suicide e il “Whitey album” degli stessi Ciccone Youth? Si potrebbe sintetizzare così la proposta musicale della “nuova” Kim Gordon, ma che alla fine poi tanto nuova non è, perché i flirt tra universo rock ‘n’ roll, arrangiamenti di natura industrial e battiti ritmici ripresi dall’hip hop vanno avanti dalla metà degli Eighties. Ma a rendere “The collective” un disco ugualmente contemporaneo (e, soprattutto, spigoloso) è il fatto che riesca a risultare comunque fresco perché rielabora modelli storicizzati, reinventandoli e attualizzandoli con la trap più radicale per dare vita a un disco non facile e divisivo, ma di cui va apprezzato il coraggio. La stessa Gordon aveva dichiarato, presentando il long playing, di volersi prendere dei rischi pubblicando un’opera che rompesse gli schemi col suo passato, con sonorità dub/trap (seppur trafitte da potenti distorsioni chitarristiche) presenti lungo tutte le undici tracce, condite da liriche che esprimessero l’assoluta follia che viviamo nel quotidiamo intorno a noi, in una società odierna bombardata da un’overdose di fake news (in cui l’etere abbonda di canali di informazione, ma nessuno dice la verità e informa davvero sui fatti e ognuno si costruisce la propria verità personale tra la propaganda politica televisiva e, soprattutto, la giungla dei social network) che intorbidiscono le acque e generano un sentimento tossico di paranoia universale, con la gente che si rifugia nelle droghe (reali, ma anche le dipendenze virtuali: TV shows, shopping, internet e le nuove tecnologie, ben esemplificate dall’immagine di un i-phone che sta per essere “scrollato” in copertina, vero e proprio oggetto-feticcio venerato che ha monopolizzato e cambiato gli usi e le abitudini, molto spesso in peggio, di miliardi di persone, sempre connesse col mondo intero, a condividere le proprie vite tramite un mezzo vuoto e freddo come un cellulare, ma in realtà succubi di una rivoluzione antropologica che ha lobotomizzato, omologandoli, i cervelli delle persone, favorendo l’ascesa dell’individualismo più egoistico a discapito del “collettivo” e delle masse che si organizzano e si associano per lottare per i propri diritti e condizioni di vita più dignitose per il 99% del pianeta che non detiene la ricchezza posseduta dal restante avido 1%) per scappare da una realtà fatta di guerre e conflitti bellici perenni, crisi economiche causate dalle storture del sistema capitalistico, disoccupazione, malattie, distruzione del pianeta Terra (per mano dell’essere umano) e diseguaglianze sociali. In un mondo globalizzato, in cui tutto è brandizzato e a portata di click, Kim sceglie di cambiare le carte in tavola, imboccando dei sentieri e percorsi musicali meno prevedibili e comodi (sarebbe stato facile, per lei, ricreare un surrogato dei Sonic Youth e comporre delle nuove “Bull in the heather” o “Kool Thing“) e si disfa delle etichette sbattendoci in faccia e nei timpani (probabilmente facendo anche storcere il naso ai fans dei SY che si aspettavano determinate sonorità da un’indiscussa icona rock ‘n’ roll come lei) un monolite sintetico dotato di una forza d’urto micidiale, avventurandosi tra battiti trap/hip hop (“The candy house“, “Trophies“) dubstep/chill out (“I don’t miss my mind“, “Shelf warmer“) bordate industrial-noise (“It’s dark inside“, “Psychedelic orgasm“, “Tree house“, “True believers” e la conclusiva “Dream dollar“) e testi anticonvenzionali (come nel caso di “I’m a man” – che descrive il senso di smarrimento metrosexual e lo sgretolamento delle certezze patiti dal “maschio alpha” del terzo millennio in piena crisi di identità – e vede la figlia Coco Gordon Moore protagonista del videoclip, e presente anche in quello di “Bye bye“). Se in Italia il mainstream ci propina ventenni che cantano di cumbie della noia, altrove (e meno male) esiste anche e ancora una Kim Gordon che a settant’anni esce dalla sua “comfort zone” e suona più moderna di tante presunte giovani eroine musicali, rimettendosi in gioco con un disco sperimentale, scomodo, impattante e “avveniristico” come “The collective“, che può piacere o meno, ma indipendentemente dai gusti personali, queste opere rientrano tra quelle che non lasciano subito il segno, e che magari non vengono capite-assorbite-digerite nell’immediato ma, in futuro, potranno/potrebbero essere rivalutate e incensate come “nuovi classici”. Una disturbante discesa agli Inferi che scatta una credibile fotografia alla delirante realtà che ci circonda, fedele ritratto di una società alienata e alienante, un faro sulle contraddizioni di questi tempi moderni (e se l’Intelligenza Artificiale, in un futuro non lontano, sarà in grado di creare musica e fare tutto da sé, sostituendo il lavoro degli esseri umani, poi come la mettiamo?) proponendo, come antidoto, la visione di una società anticapitalista e fondata su un collettivismo femminista che possa distruggere l’Io narcisistico degli algoritmi per rimettere al centro un “Noi” multiculturale e internazionalista, riprendersi le strade e il controllo delle proprie vite, tornare a unirsi e fare casino contro il modello imperante di società schiavista, basato sull’odio e sulla catena di sfruttamento perpetrata dai ricchi/forti a danno dei poveri/deboli, e che ci vorrebbe tutti automi come dei robot senza sentimenti. La creatività non manca a miss Gordon, e si spera che la deflagrante esplosione di questi solchi possa indurre più di una persona a spegnere gli smartphones e ad accendere il cervello e riflettere sul messaggio.