
Silent Carnival – My blurry life
Silent Carnival: il sangue è caldo ed esce lentamente richiamato dal canto di Marco e di Caterina, con uno stile morfinico e bellissimo, che come un liquido ti entra dentro e non ti lascia più.
Il rock, o musica rock, è un genere della popular music sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e sessanta del Novecento.

Silent Carnival: il sangue è caldo ed esce lentamente richiamato dal canto di Marco e di Caterina, con uno stile morfinico e bellissimo, che come un liquido ti entra dentro e non ti lascia più.

Sessantasei minuti di durata. E uno potrebbe chiedersi: “Ma si è messo a fare prog. rock?” Per fortuna no, però è evidentente il dato di fatto che a Ty Segall vada ormai stretto l’appellativo/etichetta “garage rocker”, vista l’evoluzione (o involuzione, dipende dai punti di vista) sonora che, nel corso dell’ultimo decennio, ha portato il menestrello californiano a inglobare, nella sua proposta musicale solista, una gamma di elementi (prevalentemente cantautoriali, folk, psichedelici e acustici) meno ruspanti e rozzi rispetto ai primi anni di attività in cui il nostro sfornava, a getto continuo, album dal piglio scapestrato e lo-fi strettamente imparentato col garage punk. Sarà l’avvicinarsi dei quaranta anni e l’aver “messo la testa a posto” nella sua sfera privata (è da poco diventato genitore insieme alla moglie, collaboratrice/musa artistica Denée) ma il frontman e polistrumentista di Laguna Beach, già da qualche disco a questa parte (almeno nel suo percorso solistico) sembra essersi decisamente calmato, prediligendo sonorità più elaborate e “riflessive” che si scontrano con quanto fatto in passato (fino a un decennio fa) e con gli Lp pubblicati con le band di cui è parte integrante (si pensi solo ai FUZZ o THE C.I.A.). E questa tendenza sonora viene confermata dal nostro anche nell’ultima sua creatura in proprio, “Three Bells“, quindicesimo lavoro sulla lunga distanza uscito, a fine gennaio, su Drag City Records. Coadiuvato dalla Freedom Band e dalla sempre presente Denée Segall (che ha firmato cinque dei quindici brani del long playing) Ty apre le danze coi cinque minuti di “The bell“, che si muove su un dinamico binario acustico/elettrico e gioca sui cambi di tempo e influenze che riecheggiano Neil Young, John Lennon e Big Star. Si prosegue poi con “Void“, singolo dalle reminiscenze Zeppeliniane fritte nella psichedelia fuzzata, mentre in “I hear” si odono chiare ispirazioni Bowie-oriented e “Hi Dee Dee” aggiunge al mosaico anche una componente funk. “My best friend” (uno dei migliori pezzi del lotto) sa di Beatles tornati scazzati dall’India a sfogare le loro migliori energie psych sul “White album” dopo averne avuto abbastanza delle chiacchiere spirituali del Maharishi, “Reflections” scivola via senza sussulti, “Move” vede alla voce Denée in un bizzarro ibrido hard rock/proto-punk. In “Eggman” torna il sound dei quattro Scarafaggi di Liverpool riprocessato e manomesso da una coda finale noise rock, ed echi di “Fab Four” imbastarditi da trame fuzz-rock connotano pure la successiva, Harrisoniana “My room“. Se “Watcher” si districa lungo sentieri heavy rock, e “Repetition” suona come un riempitivo, la lunga “To you” si dipana in maniera interessante su trame elettro(nico)-acustiche e “Wait” sembra resuscitare i late Sixties dei Pink Floyd Barrettiani miscelati coi Pretty Things (periodo “S.F. Sorrow“). “Denée” è un tributo di Segall alla sua consorte: niente di sdolcinato, ma quasi sei minuti di esperimento che sconfina nel math rock/jazz, e la litania psych-folk di “What can we do” chiude il full length. Non che debba essere per forza un male rallentare il passo e maturare, se la musica proposta continua a essere suggestiva e migliorata in qualità (e in questo senso si inserisce anche il suo passaggio in tour, in versione acustica, per alcune date in Italia a fine agosto) e pur ritenendo più che valido – anche se abbastanza prolisso – “Three Bells“, e restando immutati stima e affetto nei suoi confronti, continuiamo a preferire Ty Segall in una veste sonica più essenziale, grezza e senza troppi orpelli. Visti i tempi bui che corrono nel mondo, però, constatiamo che queste “tre campane” almeno non suonano a morto.

Esperienze psichedeliche e beat freak vi aspettano con il nuovo singolo dei Loons, High and Lonesome. Scopri il magico sound del garage rock.

Conosci i Loyal Cheaters: il party rock tra The Runaways e gli Hellacopters ti aspetta in questo disco irresistibile e carico di energia.
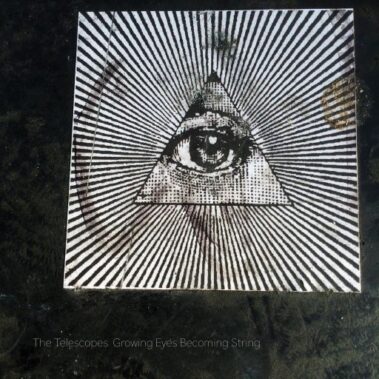
Solo alcuni mesi fa avevamo scritto del momento di prolifica vena artistica dei Telescopes e della loro pubblicazione più recente, l’album “Of Tomorrow“, anticipando il fatto che fosse già in programma un’altra imminente uscita, che infatti si è palesata, il mese scorso, con la comparsa di “Growing eyes becoming string“, sedicesimo lavoro sulla lunga distanza della ormai veterana indie/garage/noise/shoegaze/psych/drone/experimental band inglese capitanata dal frontman e polistrumentista Stephen Lawrie, ad oggi l’unico membro presente in tutte le incarnazioni del progetto. Il disco, pubblicato su Fuzz Club Records, non è un vero e proprio long playing di nuovo materiale, ma si tratta di un “lost record”, un Lp registrato nel 2013 e creduto perduto per quasi un decennio, ma poi ritrovato e ora ritornato ufficialmente in vita. Si tratta(va) di sette brani registrati in due differenti sessioni, tra Germania (ai Cobra Studios di Anton Newcombe a Berlino) e Inghilterra (ai Woodhouse studios di Leeds, sotto la supervisione di Richard Formby) insieme al collettivo experimental music londinese One Unique Signal (ossia James Beal al basso, Dan Davis alla batteria, James Messenger e Nick Keech alle chitarre, Byron Jackson alla chitarra/synth) e completati da Lawrie (voce, chitarra e producer) nel suo home studio nel 2022, dopo averli recuperati e salvati da un hard disk lesionato. E a giudicare dalla bontà del materiale “restaurato”, si può ben dire che sia stata una scelta saggia rimettere mano a queste canzoni ricolme di solido rumorismo e dissonanze (come nel caso del brano “Dead head lights”) otherworldly sounds, sperimentazioni e improvvisazioni, ritmi dilatati, vocals ipnotiche e soffocate, heavy drone rock blow-outs, melodie space e armonie psichedeliche, insomma rispettando il trademark del Telescopes sound di allora e di oggi. “Growing eyes becoming string” è un full length frutto di lunghe jam (all’insegna del “buona la prima”) imbevute di un’anima maudit, cupa, acida e abrasiva. Il consueto trip che trascina l’ascoltatore in un vortice allucinato che riesuma gli spiriti dei Velvet Underground e degli Spacemen 3 (in “Vanishing lines” e “[In the] hidden fields“) aromi Jesus and Mary Chain (“We carry along“) e litanie incessanti in cui i Black Angels si scontrano coi Brian Jonestown Massacre (in “Get out of me“, “What you love” e nella conclusiva “There is no shore“). Mentre la mandria di pecoroni italioti si scanna sulle telenovele mediatiche riguardanti i divorzi di presunti “vip” (confermando di essere un irrecuperabile popolino che si nutre solo di gossip e canzonette: finito il festivàl di Sanscemo, tra non molto inizierà l’altro circo dell’Eurovision song contest, non ce la faremo mai) noi invece rendiamo grazie, ancora una volta, a Stephen Lawrie per i viaggi lisergici in musica che continua a donarci. L’occhio di Shiva veglia sulla nostra dannazione.

La nostalgia, nella musica (ma, in generale, in tutti i settori vitali della cosiddetta società civile) è un sentimento piuttosto pericoloso da sdoganare e cavalcare quando non ha le sembianze di un genuino revival che parte dal basso, ma viene “indotta dall’alto” e fomentata dalle elités borghesi solo per meri fini di guadagno/tornaconto economico, perché significa che non tutti stanno svolgendo bene il proprio lavoro nei vari ambiti di competenza (limitandoci al “comparto musica” a grandi livelli: i media, la logica classista che caratterizza molti concerti e festival, i promoter, tanti locali/club e negozi di dischi/megastore, lo strapotere delle piattaforme streaming di musica digitale, vere e proprie piramidi oligarchiche). Ne avevamo già parlato in un’altra recensione, scrivendo del crescente fastidio, provato da chi vi scrive, nei confronti del business modaiolo adottato dal mainstream discografico che specula sul passatismo musicale per spillare tanti soldi agli appassionati, alle adoranti “fanbase” di determinati gruppi/artisti e ai feticisti del collezionismo compulsivo di album con operazioni commerciali di ristampe costosissime di Lp con diversi decenni sul groppone, soprattutto “classici” (ma anche con iniziative specifiche come il “Record Store Day“, un appuntamento teoricamente importante, ma che col passare degli anni si è trasformato in un evento “cannibalizzato” dalle major del disco, che con la loro egemonia imperialista si sono appropriate anche di questa giornata dedicata alla “salvaguardia dei negozi di dischi indipendenti”, diventata invece un’altra vacca da mungere) che fanno leva sul pretesto di “celebrare” gli anniversari di dischi famosi e/o meno noti (tirati a lucido in lussuosi “super deluxe boxset” e conditi da svariati “bonus extra”, che molto spesso si rivelano essere solo fumo negli occhi e nelle orecchie di chi ascolta) ma in realtà mirano soltanto a rimpinguare i conti in banca delle multinazionali, mosse di marketing pubblicitario che non portano assolutamente nessun contributo a un processo di rivalutazione della cultura. Ahinoi, le logiche ciniche e spietate dei “mercati” capitalisti mercificano ogni aspetto dell’esistenza terrena/terrestre ritenuta capace di generare profitti, e tutto è ridotto a essere liquido e finanziarizzato. E’ sempre più difficile trovare forme alternative di resistenza allo squallore del consumismo tossico. Un tentativo, forse (e paradossalmente, dato che il gruppo in questione non esiste più, formalmente, da 13 anni) potrebbe arrivare dall’esempio fornito dai Sonic Youth, ensemble newyorchese che, dalla sua ufficiale “cessazione delle attività” nel 2011 a oggi, e in particolare dal 2020 in avanti, è stato attivo nel condividere raro materiale della band (e solista) in formato digitale (sulla piattaforma Bandcamp) e fisico: si tratta soprattutto di inediti risalenti agli anni in cui il gruppo era ancora ufficialmente in attività, spesso materiale proveniente da registrazioni di jam pomeridiane, improvvisazioni o prove eseguite durante i soundcheck dei concerti e catturate su nastro. Tutte queste incisioni ritrovate sono state pubblicate sui profili Bandcamp del chitarrista/frontman Thurston Moore, del chitarrista Lee Ranaldo e del batterista Steve Shelley, e in particolare la pagina dell’archivio dei SY (gestita e assemblata da Shelley, che supervisiona foto, video, nastri dei concerti e altra varia memorabilia inviata dai fan e poi processata per essere pubblicata a un prezzo abbordabile) si è via via riempita di numerose raccolte di rarità e, soprattutto, concerti dal vivo tenuti dal combo ormai assurto allo status di leggenda. Il fatto che questo (numeroso) materiale venga reso pubblico su una piattaforma di musica in streaming come Bandcamp (forse la più “democratica” in termini di chiarezza-correttezza nel rapporto tra etichette e gruppi, anche se i recenti passaggi di proprietà potrebbero proiettarla verso il mainstream più becero: auguriamoci che non sia così) che privilegia l’interazione tra fan e gruppi ed è strutturata anche come una comunità virtuale (che non si limita a essere soltanto negozio-vetrina virtuale nella compravendita di musica) potrebbe far passare un messaggio secondo cui l’intento degli ex membri e protagonisti di questa gloriosa epopea non sia quello di monetizzare sul passato, ma cercare di mantenere vivo lo “spirito DIY”, l’approccio orizzontale e non settario, preservare la memoria storica e il lascito artistico, provando a combattere, con altre strategie, la summenzionata mentalità opportunistica da guadagno facile assicurato dallo sfruttamento del sentimento nostalgico dei fan di vecchia data che, in segno di fedeltà, avrebbero acquistato a occhi chiusi i suddetti eventuali box set vinilici in edizione ultalimitata a prezzi improponibili. Alfieri indie/alt-punk/noise rock e pesi massimi dell’universo alternative statunitense e mondiale, i Sonic Youth sono stati e, visti i percorsi solisti intrapresi dai suoi ex membri Moore, Kim Gordon, Ranaldo e Shelley, continuano a essere considerati dei solidi punti di riferimento e paladini del concetto di “comunità rock” che grazie al loro infaticabile attivismo, a cavallo tra Eighties e Nineties, si era allargata fino a diventare una “Daydream nation” controculturale, promuovendo il dialogo tra le varie scene regionali e cittadine degli States, creando una rete di contatti e predicando l’unione tra le diverse anime e sfaccettature dell’indie rock, “patrocinando” nuova musica e contribuendo a portarla alla ribalta (come nel caso della comunità indie di Olympia e la scena di Seattle, tessendo le lodi di Mudhoney e Nirvana e suonando con loro in tour) pubblicizzando band o artisti sconosciuti al “grande pubblico” semplicemente parlandone nelle interviste o indossandone una t-shirt ai concerti; rompendo le barriere della “musica alta” e dello snobismo intellettualoide da galleria d’arte e mischiandole col rock ‘n’ roll stradaiolo, fondendo sperimentazioni colte e improvvisazioni, il punk/hardcore e Andy Warhol, il pop da videoclip su MTV e l’antipop dell’avanguardia interdisciplinare rumorista della No Wave della Grande Mela. Oggi a rivedere la luce in maniera ufficiale è la ristampa di “Walls have hears“, un disco dal vivo che ha alle spalle una storia particolare. Uscito per la prima volta nel 1986 per volere del promoter inglese Paul Smith (amico di Moore e sodali) un discografico innamorato dell’indie rock a stelle e strisce che aveva fondato la label Blast First (di fatto, una sottoetichetta della Mute Records) anche e soprattutto per diffondere i frutti dell’allora microcosmo dell’underground R’N’R proveniente dall’altro lato dell’oceano Atlantico (oltre a pubblicare i primi dischi dei Sonic Youth, contribuì a far conoscere in Europa anche la musica dei Big Black, dei Dinosaur Jr e dei Butthole Surfers tra gli altri) questo live album venne ufficiosamente dato alle stampe attraverso la Not (che era la “official bootlegs label” della Blast First) e fu ricavato mettendo insieme brani registrati da ben tre differenti concerti tenuti dai SY in Inghilterra nei tour tra il 1985 e il 1986. Tutto avvenne all’insaputa della band (essendo, appunto, un “bootleg”, cioè una registrazione non ufficiale e non approvata/autorizzata all’epoca) il che portò a un rapido ritiro delle copie immesse in circolazione, nonostante l’arrivo anche in Italia, nel 1993, di un’altra versione unofficial (sulla label Aulica) intitolata “The Sonic Youth sound experience (Walls have ears)“. Ma oggi, a quasi quaranta anni di distanza, questo Lp dall’aura mitologica è stato “restaurato” dai nastri originari ed è diventato un lavoro ufficiale sotto forma di doppio album. Il disco si apre con”C.B.“, un breve discorso tenuto da Claude Bessy (compianto prime mover della scena punk californiana e cofondatore/editore della punkzine losangelina “Slash magazine“) che metteva in chiaro la posizione del gruppo sulla polemica suscitata con l’etichetta inglese Rough Trade Records a proposito della distribuzione del singolo “Flower/Halloween“, censurata perché aveva una copertina raffigurante l’immagine, in bianco e nero e fotocopiata da una fanzine, di una modella in topless (considerata, dalla label britannica, una forma di sessismo e maschilismo, andando allo scontro con il combo newyorkese che, invece, non la considerava offensiva per il mondo femminile) e questa introduzione dà il via alle prime otto tracce del lotto (con Shelley alla batteria) catturate alla University of London Union. Tra queste, spiccavano “Green Love” (all’epoca non ancora pubblicata e con un titolo provvisorio, che poi trovò spazio sull’album “EVOL” ribattezzata come “Green Light“) “Spahn Ranch Dance” (cioè una versione, sotto mentite spoglie, di “Death Valley ’69“, presente anche col suo vero titolo nell’altra esibizione) il curioso siparietto posto tra la fine di “Kill Yr. Idols” (riproposta nell’altro live e rinominata “Killed and kicked off“) e l’inizio di “I Love her all the time” (udibile soprattutto nell’edizione del 1986) del “rifacimento” riprodotto sul palco da un registratore, a mo’ di distrazione di massa (mentre i nostri accordavano gli strumenti) di “Into the groove” di Madonna (popstar per la quale Moore e compagni nutrivano stima, infatti nel 1988 registrarono, in collaborazione con Mike Watt, J Mascis e Greg Ginn, anche una sorta di giocoso “tributo indie” in omaggio a lei e alla musica da dancefloor “manipolata” in un side project col moniker Ciccone Youth) ribattezzata “Mad Groove“, e “Expressway To Yr. Skull“, uno dei primi brani su cui ha messo mano il nuovo (ai tempi) batterista Shelley, e che rappresentava uno degli spartiacque tra il primo periodo dal 1981 al 1985 – caratterizzato da dissonanze e cacofonico rumorismo figlio della No Wave – e il secondo periodo (quello in cui i nostri cominciarono a far coesistere sperimentazione e irruenza postadolescenziale con melodie e strutture più lineari e “pop” nelle canzoni, una formula che di lì a

Esplora il secondo EP di Merak – Sopho(s)more e lasciati travolgere dalla loro musica new wave e psych grunge. Corrosiva e avvincente!

Erotik Twist: un album affilato come un lama di rasoio in un thriller italiano degli anni settanta, di quelle che colpiscono senza dare scampo alla vittima.
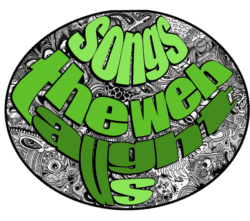
Bentornata, gentaglia di poca fede, nuovo appuntamento (primo di questo nuovo anno) con “Songs The Web Taught Us“. Perdonate la lunga assenza, ma il vostro Reverendo è stato parecchio indaffarato, tra gli ossequi all’immacolato cuore di Mari(juan)a, la consueta gita natalizia a Betlemme per salutare la nascita del Principale con due padri e una madre surrogata (perché noi kattolicy dobbiamo essere contro l’utero in affitto e dare la priorità alla famiglia naturale e tradizionale, come ci ricorda sempre anche Giorgiona la madre kristiana!) e il tour europeo di rosari e sermoni gospel in supporto alla musica del nostro vescovo e le sue suore groupies. Sempre più schifato dalla piega guerrafondaia in cui questo malandato pianetaterra continua a perserverare, eppur bisogna resistere e, finché si può, tenere la barra dritta e far fronte alle avversità con un’infornata di nuova musica da ascoltare, e che il vostro Rev ora vi consiglia per scaldare queste fredde (anzi, mica tanto) giornate d’inverno (speriamo mai nucleare). Cominciamo con l’album d’esordio dei Titane, trio pugliese (composto da “Fish McRave” alla voce e chitarra, Francesco Natilla al basso/chitarra e “Roy Frittata” alla batteria e percussioni) che negli ultimi mesi del 2023 fa ha pubblicato il suo Lp di debutto, intitolato “HYPERSPACE” e uscito sulla label tedesca Clostridium Records. Il terzetto di Bari propone otto brani caratterizzati da un sound ben messo a fuoco, e di pregevole fattura, che oscilla tra componenti stoner/psych e sonorità imbevute di doom corposo e oscuro, il tutto ammantato di un’aura psichedelica psicotropa. Mostri interiori, guerre per la sopravvivenza, sesso, violenza, litanie per dèi pagani e visioni desertiche sono le coordinate da impostare per affrontare questa discesa verso gli inferi più macabri e tetri. HYPERSPACE by titane Continuiamo con la seconda band consigliata, che stavolta proviene dalla Francia e si palesa, fragorosamente, sotto forma di un altro trio, i //LESS, la cui peculiarità risiede nell’essere un gruppo rock ‘n’ roll senza chitarra, ma composto soltanto da una batteria e ben due bassi iperdistorti e carichi di effetti, per una formula ugualmente incendiaria che deflagra in un noise/punk (con echi industrial e attitudine post-HC) torrenziale e urticante. I nostri hanno all’attivo un Ep intitolato “Social disappointment“, distribuito su varie etichette, in cui vengono sparati sei brani in cui riecheggiano, ferocemente, influenze che vanno a pescare in torbide acque sonore che puzzano di Killing Joke, Swans, Helmet, Godflesh, Jesus Lizard e compagnia rumorista. Una putrida palude da cui non uscirete salvi, se vi ci immergerete. SOCIAL DISAPPOINTMENT by //LESS Dalla Francia rientriamo in Italia e atterriamo nella città dalla Torre Pendente, Pisa, dove ad accoglierci troviamo i suoni ruvidi e grezzi di One Man Buzz!, one-man band che omaggia Buzz Osborne dei Melvins nel moniker, ha come musa artistica il blues (è la musica del diavolo, del resto…) e si definisce “nato da una relazione sessuale tra il diavolo e una donna messicana, mezzo umano e mezzo dèmone che conduce una vita dissoluta, fa i conti con le perversioni/contraddizioni della razza umana e con la sua chitarra fa ballare “gringos y chicas”, suscitando risate, disgusto e amore“. Il nostro, già ex frontman dei Bugz, canta on stage indossando una maschera demoniaca (ispirato da Bob Log III e altri funamboli) e suonando chitarra, drum machine e grancasse. Sul finire del 2023 ha rilasciato, dalle fiamme dell’inferno, diversi singoli e un nuovo album, “One man band from hell with love and flames“, completamente autoprodotto, composto da nove pezzi, tra riarrangiamenti di repertorio e nuove composizioni, che si rifanno alla (non) scuola dei “supereroi” monobanda (King Automatic, il nostro vescovo, Dead Elvis and so on…) ma rinforzati da una spolverata sonica di stoner à la Queens Of The Stone Age/Josh Homme (altra passione dichiarata). Si consiglia di accompagnare l’ascolto di questa musica incendiaria (particolarmente in sede live) con una bottiglia di tequila, whisky, rum, vino o, nel peggiore dei casi, una (o due, o tre, o quattro, o cinque…) strong ales! Col freddo e i rigori dell’inverno mi sembra più che appropriato proporre il moniker di un ensemble chiamato SPIRITO DI LUPO, italiano (di stanza tra Milano e Bologna) ma che ha inciso l’album di debutto, “Vedo la tua faccia nei giorni di pioggia” (2023) su etichette estere (prodotto e distribuito dalla Iron Lung Records di Seattle e dalla punk/HC label londinese La Vida Es Un Mus). I nostri, già attivi nel circuito underground (Kobra, Horror Vacui, Cerimonia Secreta, Skalp) avevano già esordito con un Ep (intitolato semplicemente “4 canzoni“) uscito su Sentiero Futuro Autoproduzioni, riprendono sonorità e tematiche cari alla scena anarcho-punk britannica e italiana, trasportando l’aggressività sonica-cacofonica dei Discharge, degli Indigesti e dei Wretched nel nuovo millennio, e fondendola a incursioni analogiche nell’elettronica minimale, il tutto sublimato furiosamente in un cantato a due voci (quella maschile di Francesco Goats, che ha curato anche l’artwork del disco, e quella femminile di Vittoria) che può rimandare ai Contrazione e squarcia l’aria con liriche che urlano di temi ambientalisti e pacifisti cari a Crass e compagnia. Inner peace punk! Vedo La Tua Faccia Nei Giorni Di Pioggia (LUNGS-250) by SPIRITO DI LUPO E chiudiamo questa rassegna immacUlata fermandoci in Puglia, dove troviamo i couchgagzzz, nuovo progetto a tinte budget rock formatosi nel 2021 in uno scantinato di Bari e composto da “JJ” (batteria e voce, già nei Santamuerte) “BB” (basso e voce) “Garko” (chitarra e voce) e “Snafu” (synth e chitarra). Ci fanno sapere che sono fissati con gli steroidi e con gli sport, e “gonfiano” le loro passioni assumendo grosse quantità di rock ‘n’ roll di matrice australiana. Budget rock dopato (appunto) che racconta di vittorie sudate e campioni sconfitti, chitarre nervose che mostrano i muscoli e synth-punk coi denti serrati. L’otto marzo è in arrivo il loro album di debutto, intitolato – tanto per gradire – “Gosports!!!“, che uscirà su Ciqala Records/Side 4 Records e conterrà 8 brani sotto steroidi (registrati a luglio 2023 presso il VDSS Recordings Studio) che corrono elettrici, veloci e taglienti al traguardo, dopo poco più di 20 minuti dall’inizio della gara, e che rappresenteranno la colonna sonora ideale per i vostri allenamenti all’aperto, a casa o in palestra. E ai primi dieci che telefoneranno, regaleranno un mese di abbonamento gratis. Chiamate subito il numero… ehmmm scusate, mi ero lasciato prendere dalla modalità televendita. Nell’attesa, hanno condiviso la title track e, ovviamente, non vediamo l’ora di ascoltare l’intero full length. E intanto cominciate a fare stretching. L’amore per l’underground dà solo buoni frutti. Come sempre, cari fratelli e sorelle, prendete e ascoltatene tutti, spargete il verbo e acquistate anche, se potete. Fuzzamen!

Smalltown Tigers: questa raccolta di canzoni un prodotto molto riuscito ed accattivante.

I Bachi da pietra, a 3 anni circa dall’estroverso e diretto Reset, spianano la strada alla loro visione ultra rock (comunque ultra) col nuovo Accetta e continua.
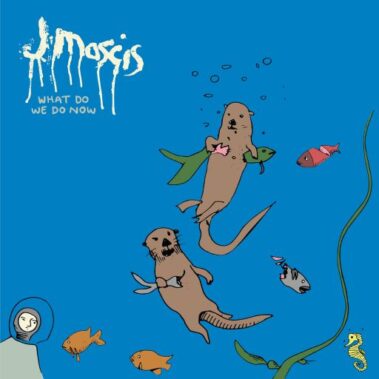
J. Mascis è un porto sicuro in cui rifugiarsi quando si ha bisogno di certezze e si vuole scappare dalla mediocrità generale imperante e dalla musica dimmmerda che ci circonda (soprattutto in questo periodo in cui imperversa ancora l’olezzo maleodorante dell’onda lunga del pre- e post-festivàl di Sanscemo). Che pubblichi materiale come frontman dei Dinosaur Jr. (in veste più elettrica distorta) o come solista (in una dimensione più cantautoriale e intimista) sai sempre cosa aspettarti dal nostro: una formula consolidata che miscela la capacità di far piacere e rendere accattivanti alle nostre orecchie lo stile slacker, litanie miagolanti e gemiti scazzati, cantati con tono apatico e lamentoso (tipico di Neil Young) a un’incredibile abilità chitarristica che, all’interno del panorama dell’alternative rock/indie rock (americano e mondiale) hanno fatto del lungocrinito polistrumentista di Amherst (Massachusetts) una anomalia che, quasi quattro decenni fa, coi Dino, mandò in cortocircuito la scena HC punk statunitense “cooptandola” con un pot-pourri di heavy/hard rock, punk/post-punk e noise pop fatto di incredibili fraseggi e assoli alla chitarra talmente intricati e vorticosi da poterli considerare una sorta di bignami Hendrixiano frullato e sputato fuori alla velocità della luce, il tutto filtrato dal retaggio hardcore, riuscendo a creare un marchio di fabbrica trasversalmente apprezzato e aprendo una strada che contribuì a portare all’esplosione dell’universo del R’N’R underground e della sua irruzione nel mainstream nel fatidico 1991, l’anno in cui punk broke. E così, tra un “Fuck patriarcato” e uno “Stop al genocidio” (slogan più che giusto, peccato però che provenga da chi era, solo qualche anno fa, testimonial italiano degli spot pubblicitari di una nota multinazionale statunitense del fast food/cibo spazzatura che foraggia le politiche di pulizia etnica perpetrate da decenni da un certo Stato invasore ai danni di popoli confinanti a est del Mediterraneo, ma vabbè) per fortuna abbiamo ancora il potere di spegnere la televisione e ignorare il teatrino montato ad arte delle polemiche da social network, e allora torniamo nel mondo reale e accogliamo questo nuovo album solista di J Mascis, “What do we do now“, uscito a inizio febbraio su Sub Pop Records e arrivato a sei anni di distanza da “Elastic Days“. Il disco è stato concepito da J durante il periodo pandemico nel suo Bisquiteen studio, assemblando melodie in acustico e lavorando sulle canzoni con una dinamica differente rispetto alle composizioni create per la band madre (dove deve tenere conto delle parti di basso e batteria da assegnare a Lou Barlow e Murph) concentrandosi soltanto sulla sua sfera artistica personale ed elaborando il materiale prettamente in maniera acustica, anche se in “What do we do now” le chitarre elettriche non mancano e, senza dubbio, questo è forse il suo Lp in proprio (seppur coadiuvato dal pedal steel guitar di Matthew “Doc” Dunn, e al piano/tastiere da Ken Maiuri) che si avvicina maggiormente alle atmosfere dei Dinosaur Jr (soprattutto quelli post-Barlow dei metà Nineties di album come “Where You Been” e “Without a sound“) con parti di batteria stavolta onnipresenti e assoli chitarristici ben assestati. Mixato e masterizzato da due mostri sacri come Greg Calbi e il collaboratore di lunga data John Agnello, il full length è ben messo a fuoco, probabilmente difetta un po’ di prolissità (quasi tutti i pezzi superano i quattro minuti di durata e magari sarebbe stato meglio “asciugarne” la lunghezza) ma la sostanza c’è e si innesta, come detto in precedenza, su una impostazione acustica folk poi arricchita dalle distorsioni elettriche (con liriche che trattano di incomunicabilità, incomprensioni, alienazione dettata dalla fine di una relazione, ma c’è anche spazio per ottimismo, sogni e voglia di amare) e ne abbiamo subito dimostrazione nell’opener “Cant’ believe we’re here“, passando poi per la title track, “Right behind you“, “You don’t understand me” e “I can’t find you“, in cui influenze country-Americana si fondono con guitar solo classic rock. “Old Friends” e “It’s true” sono i momenti dell’opera che più si richiamano al feeling 90’s del Dinosauro, mentre la parte conclusiva ritorna al dualismo acustico/elettrico della matrice folk/Americana/country rock di partenza con “Set me down“, “Hangin’ out” e “End is gettin’ shaky“. E quindi, cosa facciamo adesso? Intanto aspettiamo Mascis in Italia in tarda primavera/inizio estate in tour coi Dinosaur Jr, e poi vorrei rivolgergli una frase magari banale, ma che in fin dei conti non lo é: Grazie per esserci ancora e continuare a sfornare album per noi appassionati. A 58 anni (di cui quaranta trascorsi sulle scene) J è un musicista affermato che ha collaudato uno stile, sa in che modo vuole suonare e si è meritato sul “campo di battaglia” – su cui ha combattuto non con le armi, ma da “inattivista” con le sue chitarre e un muro di ampli – gloria e riconoscimenti “indie” (da Kurt Cobain che lo avrebbe voluto nei Nirvana, alle collaborazioni con Mark Lanegan, ai Sonic Youth che, in una canzone, avevano fantasticato su di lui come ipotetico presidente degli Stati Uniti) non ha più nulla dimostrare a nessuno ma, forse, proprio in virtù di questa consapevolezza, si potrebbe leggere il titolo del long playing anche come il segnale di un momento di incertezza che potrebbe preludere a una pausa di riflessione sulla prossima mossa da compiere: tentare nuove strade musicali o restare fedeli a se stessi, riproponendo all’infinito la “comfort zone” di un ventaglio di sonorità che tutti noi amiamo, però a costo di difettare, alla lunga, di qualità e ispirazione? Non lo sappiamo, e “WDWDN” non passerà di certo alla storia del rock ‘n’ roll come un capolavoro o una pietra miliare, ma è un lavoro solido e intanto ci prendiamo questi dieci brani e ci piacerebbe preservare il talento di questo (anti)eroe ancora per tanto tempo a venire.