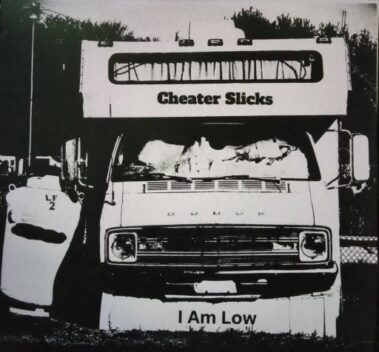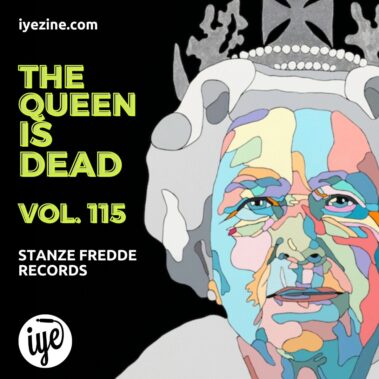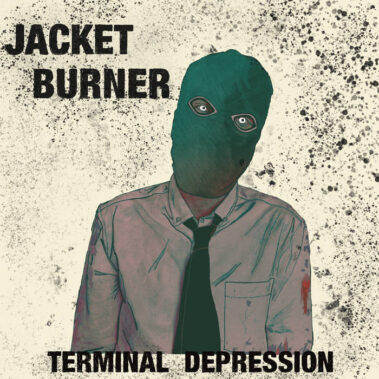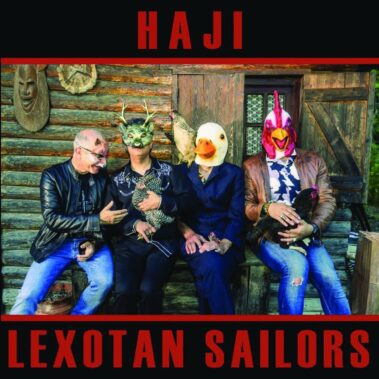Prima o poi scoppierà la bolla dei grossi concerti primaverili-estivi organizzati e gestiti all’italiana maniera (con la chicca dei settori con “visibilità limitata”, fino ad arrivare ai tragicomici biglietti classisti “Vip package” che, per la modica cifra di 500 euro, “regalano”, a chi l’acquista, il posto migliore per fare i selfies e i video del palco, per farlo/a sentire privilegiato/a rispetto alla plebaglia che si deve accontentare del “posto in piedi”, e inoltre vi fanno accedere a una “area relax” per godere nientepopodimeno di qualche birretta, un aperitivo e avere una maglietta delle “rockstar” di turno che, nonostante la cifra sborsata, non si degnano nemmeno di gratificarvi presentandosi di persona e alitandovi in faccia per qualche minuto di “meet and greet“) per assistere a megaconcerti (propagandati come grandi eventi) in stadi, arene o palasport – spesso a distanze chilometriche dal palco, schiacciati uno sull’altro come bestie in un recinto – popolati, per la stragrande maggioranza, da un pubblico di individui occasionali che, magari, di una determinata band avrà ascoltato sì e no tre/quattro canzoni e si “accende” solo per quelle, per poi trascorrere il resto del live a farsi i cazzi propri e giocare con l’i-phone, ma quando sente il richiamo della superband mainstream conosciuta da tutti (diventata un brand di cui trovate il merchandising in vendita anche nei centri commerciali) spende anche l’equivalente di uno stipendio mensile pur di accaparrarsi un tagliando, per poi fare gli sboroni sui social e scrivere “IO C’ERO“, alimentando un circolo vizioso (fatto di agenzie di ticketing, booking, promoters e tutto il cucuzzaro del management organizzativo) che ha ormai rodato un lucroso business che specula sul presenzialismo modaiolo della gente che conosce solo cinque o sei gruppi ruoooooock “famosi” (e sempre i soliti) che vengono a suonare la loro “data unica in Italia” per celebrare i quaranta, cinquanta o sessanta anni di “carriera”, gonfiando a dismisura i prezzi ma raggiungendo ugualmente il “sold out”, a discapito di tanti veri fan che non possono permettersi di tirare fuori cifre improponibili, fuori dal mondo e fuori controllo, per coprire le varie spese che un concerto può comportare (costo alto del biglietto del live; benzina o biglietto per treno, bus o aereo per raggiungere il luogo del concerto se non si abita nei paraggi; pernottamento in strutture ricettive; eventuali prezzi per parcheggi, cibo e “token” per le bevande a prezzi da ristoranti stellati gourmet all’interno dell’area dove si svolge l’evento). Meglio spendere centinaia di euro per questa bolgia infernale, o tornare a frequentare i circoli musicali, i localacci scalcagnati e i piccoli club, spendendo pochi soldi e condividendo il piacere di ritrovare i rapporti umani, vivere le emozioni dei live in tempo reale insieme alle band che suonano a pochi metri dai vostri volti, avendo la possibilità di interagire coi musicisti in carne e ossa, senza filtri di giganti maxischermi né contenuti premium? Di sicuro, se opterete per la seconda opzione (consigliata) in quei posti lì ci troverete a suonare i Cheater Slicks, garage/lo-fi/blues/psych punk band (originaria di Boston, poi trasferitasi in Ohio) tornata quest’anno a pubblicare nuovo materiale a un anno di distanza dall’ultima release, l’album “Ill-fated cusses” (undicesimo long playing ufficiale del combo). Il terzetto statunitense, attivo dal 1987 e incentrato sui fratelli Tom (chitarra e voce) e Dave Shannon (chitarra) coadiuvati da Dana Hatch alla batteria/voce, ha infatti fatto uscire, sulla loro label Morbid web records (e distribuito dalla In the red e dalla Goner records) un singolo autoprodotto che, nell’immediato futuro, non sembra essere l’antipasto di un prossimo Lp: per i nostri, in realtà, sembrerebbe esserci in cantiere la realizzazione di un nuovo 7″ (di cui, al momento, non si conoscono titolo né la quantità dei brani in esso contenuti) in collaborazione con Don Howland, che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno. Poco male, però: quando si tratta di far deragliare sonorità R’N’R sporche e luride, i Cheater Slicks si fanno sempre rispettare. Questo 7″, intanto, presenta due gradevolissimi brani: la title track “I am low” prende in prestito il testo da un poema di Phil Milstein (presidente della Velvet Underground Appreciation Society, editore della rivista “What goes on” che può vantare collaborazioni musicali con Thurston Moore, tra le altre attività) musicato secondo la ricetta degli Shannon brothers, a base di un rozzo e scorticato rock ‘n’ roll, stavolta irrobustita anche da uno schizofrenico intervento di Bobb Hatt al sax a rendere l’atmosfera ancora più sudicia, mentre “Rock ‘n’ roll” è una rivisitazione di un brano del leggendario Ellas McDaniel, in arte Bo Diddley (noto come “The Originator“, colui che suonava la chitarra rettangolare Cigar Box, ispirò migliaia di bands e inventò il “Bo Diddley beat“, tra i principali artefici della transizione, alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, dal blues delle origini al rock ‘n’ roll, uno tra i pionieri che contribuirono a demolire le barriere del segregazionismo razziale negli Stati Uniti con la propria musica, nonché uno dei primi artisti uomini a sdoganare l’inserimento di musiciste donne in una band) trasformato in una selvaggia sarabanda noise-punk dai bostoniani (peraltro non nuovi in quanto a omaggi al Maestro, avendo partecipato anche al tribute album “He’s bad!” col rifacimento di “The great grandfather“) ai quali danno manforte il basso di James Arthur e il saltellante piano di Will Foster (questi ultimi due già presenti nelle sessioni di registrazioni di “Ill-fated cusses“). Crowd-rockin’ motherfuckers from around the way. Losers e fieri di esserlo!