
C’ era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji
C’ era una volta in Bhutan: da vedere perché il regista bhutanese ci racconta di un paese dove, specie nelle zone rurali, la religione è più popolare della politica

C’ era una volta in Bhutan: da vedere perché il regista bhutanese ci racconta di un paese dove, specie nelle zone rurali, la religione è più popolare della politica

Enrico Benevenuto – Transition: lavoro corposo, poetico e di grande bellezza, con un significato speciale a partire dal titolo.
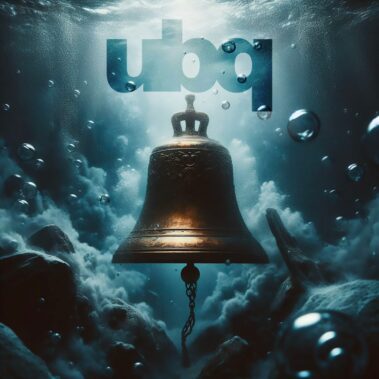
Nidoja – Ubt _ Angapp Music: Un disco prezioso, suonato e sentito in maniera molto diversa rispetto alla maggioranza dei dischi attuali

Principe Valiente sono un gruppo di dark pop svedese arrivati al loro quinto album con “In this light” uscito per Metropolis Records.

Blues a Teheran: un viaggio introspettivo tra musica, psicoanalisi e vita quotidiana nella Teheran contemporanea.

Altamont è un (non) luogo che, nell’immaginario popolare collettivo (e, in particolare, per gli appassionati di rock ‘n’ roll) rappresenta la fine del sogno hippie dei figli dei fiori dei Sixties, quello di un mondo fondato sugli ideali fondamentali della pace e dell’amore universali, dell’assenza di guerre e di altre nobili istanze che, allora come oggi, sono di fatto rimaste utopie (rese tali dall’avidità e dall’ingordigia di denaro e potere da parte dell’essere umano) difficili da raggiungere in un tempo ragionevolmente breve, perché più passano gli anni e più il mondo sta regredendo in una spirale autodistruttiva di odio irrazionale, antropocene, diseguaglianze sociali e cieca violenza, invece di progredire. In quelle cittadine californiane, nel dicembre 1969 (ma anche nell’agosto dello stesso anno, con l’eccidio losangelino di Cielo Drive messo in atto dalla setta guidata dal “guru” deviato Charles Manson, genio del male col cervello bruciato dall’LSD) si sono consumati, a livello temporale e non, gli anni Sessanta, dopo il megafestival gratuito in un autodromo, (male) patrocinato dai Rolling Stones che, insieme agli altri organizzatori, affidarono infelicemente la gestione del “servizio d’ordine” agli Hell’s Angels strafatti e ubriachi molesti, con tutti i disagi che ne seguirono, causando incidenti e accoltellando a morte un ragazzo afroamericano. Se da un lato, però, il nome della rassegna statunitense resterà sempre legato a questo fattaccio (che in totale registrò quattro decessi) visto come uno degli eventi spartiacque che hanno segnato il tramonto del movimento degli hippies come fenomeno di massa, dall’altro lato l’aura negativa e il fascino malvagio legato a quel macabro festival ha ispirato diverso rock ‘n’ roll sporco e abrasivo, e un esempio di questa influenza si può ritrovare, senza dubbio, nel garage/psych rock proposto dai Lords of Altamont che, manco a dirlo, si sono formati a Los Angeles e già dal moniker si ricollegano a uno degli avvenimenti più discussi che ha contraddistinto la storia della “musica del diavolo” e che rappresentò il rovescio della medaglia di Woodstock, il flower power represso nel sangue delle proprie illusioni. Quest’anno i quattro ragazzacci (Jake Cavaliere alla voce e organo, Robert Zimmermann al basso e voce, Barry Van Esbroek alla batteria/voce e l’italiano Daniele Sindaco alla chitarra e voce) hanno pubblicato, attraverso la label romana Heavy Psych Sounds, un disco dal vivo, intitolato “To Hell With Tomorrow The Lords Are Now!“, che in realtà sarebbe un album live in studio, suonato dal vivo non in un concerto vero e proprio, ma in uno studio di registrazione olandese (precisamente i Moskou studios di Utrecht) le cui incisioni dei pezzi sono avvenute nell’aprile 2022, dopo due anni di pausa pandemica forzata. A due anni di distanza dall’ultima fatica discografica, il long playing “Turn on, Tune in, electrify!“, i seguaci del caos di Altamont tornano con un full length suonato in maniera feroce e impeccabile, con la solita ottima qualità (merito anche di Guyom Pavesi in cabina di regia) e maestria con cui nostri sanno maneggiare il garage rock di matrice Stooges, MC5, Cramps, Fuzztones, Sonics, Dwarves (e altra compagnia brutta, sporca e cattiva) producendosi in una sorta di greatest (s)hits del loro materiale (escluso l’ultimo Lp, ancora troppo fresco d’uscita l’anno scorso) reso in maniera così potente, precisa e compatta che non sembra neanche di trovarsi di fronte a un live record, tanta è la perizia con cui i quattro sciorinano le tredici canzoni (di cui una cover di “Slow death” dei Flamin’ Groovies come bonus track e due brevi intermezzi, uno in apertura e l’altro a metà dell’opera, che si dividono il titolo della stessa) presenti in scaletta senza le sbavature tipiche di un concerto con tutti i crismi (e ultimamente l’ensemble è anche passato dall’Italia, con una data a Torino e una a Marina di Ravenna). Con un lettering in copertina che richiama il logo degli Stooges (e durante il disco rievocati soprattutto nel brano “Going downtown“, quasi un omaggio a “Raw Power”) “To Hell…” corre dritto e spedito come un treno, travolgendo qualsiasi cosa gli si piazzi davanti, per poco più di mezz’ora che, ai timpani già allenati a determinate sonorità raw ‘n’ wild, procurerà sicuro godimento. “Sorry, no stickers, no fake tattoos, and no autographs, just raw live rock ’n’ roll” è la frase scelta dal gruppo per descrivere il contenuto di “To Hell…”, ma può benissimo essere applicata all’essenza di tutta la natura dei Lords of Altamont da ventitré anni a questa parte, una band che non ha bisogno di (iper)produzioni milionarie per esprimersi in dischi e concerti infuocati, prova ne sia questo primo live album, coi volumi sparati al massimo, registrato in un solo giorno e senza l’ausilio di trucchi da studio né altre correzioni da post-produzione. They walk it like they talk it, e restano una delle migliori band in circolazione nel panorama del rock ‘n’ roll tutto, ancora capaci di incendiare i palchi di tutto il mondo con la loro miscela dinamitarda di garage rock, proto-punk, blues and glam. Come dite? E’ tutta roba vecchia? Ecchissenefotte, la modernità ha rotto il cazzo, e ci servono anche dischi come questo per rinverdire una formula che rielabora il buono (e cioè il marcio) della musica degli ultimi sessant’anni per poi shakerarlo e servirlo in un cocktail esplosivo da bere contro il logorio della quotidianità e lo squallore dell’attualità. Preservare i frutti migliori del passato come antidoto alla morte (fisica, cerebrale e spirituale) propinata dal nulla odierno. TRACKLIST 1. To Hell With Tomorrow 00:17 2. I Said Hey 3. Going Downtown 4. Going Nowhere Fast 5. Ivory 6. Like A Bird 7. The Lords Are Now! 00:23 8. The 7th Day 9. Velvet 10. Action 11. 4.95 12. F.F.T.S. 13. Slow Death (BONUS TRACK, Flamin’ Groovies cover)

Sarà che il blues e il punk, due generi/movimenti/universi differenti tra loro per contesto storico-culturale e ambientale, ma in fondo accomunati dalla stessa urgenza espressiva e concettuale, sono opposti che si attraggono per via della stessa esigenza di suonare una musica (apparentemente) semplice per far sentire la propria voce al mondo e veicolare istanze ed emozioni, usando un linguaggio “urbano”, poco forbito o comunque di facile comprensione, affinché arrivi a più gente possibile il racconto nudo e crudo della vita di tutti i giorni: gioie, paure, amore, meraviglia, magia, vittorie, sconfitte, delusioni e vendette sentimentali, sfoghi, ingiustizie, soprusi, odio, disgusto, noia, rabbia verso la società e il sistema borghese/capitalista di sfruttamento della povera gente, che prescinde dal colore della pelle (gli afroamericani deportati e costretti a lavorare tutto il giorno nei campi di cotone, la working class inglese e, in generale, dell’uomo bianco disoccupata o salariata ma condannata a sopravvivere facendo lavori odiati, precari e sottopagati) le difficoltà a tirare avanti e la voglia di rivalsa sociale. Due background distinti, ma identici problemi. E quando questi due mondi si incontrano-scontrano e provano a dialogare, fondersi e compenetrarsi l’uno nell’altro, quasi sempre il risultato di questa commistione dal basso dà vita a una musica infuocata, ruspante, vivace e verace. Non stiamo parlando, logicamente, di puristi della tecnica alla Eric Clapton o altri mostri sacri della popular music che hanno fatto le loro fortune ripetendo all’infinito gli stessi stilemi di un blues/rock/pop che si è “appropriato” della black music (dalla “British invasion” in poi) e dagli anni Sessanta in poi ne ha riproposto sempre una versione “sbiancata” e ingessata di esso. No, ci riferiamo invece al melting pot tra blues apocalittico e punk rock incendiario (o anche garage rock/punk di Sixties ed Eighties) di cui sono stati fautori band e artisti straordinari e indimenticati come gli Stooges, i Gun Club, Jon Spencer nelle sue varie incarnazioni, Reverend Beat-Man. Tutte esperienze di cui la one girl band vicentina Elisa De Munari, in arte Elli De Mon, ha fatto tesoro (suonando in giro per l’Italia ed Europa, a volte aprendo, tra gli altri, anche per i live di Jon Spencer e del Reverendo) e ha riproposto nel suo ritorno discografico, con l’album “Pagan Blues“, da poco pubblicato sulla benemerita label pisana Area Pirata Records, ri-miscelando l’energia e l’attitudine del rock ‘n’ roll con la tradizione sciamanica della psichedelia indiana e del blues ancestrale di Bessie Smith, Fred McDowell e Son House. Il settimo Lp ufficiale di Elli, talentuosa donna/realtà ormai consolidata nel panorama dell’underground indipendente italiano ed europeo, mostra l’artista sempre sul pezzo, migliorata tecnicamente e nello stile, perfettamente capace di padroneggiare con disinvoltura tutti gli onori e gli oneri che spettano a un/una one man/woman group, ossia cantare e suonare tutto da soli/e: grancassa, chitarre, rullante, sonagli e spirito di sacrificio. Con il blues primordiale a fare da collante e bussola tra progetti passati, presenti e futuri. Il full length arriva, infatti, a due anni dal progetto “Countin’ The Blues“, tribute album e libro incentrato sulla figura delle pionieristiche e coraggiose blueswomen afroamericane degli anni Venti del Novecento (ai quali hanno fatto seguito la graphic novel “La donna serpente“, e il libro di racconti “Muder Ballads“) e “blues” è ancora la parola chiave, quella del titolo del nuovo long playing, ma è anche “pagano” perché accoglie le molteplicità e coltiva il dubbio, in provocatoria opposizione verso le scuole pensiero che ingabbiano il blues in un oggetto devozionale, da museo (come detto prima riguardo a Eric Clapton e affini) e in discorsi puristi su cosa sia “vero blues” o meno. Ma il “paganesimo”, non avendo la pretesa di essere un’entità assolutistica, mischia popoli e culture, non si nutre di certezze granitiche “monoteistiche”, è un camminare domandando, e questo cammino musicale (che va avanti da oltre un decennio) non fa avere a Elli la verità in tasca, ma la porta a studiare tradizioni musicali extraeuropee, viaggiare e indagare in luoghi lontani (fisici e spirituali) a volte anche scomodi, ma dal conflitto tra luce e oscurità ci si arricchisce nell’anima e si gettano ponti oltre gli integralismi. Un percorso “pagano” aspro che si snoda lungo nove tappe di dannazione e inquietudine, a iniziare dal costante senso di minaccia di “The Fall“, che sembra sempre in procinto di deflagrare da un momento all’altro, al fragore chitarristico cesellato di “I can see you“, passando per il torrido trip sotto effetto del peyote fatto in compagnia del fantasma di Jeffrey Lee Pierce in “Desert Song” e in “Catfish Blues“, ammaliante e letale come l’abbraccio mortale di un black mamba che sbuca dalle stesse savane africane che ha partorito i progenitori del deep blues. “Star” si muove come un canto beneaugurante per una nuova e generosa Saturnalia che dia abbondanza e sfami tutto il creato, mentre i ticchettii di “Ticking” innescano esplosioni garage rock che avrebbero fatto felici i White Stripes, ma anche Pj Harvey (altra beniamina della polistrumentista veneta) sarebbe fiera delle folate alternative della title track e di un brano come “Sirens’ Call” che sembrano ispirati proprio a Polly (e alla collega “one whoaman band” Molly Gene) anche se insaporiti da spezie psych indianeggianti, prima di lasciare la scena alla conclusiva “Troubled“, sorta di ninna nanna al veleno sussurrata dai genitori alla prole per metterla al letto, coricandosi poi con la ripromessa di ringhiarla anche in faccia ai propri schiavisti il giorno successivo, ritornando a spaccarsi la schiena ai lavori forzati nelle piantagioni di tabacco. “Pagan Blues” è un album senza cali di tensione e senza sbavature né troppi fronzoli, va efficacemente dritto al punto, a buon diritto si candida a essere uno degli album preferiti del 2023 per chi vi scrive, e un buon pretendente a un posto nella classfica dei migliori dischi di quest’anno. TRACKLIST 1. The Fall2. I Can See You3. Desert Song4. Catfsh Blues5. Star6. Ticking7. Pagan Blues8. Sirens’ Call9. Troubled

Questo disco è una cassetta e solo in cassetta è come vi consiglio di ascoltarlo; così come il supporto dove si decide di dipingere è importante per definire la luce, il contrasto, l’impatto del colore e le sue sfumature, così è importante la musicassetta per cogliere l’immaginario di Klint, le sue visioni sonore su di un mondo senza tempo, che iniziano nel 1021 e stazionano, temporaneamente, nel 2023.

Terzo disco per i Madhouse capitanati dalla cantante cantante Federica Tringali e dal chitarrista Filippo Anfossi, il titolo è ” Secret antithesis” ed esce per Nadir Music. La proposta musicale dei Madhouse è un metal moderno e fresco, con rimandi gotici in alcuni passaggi.

Still No One -This is fuel: esordio discografico sulla lunga distanza per i trevigiani Still No One dal titolo “ This is fuel”, autoprodotto.

Atteso ritorno dei Memoriam, il gruppo death metal fondato dal cantante Karl Willetts ex dei Bolt Thrower da Frank Healy bassista dei Benediction ed ex chitarrista dei Napalm Death, insomma la crema del death metal, coadiuvati molto bene da Scott Fairfax alle chitarre e Spike T. Smith alla batteria.

Turisti, terroristi, hacker, fondamentalisti e algoritmici sono parte di quelle tribù che abitano e agitano L’innominabile attuale (2017), un mondo che pare ignorare il suo passato ma che s’illumina appena si profila il periodo fra il 1933 e il 1945.Roberto Calasso.