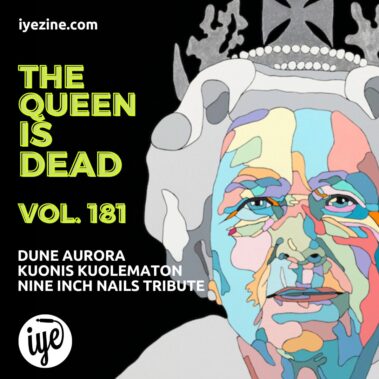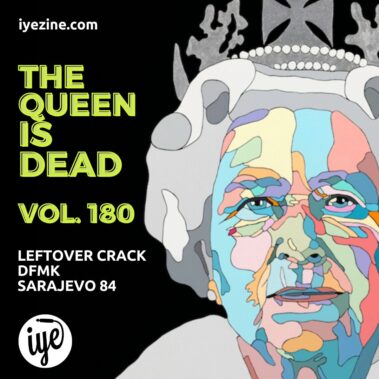Ludovica conduce da alcuni anni una vita molto ritirata. In seguito a un periodo caratterizzato da frequenti attacchi di panico, ora vive nella paura di poterne avere degli altri. Ha smesso di prendere i mezzi pubblici e l’automobile, evita di frequentare i luoghi affollati così come gli spazi aperti e lascia la sua abitazione solo se strettamente necessario e accompagnata da un familiare.
Questo è solo uno dei molti casi di agorafobia, un disturbo fobico per il quale un numero sempre maggiore di adulti si rivolge a uno psicoterapeuta per chiedere aiuto.
Sebbene la parola significhi letteralmente “paura della piazza”, nel tempo ha assunto un significato sempre più ampio, rappresentando un disturbo specifico e unitario, che si manifesta anche in assenza del disturbo da attacchi di panico.
Oggi l’agorafobia viene definita come “ansia relativa all’essere in luoghi o situazioni dai quali sarebbe difficile (o imbarazzante) allontanarsi, o nei quali potrebbe non essere disponibile aiuto nel caso di un attacco di panico o di sintomi tipo panico (per esempio la paura di poter avere un improvviso attacco di capogiri o di diarrea)” (APA, 2000, p. 396).
Sono tre, in particolare, le situazioni che possono generare ansia nella persona con agorafobia: la solitudine, la costrizione e gli spazi aperti.
Ma cosa hanno in comune queste tre situazioni?
La solitudine riduce il senso di sé poiché vengono a mancare le persone dalle quali il paziente sa di essere conosciuto e con le quali si identifica: è la mancanza di familiarità, infatti, più che la solitudine a rappresentare una situazione ansiogena in questo tipo di pazienti. Ecco perché in molti casi la figura dell’accompagnatore, una figura, cioè, più familiare che protettiva, svolge una funzione fondamentale, se non risolutiva, poiché il senso di sé di questi pazienti si incrementa attraverso la consapevolezza di una relazione in cui ci si riconosce reciprocamente.
La costrizione rappresenta, invece, una limitazione dell’individuale libertà di agire, intesa non solo come costrizione fisica, ma anche mentale, come quella di un legame affettivo o di una situazione lavorativa che non consente di esprimersi e agire liberamente.
Gli spazi aperti, infine, implicano una sensazione di disorientamento, dovuta alla mancanza di punti di riferimento (tanto per rendere l’idea, basti ricordare l’iniziale sensazione di smarrimento che ci assale quando ci immergiamo nella visione di un cielo stellato!).
Insomma, quello che caratterizza queste tre situazioni è la perdita di controllo, intesa come dissolvimento del senso di sé e della propria agentività: in sostanza, la persona con agorafobia si sente privata della sensazione di sentirsi protagonista della propria vita e interpreta, questa sensazione come catastrofica e irrecuperabile, temendo, cioè, di essersi trasformata in uno zombi e di aver raggiunto una sorta di “punto di non ritorno” (Gragnani e Mancini, 2004, 2005).
A mantenere e peggiorare tali pensieri catastrofici contribuiscono, poi, tutta una serie di comportamenti protettivi (come l’evitamento di alcune situazioni o la fuga), finalizzati a prevenire proprio gli esiti temuti, ma che, di fatto, non solo si rivelano controproducenti, ma aggravano la qualità della vita delle persone con agorafobia .
Cosa fare dunque? Rivolgersi a uno specialista è sicuramente un primo passo per alleviare la sofferenza e la terapia cognitivo-comportamentale rappresenta un trattamento estremamente efficace per l’agorafobia poiché interviene sui pensieri catastrofici e sui comportamenti protettivi che aggravano il disturbo.