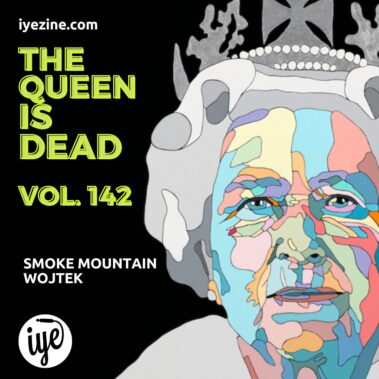SETTEMBRE DUEMILAVENTUNO
“L’UTILITA’ DELL’INUTILE”
Ho deciso di prendermi un mese di pausa da tutte quelle che sono (state) le mie ultime “confessioni”. La vita mi sta mettendo a dura prova, come a volermi ricordare che non sono io quello che ha potere decisionale sul presente e sul futuro. L’entità dei problemi che vedo crescere in modo ingravescente inizia a diventare preoccupante e di non facile gestione. Soprattutto in ambito familiare, laddove gli equilibri sono da sempre particolarmente precari. Inevitabile quindi la ricerca di un qualcosa che possa aiutarmi ad evadere da quelle dinamiche in cui sono giocoforza finito negli ultimi mesi. Per cui stavolta argomenti frivoli. Niente Covid-19, niente GreenPass, niente vaccini, niente di tutto quello che ha caratterizzato e sta ancora caratterizzando la storia recente. Lascio che momentaneamente siano altri a portare il ragionamento laddove è richiesto un supplemento di intelligenza. Io mi fermo a qualcosa di meno serio, cercando di svagarmi e di riappropriarmi di una delle mie passioni da sempre, la musica.
Da sempre convinto che l’approccio all’ascolto sia da individuare in un coinvolgimento che implica l’allontanamento di ogni fonte di disturbo, per un’immersione che sia quanto più totalizzante possibile, mi sono deciso ad ascoltare alcuni tra i dischi che sono usciti di recente, e di cui ho sentito parlare di più. E visto che si tratta di gruppi a cui sono storicamente intimamente legato, sia da un punto di vista affettivo che di crescita musicale, quale occasione migliore per provare a “staccare” un attimo e ripulire la testa da tutti quei pensieri che mi stavano portando su una strada molto pericolosa in cui è facile scivolare?
Tra i tanti ho puntato quelli di Carcass e Iron Maiden, stimolato dal gran parlare che ne hanno fatto online la maggior parte degli “amici”. Ho visto e vissuto le loro carriere in modo intenso. Il primo concerto che vidi fu quello degli Iron Maiden a Firenze nel lontano dicembre del 1986, per il tour mondiale di “Somewhere in Time”, a 15 anni. Mentre per i Carcass posso raccontare di esser stato presente al loro concerto (il primo in Italia) al Forte Prenestino di Roma, nel luglio del 1990. Giusto il tempo per gustare “Genital Grinder”, “Exhume to Consume” e “Reek of Putrefaction”. Stop. Dopo solo il delirio, la rissa con il pubblico e l’interruzione del concerto. 410 chilometri per vedere tre pezzi soltanto ed essere stati tra i pochi che avevano preso le parti dei Carcass, che dal palco agitavano i loro strumenti imbracciandoli al contrario come armi per difendersi.
Ci tengo a sottolineare sin da subito che non si tratta di una doppia recensione, ma di un ragionamento che unisce i due dischi cercando di sottolineare la loro totale inutilità, anche se per motivi tra loro differenti. La mia non è la reazione dell’amante deluso, che scopre come le cose non stiano più come un tempo e quindi apre il proprio cuore dilaniato in pubblico. Sono anni che non mi emoziono più per loro, avendo raggiunto un distacco emotivo che mi permette di guardarli con criterio, alla giusta distanza, in modo analitico, senza farmi condizionare dal troppo amore di un tempo. Lungi da me quindi cadere nella retorica nostalgica, la mia è una visione sì critica, ma al tempo stesso assolutamente lucida. Magari, anzi quasi sicuramente, non condivisibile, ma spontanea, del tutto priva di malizia.
Partiamo dai Carcass e dal loro “Torn Arteries”. Detto della copertina che è l’unica cosa che salvo, non posso non dire sin da subito che si tratta di un album assolutamente gratuito. Un album che sicuramente a molti piacerà, ma che per me altro non è che la riesumazione degli scarti di “Heartwork” (1993) ricontestualizzati per renderli affini ai giorni nostri. Non riesco proprio a capire che cosa abbia da dire un disco come questo e a che cosa possa servire restare legati ad un suono e a un approccio che da quasi trentanni è quasi sempre lo stesso. “Torn Arteries” non aggiunge nulla alla loro carriera, soprattutto per me che sono legato in modo indissolubile ai loro primi due album, gli unici che abbiano apportato un cambiamento radicale in ambito estremo. È un disco che suona esattamente come deve suonare, in modo del tutto privo di spontaneità, piatto, monotono. Da “Symphonies of Sickness” (1989) in poi, tranne alcune cose di rilievo in “Necroticism” (1991) salvo soltanto l’azzardo, ovviamente non ripagato, se non da pochissimi, di “Swansong” (1996), disco che segna in modo indelebile il loro percorso. Vero disco nichilista per eccellenza, ben altra cosa rispetto a tutto ciò che è seguito e che li ha portati ad oggi. Disco che ha spiegato in modo chiarissimo come i Carcass fossero realmente un passo avanti rispetto agli altri. “Torn Arteries” va in direzione opposta, come il precedente “Surgical Steel” (2013), e finisce per accontentare il “metallaro medio”, quello che non sposta troppo i propri ascolti, non per incapacità ma per ottusa adesione ai cliché. E allora via di tecnica, pulizia, velocità e produzione che spinge nei punti giusti, per l’ennesimo album che rasenta la noia. Se “Swansong” (su cui insisto parecchio proprio perché credo che potesse rappresentare lo spartiacque nella loro carriera, mentre si è rivelato realmente il loro “canto del cigno”) viveva in modo irrazionale la sua carica di irriverenza altrettanto fa “Torn Arteries” chiudendosi in un concentrato di esercizi di stile atti a mostrare quanto siano bravi i Carcass a fare dischi che suonano bene. Il fatto che poi, però non dicano nulla, pare interessare solo a me. Ma me ne farò una ragione.
Passando invece a “Senjutsu” degli Iron Maiden il discorso cambia. Partendo dall’idea, maturata nei decenni, che i Maiden non avessero veramente più nulla da dire, mi sarei aspettato molto ma molto peggio, sono sincero. Detto che negli otto anni che vanno dal 1980 al 1988 hanno sfornato sette dischi epocali e irripetibili, è difficile approcciarli oggi a distanza di così tanto tempo. Degli anni 90 non c’è davvero nulla da salvare, al punto che ricordo come pensassi spesso ad uno scioglimento che sembrava, per me, inevitabile, visto il declino inarrestabile in cui erano precipitati. Al netto di un “Brave New World” (2000) con cui rialzarono inaspettatamente la testa qualitativamente parlando, il resto degli ultimi ventanni è stato un procrastinare la fine a suon di album pessimi sotto tutti i punti di vista, alternati da raccolte e live album su cui preferisco sorvolare.
Quello che non capisco è perché continuare a prolungare una carriera che li ha resi l’unica vera grande icona del metal moderno, portandoli laddove nessuno è mai arrivato e mai arriverà. Nemmeno i tanto osannati Metallica possono dire di avere influenzato le generazioni a venire quanto e come hanno fatto (involontariamente, ed è qui che sta la loro grandezza) gli Iron Maiden. Potrebbero ritirarsi a vita privata in modo più che onorevole e invece si ostinano a sfornare album che rischiano di farli ricordare per i loro ultimi passaggi a vuoto, anziché per quello che davvero hanno rappresentato.
Restando su questo ultimo “Senjutsu” non possiamo innanzitutto sorvolare sulla pessima produzione, che contribuisce a rendere ancora peggiore la resa totale di un disco che poteva essere tranquillamente evitato. È inconcepibile come oggi a distanza di quarantanni dal loro esordio si possa ascoltare un album così pessimo come resa sonora. D’accordo che i Maiden sono da sempre orientati ad un suono che ruota tutto intorno al basso di Harris, ma una povertà di suoni (prima) e di mixaggio (a seguire) non possono passare inosservati, a meno che non si menta in modo consapevolmente di parte.
Capisco che quello che resta della voce di Dickinson andasse preservato e mostrato per quello che non è più da decenni ma così si sfiora il ridicolo. Perché, è inutile girarci intorno, il vero problema degli Iron Maiden è il cantante. Sfiancato e sfinito da problemi di salute che avrebbero ucciso chiunque e che lui ha stoicamente mostrato di aver a suo modo superato, dobbiamo però ammettere che di voce non ne ha davvero più, soprattutto per uno stile come quello dei Maiden caratterizzato da cavalcate sui cui lanciare i propri acuti. Non fraintendetemi, è normale che sia così, per età e per patologie pregresse, resta il fatto che qualcuno dovrebbe far loro presente la cosa, prima che gli Iron Maiden diventino un gruppo strumentale a tutti gli effetti. Non a caso quello di buono (e non è poco, anzi) di “Senjutsu” arriva nei brani meno intensi, più cadenzati, che girano intorno a tonalità decisamente più basse, alla portata di Dickinson.
La formazione a tre chitarre è un qualcosa di cui non vorrei più parlare, ma visto che ci siamo… La scelta di mantenere in formazione Gers, la cui entrata è coincisa (in modo tutt’altro che casuale) con l’inizio del declino compositivo nel 1990, è uno dei grandi misteri della storia musicale del secondo dopoguerra. Fermo restando che non apprezzo il suo gesticolare da scimmietta ammaestrata sul palco, nè tantomeno la sprecisione con cui “sporca” i brani, trovo che sia soprattutto il suo apporto in fase compositiva, praticamente nullo, a rendermelo insopportabile agli occhi. Se qualcuno ha idea di queli migliorie arrivino da un terzetto di chitarristi, sono prontissimo ad ascoltarlo. Io, che da anni me lo chiedo ancora non ho trovato risposta.
Rileggendo a posteriori quanto scritto, avrei potuto impiegare diversamente il mio poco tempo libero, ma alla fine è giusto tributare il doveroso epitaffio anche a loro.