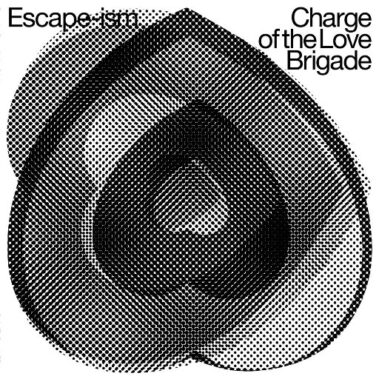CONFESSIONI DI UNA MASCHERA
MAGGIO DUEMILAVENTUNO
“SMALL MAN, BIG MOUTH”
La voglia di apparire a tutti i costi, anche quando non ci sono le condizioni per potersi inserire in una conversazione in cui non si ha nulla da dire e che ci vede giustamente spettatori silenti, riesce a metterci in ridicolo una volta di più. L’ego smisurato che ci fa credere di essere in grado di disquisire sempre e comunque ma soprattutto di qualunque argomento, è il migliore alleato per cadere rumorosamente, e a poco servirà cercare di arrampicarsi sugli specchi per una risalita che mostra sistematicamente il peggio di noi stessi, se messi sotto stress per la figuraccia pubblica appena rimediata. Il grande problema, sdognanato e amplificato dalla rete, è che tutti pensano di poter disquisire di qualunque argomento e in qualsiasi contesto, indipendentemente dal fatto che abbiano le competenze, le conoscenze e soprattutto che sia richiesta la loro opinione.
La voglia di apparire è il virus di una pandemia ancora peggiore di quella che stiamo cercando di metterci alle spalle.
La nostra è una professione che svolgiamo quasi costantemente con i guanti alle mani, non solo oggi in epoca di covid-19. Anche solo da un punto di vista simbolico, indossare i guanti è un segnale di distacco, di allontanamento, non solo di precauzione sanitaria. “Sporcarsi le mani” è il grido di battaglia che sentiamo di dover fare nostro, il segnale che ci spinge a rompere gli schemi con un gesto che vada al di là delle dinamiche lavorative.
Un atteggiamento “rivoluzionario” che sottintende la voglia di liberare il nostro istinto, contro ogni tipo di dogma razionale.
Siamo quello che abbiamo vissuto e non quello che ci chidono di essere. Siamo il prodotto di una serie di dinamiche che ci hanno visti protagonisti, con cui abbiamo riempito i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre incertezze. Non il risultato dell’applicazione di schematici comportamenti indotti da didattiche asettiche che negano l’irrazionalità dei rapporti umani. È irricevibile l’idea di doversi “far belli” soltanto perché è il nostro ruolo sociale che ce lo impone nel momento in cui indossiamo la divisa. Irricevibile e umiliante.
Questo è un atteggiamento che mostra, più che una decadenza, una povertà eticomorale che non è forse nemmeno possibile quantificare. È lo specchio di una mentalità misera che viene da coloro che pensano di aver avuto una “rivalsa sociale” grazie alla propria professione, mentre non hanno capito che, oltre ad essere ingranaggi semisconosciuti di una ruota che gira anche in loro assenza, il loro spessore e il loro riconoscimento sociale sono da ricercare in tutti quei momenti e in quelle situazioni che esulano dalle imposizioni. Si tratta di un concetto talmente semplice, che non riusciamo a capire come non possa essere ancora stato sdoganato ed accettato collettivamente. Ma è anche vero che, molto spesso, queste figure sono anche quelle “meno dotate” da un punto di vista intellettivo. Per cui insistere in questa direzione non porta e non porterà a nulla. Fermiamoci quindi.
L’incapacità, o ancor peggio il disinteresse, verso le relazioni che non ci portano “benefici” tangibili, concreti ed immediati, è intellettualmente abominevole per il nostro modo di pensare alla socialità. Ma, visti i tempi che corrono, e l’atteggiamento comunemente diffuso, siamo arrivati alla conclusione che siamo noi a stare dalla parte del torto, almeno numericamente parlando. Noi, stolti ed ottusi sognatori che pensano ad un mondo che sia inclusivo ben più di quanto non lo sia stato, e non lo sia oggi, restiamo ancorati all’idea che sia possibile dare senza necessariamente ricevere nulla in cambio, per il piacere del gesto, per la sua bellezza, per il suo valore simbolico.
Ma siamo anche purtroppo consapevoli che una buona fetta di coloro che si proclamano professionisti della salute siano andati e vadano in altra direzione. Segno tangibile della pochezza di una categoria professionale che poco ha imparato dagli insegnamenti di una vita in corsia. Noi non siamo santi né eroi, e nemmeno mai abbiamo ambito a tali status, siamo però disgustati da ciò che ci circonda e che ci equipara a loro. Siamo dunque qui per ribadire la nostra distanza etica e intellettuale da tutti coloro che vedono nell’empatia il modo migliore [se non l’unico] per non incorrere in sanzioni amministrative o pecuniarie.
Siamo in minoranza, anche e soprattutto perché pensiamo di anteporre l’irrazionale al razionale, perché pensiamo di liberare le emozioni anziché chiuderle in gabbia, perché rifiutiamo gli schemi comportamentali imposti e preferiamo vivere le dinamiche in modo spontaneo. La scelta di come impostare una relazione, un contatto, un rapporto è il frutto di un vissuto, di un modo di pensare, di una scelta ideologica e non di uno schema che prevede la didascalica adesione a schemi dettati da chi i rapporti è abituato a viverli sui libri e non di persona.
La nostra esperienza professionale e di vita quotidiana ci ha insegnato a vivere “liberi”, a rifiutare tutti i dogmatismi tranne quelli che ci impone la nostra coscienza, a dare spazio a chi di spazio non ne ha, a illuminare le vite di chi vive al buio. Ma soprattutto a farlo nella vita di tutti i giorni e non solo sul posto di lavoro, perché “qualcuno” ce lo impone. Che senso ha essere il miglior infermiere sulla piazza se poi appena dismessa la divisa cambi il tuo comportamento coi tuoi simili e ti trasformi in un intollerante? Possiamo per assurdo ipotizzare un’unica spiegazione, che risiede nella necessità di sfogare la tensione e lo stress accumulati per aver dovuto “recitare un ruolo” fingendo socialità ed empatia. E nella voglia di farlo con il primo incontrato. Altre non ne troviamo.
In un rapporto, la comunicazione, oltre ad essere bilaterale, è anche subordinata a tutta una serie di fattori che la “letteratura” non può prevedere. Ogni situazione che intercorre tra due persone va al di là dei ruoli sociali, essendo figlia di tutte le dinamiche legate al contesto in cui ci si ritova ad agire. È un insieme di sollecitazioni che non possono essere ricondotte alla razionalità schematica. Pena la morte della spontaneità, con la conseguente impossibilità di costruire un qualcosa di duraturo, spontaneo e gratificante.
Come detto, la capacità di astrarre il pensiero è un qualità che non tutti possiedono. Non esistono corsi universitari per acquisirla. Chi ne è sprovvisto ne resterà sempre sprovvisto, potrà pensare di arginare alla meglio, limitando i danni, quello che è il suo reale istinto, ma non sarà mai in grado di vivere un rapporto in modo spontaneo e trasparente. Sul lavoro come nella vita. L’empatia, per tornare all’argomento di partenza, non è in vendita.
Nel momento in cui standardizziamo le nostre emozioni siamo morti. E se non ci hanno ancora seppellito è solo per mancanza di posti disponibili nei cimiteri. La morte interiore ha molti modi per manifestarsi. Questo è uno di quelli.
Empatizzare come meccanismo di risposta ad un potenziale “pericolo” è l’aberrazione dell’emotività. È la morte, immmediata e meritata.