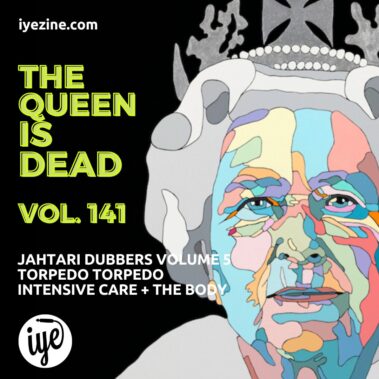Mi accingo a scrivere ora e su questo per caso, perché mi sono ritrovato a pensare che ormai sono sufficientemente freddo su ciò che è accaduto tempo fa.
Intendiamoci: Bowie non fu mai umile.
E’ curiosa la cosa che lessi altrove, non ricordo se di Bangs, che diceva di come egli ricordasse un vampiro, come si attaccasse letteralmente ai colleghi per assorbirne il talento, se qualcuno si ricorda Space Jam; cito questo film apposta per creare un ponte fra la realtà e il cartone animato: in linea di massima quello che aveva fatto David Bowie.
Mi sento di dire che sono sempre stato un suo grande ascoltatore ed estimatore (intanto mi son chinato per tutti quelli che volessero prendermi a sassate, poi non si dica che non son buono) e in quanto tale intendo prendere qualche distanza dai video che girai anni fa.
Ziggy Stardust era a colpo sicuro, un disco fortissimo come quelli di Marc Bolan ma non come For Your Pleasure; certo è che se spingiamo dentro anche l’enormità di Alex Harvey e, volendo, pure la mediocrità di Jobriath a fare da contrappeso, c’è chi può concordare nel pensare che David Bowie abbia avuto il suo periodo di fertilità musicale (scaturita dall’assimilare) nell’arco d’anni incluso fra il disco sopracitato e, sostanzialmente, Lodger.
Sorvolando sul punto che Aladdin Sane aveva rimandi secchi alle “nuove” soluzioni degli Stones, il fatto che avesse centrato l’obiettivo preso a metà con Raw Power, cioè pulire e vasectomizzare, era indicativo delle inclinazioni al compromesso industriale, e se quindi Aladdin lo consideriamo un gran disco dobbiamo solo che riesumare ed abbracciare la salma di quel pazzo che era Mick Ronson.
Nel senso, pure non vivendocelo in prima persona noi si ascolta, non siamo scemi.
Poi si ascolta Young Americans e Station To Station, e ci si scopre curiosi di grattare ancora, soprattutto nel secondo caso, ove la dichiarazione di Bowie è concreta e fredda, come se si fosse riascoltato Pinups e ne avesse ricevuto la medesima doccia. Il disco è austero, diverso, pure questo con le scantonate di Golden Years e Wild Is The Wind, quest’ultima un bel melò a membro duro (!); il disco complessivamente aveva, è vero, più sincerità rispetto ai personaggi precedenti, di quelli dalla sporta del Duca. E questo non significa necessariamente che il nuovo alter-ego non fosse uno fra i tanti: era il più azzeccato, che senza dare troppo peso ai privati dettagli di contorno del tempo che poteva tener per fatti propri aveva ed ha tutte le carte in regola per esser apprezzato.
A Bowie fece bene calarsi nel personaggio, perché oltre a scovare una nuova identità musicale con Brian Eno presso gli studi Hansa a Berlino Ovest nel 1977, trovò una sintesi di sé stesso nel contrapporsi consapevolmente all’Idiot Pop grazie alla copertina di Heroes: la via spudoratamente evidente di offrire un doppia scelta al consumatore dopo le grandi estemporaneità in Low lo mise nella condizione di attuare la mitosi, di poter dare arbitrio al
consumatore tra i demoni personali o le sue esorcizzazioni per tutta la durata dell’anno e di quello successivo, e nel negozio più vicino a te, lettore.
Così fu di nuovo e come sempre in sé, nella via paradossalmente più onesta.
Premurandosi di catturare l’aria del periodo cortina, il Duca si imbosca dietro i synth per poi esporsi in prima persona ma in scala di grigi, sbiadito come i palazzi tedeschi ed efficiente nel messaggio, vittima dell’autoindotta schizofrenia e, se non in anticipo, almeno al passo coi tempi.
Fu soprattutto l’emotività a salvare Heroes dal pozzo nero in cui invece cadde roba superiore come Taking Tiger Mountain, ed al di là delle rivalutazioni del vintage dei Novanta/Duemila (senza le quali io non sarei qui a scrivere) ancora una larga fetta di pubblico tende ad ignorarne il lato più interessante, il varco ove Bowie aspettava il proprio pubblico per testarlo, per sapere se era veramente pronto alla visione del proprio beniamino che una volta tanto andava per loro denudandosi.
Potremmo comodamente imputare il punk rock come possibile colpevole delle pieghe intime in alcuni personaggi già all’epoca rodati; eppure, proprio adesso che sono qui a schiacciar tasti con Street Hassle in sottofondo, non riesco a non pensare all’ultimo disco di Bowie come a un’uscita di scena volutamente sibillina ed arguta.
Se asserissi che il notevole gap fra The Next Day e Blackstar fosse preventivato mi prenderei dell’infame insensibile complottista, ma vi giuro, non avete idea di cosa pagherei per poter vedere la faccia di Dave in questo momento, dopo che la minestra ha avuto tutto il tempo di freddarsi.
Ad un primo impatto il disco è criptico, già dalla copertina le mani sono tese in avanti a preconizzare un clima non tanto catastrofico quanto pomposamente tetro, cosmico ma minimale. Bowie canta il jazz-lounge-pop di Lazarus in specularità rispetto a Young Americans: solito timbro, diversa consapevolezza, in un formato tutto sommato radio-friendly dalle atmosfere cupe che alla sua uscita mette la pulce all’orecchio ai più tagliati, anche per il testo di certamente poco riguardo verso il futuro sulla lunga distanza: “Look up here, I’m in Heaven/I’ve got scars that can’t be seen/I’ve got drama, can’t be stolen/Everybody knows me now” piuttosto che “I’ll be free/just like that bluebird/Oh, I’ll be free”.
Salvo poi smentire, in tasca a lui, con Blackstar, che più che un singolo è un mediometraggio (10 minuti). Il videoclip è senza dubbio d’impatto, senonché il pezzo mantiene un certo mood per poi troncarsi esattamente allo scoccare del quinto minuto: ecco che arriva come un treno la sezione che può essere isolata e trasmessa ai palati meno abituati all’ostico. Notare come Blackstar sia il pezzo più lungo mai prodotto da Bowie tolto Station To Station: ne deduciamo uno slancio sperimentale à là suite, nonostante la tenace Itunes avesse comunque imposto dei picchetti che costrinsero il cantante a sfrondare il pezzo di appena appena un minuto. La nenia raddoppiata
della voce è interessante, un richiamo alle atmosfere macabre di Outside, degno di menzione in quanto una delle estemporaneità più riuscite di Bowie.
Girl Loves Me esce loffia dopo il terzo ascolto, come dei Prodigy senili, e Dollar Days è degna delle cantilene anni ottanta scuola Frampton (comunque più garbata e composta nel tono); ciò che metto sotto il riflettore è Sue (peraltro risalente al 2014), davvero nevrotica e indicativa dello stato d’animo in cui di certo ha versato a fasi alterne Bowie durante le sedute di stesura, produzione e mixaggio dell’album, come l’esame di coscienza del mitomane. Qui sì che il soul strozzato e apocalittico del cantato si innesta a dovere nelle ritmiche trip-hop esagitate: lasciato solo in una camera di manicomio blindata e senza finestre, Bowie spettro scorrazza per la stanza messo davanti a sé stesso, ai suoi mille costumi, al trauma da abbandono, come se avesse voluto auto-disintossicarsi restando completamente cristallino e cercando di soffocare un ego che però ha avuto comunque la meglio come dimostrano i risultati di vendite immediatamente successive l’uscita dell’album.
Ho dovuto attendere almeno un mese e mezzo per procurarmene una copia, e appena aperta la porta di casa me lo sono sparato in cuffia. Quando la “sindrome da exploitation” ha avuto il sopravvento (film di serie Z la cui locandina risultava migliore del prodotto stesso) ho preso il disco e l’ho adagiato col mio usuale garbo tra Americans e Dogs. C’è rimasto fino ad oggi, e dopo un nuovo giro sul piatto ho potuto constatare come, sotto gli strati spellati via, niente altro resta che le solite marcate divergenze sempre avvertite in pressoché ogni lavoro di David Bowie: o la canzone mi esalta, o mi fa venire da grattare.
Tutti i preparativi erano stati approntati da tempo, e la tragicomica immagine dei ripetuti «Allora, quanto manca?» rivolti al medico per dare l’ok al distributore la custodisco per me, per addolcire la pillola della sua morte che effettivamente ritenevo (speravo) potesse avere un impatto più forte sul sottoscritto.
Per il resto Tony Visconti s’è riservato un tocco d’epitaffio con un comunicato post-scomparsa che, asciutto asciutto, suona più o meno così: “Come se già non lo sapeste”.
Pazienza, vuol dire che volevo più bene a Lou Reed.