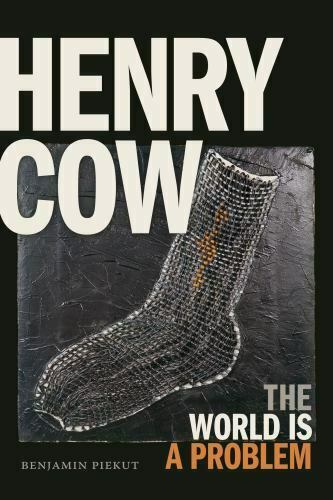HENRY COW: THE WORLD IS A PROBLEM
di Benjamin Piekut
Questo libro, che meriterebbe una traduzione italiana a dispetto delle scarse vendite previste, parla dell’unica band per ascoltare la quale chi scrive una volta è scappato di casa.
Inutile soffermarsi su quelle circostanze adolescenziali, certo non del tutto avventurose e che alla fine si conclusero con un loro concerto interrotto quasi subito per la pioggia, perché interesse del lettore è ovviamente il libro e non la biografia del recensore.
Tuttavia va detto che gli Henry Cow erano decisamente attraenti, quasi si potrebbe dire sexy.
Nonostante la loro apparente seriosità quello che comunicavano era un senso di entusiasmante avventura estetica, anti-conformismo e impegno politico ma anche un pathos travolgente e un grande desiderio di libertà dalle costrizioni comunicative ed estetiche del rock commerciale.
Inoltre erano tra le rarissime band nell’epoca di cui parlo – la seconda metà degli anni ‘70 – in cui suonavano delle donne che non fossero solo cantanti, arrivando a un certo punto a una parità numerica, dunque realizzando, più o meno consapevolmente, quelle che oggi si chiamano “quote rosa”.
La loro attività si è interamente svolta nei dieci anni intercorsi fra il ‘68, inteso anche in senso simbolico ed esistenziale, e l’avvento a livello globale delle politiche neo-liberiste, coinciso più o meno con il diffondersi del punk con tutto quello che questo significò, in termini di orientamento del pubblico, per tutta l’area del rock progressivo, di cui in un modo del tutto originale anche loro hanno fatto parte.
La crescente svalutazione dei contenuti di ricerca musicale (e impegno politico nella direzione della trasformazione del mondo e delle relazioni personali), unita alla sfrenata e tutto sommato cinica corsa al guadagno senza rischi da parte dei produttori musicali, furono infatti (al di là dei conflitti interni sui quali il libro si sofferma fin troppo) tra gli elementi più rilevanti che portarono alla fine di questo progetto che possiamo definire, senza timori, utopico, sia dal punto di vista della visione di una musica del presente proiettato nel futuro che da quello della creazione collettiva di un nuovo modo di vivere e condividere la produzione musicale.
Il libro di Piekut, Professore Associato alla Cornell University e già autore di un altro volume dedicato all’avanguardia musicale newyorchese negli anni ‘60, si sofferma in alternanza su questioni estetiche e musicologiche ma è anche un vero e proprio romanzo di formazione della stessa band inglese, dalle origini del duo fra Fred Frith e Tim Hodgkinson fino all’incontro con Chris Cutler e con coloro che, a fasi alterne, hanno fatto parte della band, prime fra tutte la polistrumentista Lindsay Cooper e la cantante Dagmar Krause che tanto contribuirono a forgiarne il suono e l’identità, al pari dei fondatori.
È certamente una storia complessa e forse difficile da comprendere per chi proprio non ne sa nulla o non ha vissuto quegli anni ma l’autore coglie nel segno quando identifica nel loro percorso quasi un prototipo di quella che lui chiama, con termine difficilmente traducibile in italiano, “vernacular avant-garde” e che può identificare tutta quell’area di musiche che venivano create allora, e in parte ancora oggi, da musicisti privi di una vera e propria formazione accademica ma il cui linguaggio e intenzione artistica li conducevano alla realizzazione di opere di grande complessità che ancora oggi è difficile decifrare del tutto, proprio perché utilizzavano fonti di ispirazione molto differenti.
Partendo dal linguaggio di compositori europei anche molto diversi tra loro – come Messiaen, Weill, Stravinsky etc – per giungere alla pratica dell’improvvisazione libera, passando per l’utilizzo di elettronica, nastri preregistrati, studio di registrazione ed altre tecniche innovative fortemente presenti nei loro dischi, nel corso della sua storia il gruppo non ha però tralasciato la forma canzone, l’interesse per le musiche tradizionali e in taluni casi pure la pratica e l’arte della “cover”.
Indubbiamente fu il primo contratto con l’allora neonata etichetta Virgin a consentirgli una fama che andasse oltre i confini inglesi ma ugualmente il loro percorso fin dalle origini è già attraversato da quei conflitti con l’industria discografica, non solo ideologici, che li porterà alle produzioni indipendenti dell’etichetta ReR, tuttora attiva e creata da Cutler proprio nell’anno di scioglimento del gruppo.
Uno scioglimento, potremo dire, nel “movimento” e che diede origine a vari spin-off oltre che a innumerevoli collaborazioni o carriere solistiche che durano ancora oggi, fino a una e vera e propria reunion che li vide nel 2014 tornare sul palco, in un paio di concerti in Inghilterra e uno in Italia, per eseguire la musica di Lindsay Cooper, scomparsa l’anno precedente.
È strano ripensare ora, in un’epoca in cui una musica del genere può forse raccogliere una o due decine di spettatori in qualche centro sociale, alla vicenda di un gruppo che suonò con Robert Wyatt nel ‘75, in una Piazza Navona gremita di pubblico.
E tuttavia il libro riesce a utilizzare la storia degli Henry Cow come paradigma di tanti fenomeni che vediamo ancora in atto nelle scene musicali e sociali della contemporaneità, fatta eccezione forse solamente per l’impegno politico diretto che pare ormai quasi completamente scomparso per essere sostituito da una specie di attivismo umanitario che molti musicisti esercitano principalmente attraverso i social network.
E anzi, a questo proposito, risulta ancora più interessante il confronto con la storia di un gruppo che ebbe come motto:”L’arte non è uno specchio, è un martello”, scritto a chiare lettere sulle copertine dei dischi e nei poster dei loro concerti.
Viviamo infatti nell’epoca in cui all’opposto molti, musicisti e non, credono di usare i social network come un martello, senza rendersi conto che non sono altro che uno specchio.
Il più delle volte nemmeno uno specchio che riflette la realtà ma solamente loro stessi.
In attesa della traduzione la versione originale in inglese è acquistabile presso la libreria Blutopia di Roma, anche via posta (https://www.facebook.com/blutopiastore/), oppure sul sito di ReR (https://www.rermegacorp.com/).