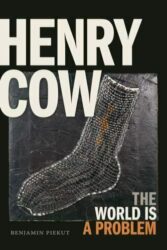Strano strumento la batteria.
Anzi, neanche uno strumento solo ma un insieme di strumenti, tamburi e piatti, da suonare tutti allo stesso tempo, come se fossero uno solo.
Strumenti, per lo più relegati sul fondo del palcoscenico a causa del grande frastuono che producono, ma tutto sommato protagonisti delle novità musicali più importanti del ‘900, il jazz e il rock’n’roll, con tutti i derivati e sub-derivati o commistioni dei due.
E anche coloro che si sono cimentati con questo strumento hanno uno strano destino che li vede o relegati in un ruolo da gregario faticatore – poco considerato dal pubblico attratto dalle star sulla front line, e tuttavia essenziale nel creare la pulsione ritmica delle musiche di cui sopra – o esaltati nella veste di virtuosi apparentemente privi, fatte salve alcune luminose eccezioni, di una particolare attitudine compositiva che non sia quella messa in evidenza in interminabili assoli, spesso generatori di una noia mortale in chi li ascolta.
Eppure senza questo strumento – che, al pari solamente dell’organo, si suona utilizzando in contemporanea due mani e due piedi – gran parte della popular music, che sia commerciale, indie o avant-garde, non esisterebbe nella forma e con la spinta ritmica che la contraddistingue, tanto da portare qualcuno a identificare questa musica, in modo indistinto, col “bum-bum” di fondo, come fece in televisione qualche anno fa Maurizio Pollini, pianista classico assai di rilevo, per l’occasione intervistato da Fabio Fazio (quest’ultimo peraltro, uno dei promotori del bum-bum, anche se perennemente in cerca di nobilitazione portando nel suo salotto qualche “intellettuale” o presunto tale).
Le cose si complicano ancora di più nel caso in cui all’uso delle due mani e dei due piedi si aggiunga quello della voce: le eccezioni ci sono ma in qualche modo tutte evitano di fare la due cose contemporaneamente, quindi o cantano o suonano, specialmente dal vivo.
Parliamo quindi in questo testo di due di queste eccezioni che hanno trovato il modo di fare le due, anzi le tre, cose insieme: batteristi, cantanti e pure compositori.
Robert Wyatt non credo abbia bisogno di presentazioni, la sua fama è ormai trasversale e le sue collaborazioni pure, è una figura di culto, dai tempi dei Soft Machine a oggi, per molte generazioni di musicisti e ascoltatori.
Ci si può chiedere quale sarebbe stato lo sviluppo della sua doppia attività se un incidente nel 1973 non lo avesse paralizzato e costretto sulla sedia a rotelle, impedendogli così di suonare interamente la batteria come fece in tutto il decennio precedente, sia nei Soft Machine che nel gruppo successivo, da lui fondato, chiamato Matching Mole.
E in entrambe le situazioni essendo la voce solista principale.
La domanda ovviamente non ha risposta perché Wyatt da allora si è completamente reinventato creando, nelle sue produzioni discografiche, qualcosa di unico e che si può definire solo col suo nome.
Di questo unico indefinibile tratta in un certo senso il libro di Michele Giuseppone, uscito nel settembre del 2021 per Crac Edizioni e intitolato, un po’ genericamente, “Opinioni e suoni del XXI secolo – A colloquio con Robert Wyatt”.
E lo fa nel miglior modo possibile, cioè lasciando ampiamente la parola al diretto interessato, il quale lo fa nel miglior modo possibile, non rispondendo o deragliando o divagando, per poi sempre ritornare a chiedere al suo interlocutore “qual era la domanda?”.
Esistono già diversi libri in italiano dedicati al personaggio, va detto, ma questo si distingue perché non raccoglie interviste già pubblicate e non è un saggio o una biografia.
Semplicemente l’autore cerca del materiale per la sua tesi di laurea e, con la sfrontatezza di chi ha vissuto il mito solo di riflesso, chiede un’intervista (nel 2011 ormai) al musicista inglese che il padre gli ha fatto conoscere già in tenera età.
Non si sa perché il libro esca solo ora, a dieci anni di distanza, ma è ugualmente consigliabile sia ai maniaci (che probabilmente scopriranno qualche aneddoto inedito) sia ai neofiti che vi potranno trovare comunque spunti di riflessione tali da indurli poi ad approfondire l’ascolto della musica di Wyatt (o di una delle sue innumerevoli partecipazioni a progetti altrui in veste di vocalist).
Nonostante qualche strafalcione in veste di traduzione, il volume si può leggere tutto di un fiato e anche rileggere per meditare ulteriormente sulla comunque notevole mole di informazioni e riflessioni che propone.
Robert Wyatt non si fa pregare e come suo solito interviene sui temi più disparati: dall’importanza dei sottotitoli alla musica cubana, dall’educazione cattolica dei suoi nipoti al racconto dei suoi inizi al club UFO di Londra, dalle innumerevoli considerazioni sulla musica sua e altrui alla cucina e la politica (sempre fedele al suo internazionalismo marxista con qualche venatura anarchica) e passando per momenti più spontaneamente filosofici, gli spunti sono pressoché infiniti e costituiscono una specie di summa, del tutto temporanea e frammentaria, del pensiero wyattiano.
Un pensiero che nasce da ogni sua esperienza, sia musicale che corporea o vocale o esistenziale, senza però perdere l’immediatezza di una conversazione nel giardino di casa, fra una tazza di the e l’altra, sorseggiata insieme ai due interlocutori italiani (uno funge da interprete perché l’autore candidamente ammette fin dall’inizio di non sapere molto bene l’inglese).
E naturalmente in compagnia della inseparabile moglie Alfreda Benge, autrice di molti testi delle canzoni di Wyatt nonché, da più di quarant’anni a questa parte, delle bellissime copertine di quasi tutti i suoi dischi, oltre che sua insostituibile voce critica, sia in riferimento all’alcoolismo dal quale pare aver più volte tirato fuori il marito o più semplicemente alle sue produzioni discografiche.
Chissà invece se Mariá Portugal ha mai ascoltato “End of an ear“?
Il recente album della cantante e batterista brasiliana – “EROSÃO” uscito nel 2021 in contemporanea per l’etichetta tedesca Fun In The Church e la brasiliana Selo Risco – pare infatti una versione tropicale e digitale dell’esordio solista di Wyatt uscito nel 1970 (quindi ancora prima dell’incidente che gli avrebbe poi impedito di usare la metà inferiore del suo strumento) e in qualche modo anche del successivo, il celeberrimo “Rock Bottom“.
Il disco, registrato in Brasile nel 2019 è stato poi completato in Germania, dove Mariá Portugal vive tuttora, in seguito a una prima residenza creativa offertale dallo storico Festival di Moers nel 2020 e poi forse a causa anche delle restrizioni che impediscono a lei – come a tanti altri musicisti delle giovani generazioni abituati a viaggiare di continuo e a stabilire contatti in tutto il mondo tramite internet – di proseguire l’attività nel suo paese di origine o altrove.
E se Wyatt nei primi anni ‘70 usava ancora lo studio analogico con supporti su nastro per le sue geniali sperimentazioni con la voce e i primi effetti elettronici, Mariá Portugal invece è già compiutamente evoluta nel costante flusso di informazioni sonore dell’epoca digitale, potendosi permettere di costruire i suoi brani quasi a strati, inserendo interferenze e rumori, sovrincidendo editando e utilizzando anche, nella traccia finale, qualche field recording amazzonico.
Non troviamo però nel lavoro di Mariá Portugal l’uso strumentale della voce, quello stralunato e surreale scat in falsetto che invece Wyatt utilizza a piene mani in alcune tracce di quel suo primo disco di cui pure si accenna in un capitolo del libro.
No, la musicista e improvvisatrice brasiliana – già collaboratrice della cantante Elza Soares e di altri musicisti della scena sperimentale di San Paolo – si rifà decisamente nella sua vocalità al linguaggio e alla tradizione della MPB (Musica Popular Brasileira), riattualizzandone le melodie e i temi, cantando testi poetici, suoi o di altri, e forse avvicinandosi di più al Wyatt creatore di meravigliose canzoni fuori-asse, nei suoi dischi più conosciuti.
E, quasi a riportarci alla mitica “Sea song“ wyattiana, i testi del cd, rintracciabili su Bandcamp, hanno molti riferimenti al mare, ai litorali e le spiagge, e paiono quasi evocare una “eros/ione” che è quella dei territori minacciati dal global warming e allo stesso tempo dei sentimenti possibili nelle relazioni fra gli umani, così difficili e complicate già nell’epoca precedente alla pandemia.
Fino ad arrivare – nella versione live del progetto ben documentata dal video registrato di recente al JazzFest di Berlino – a invocare nella “cover” di un brano di Clara Nunes presentato in chiusura di concerto – e quasi come se fosse un mantra propiziatorio – un amore che “será eterno novamente”.
E su questo brano, intitolato non a caso “Juizio Final“, possiamo chiudere il cerchio: il tappeto elettronico sovrapposto alla tromba e ai sax non può che rimandare al fraseggio free e denso di pathos di Mongezi Feza e altri musicisti che Robert Wyatt ha sempre lasciato muoversi liberamente all’interno delle sue canzoni, generando oggi un’atmosfera davvero inedita, dove la personalità della compositrice e leader si afferma come una delle più interessanti e originali nella scena della nuova musica mondiale, senza definizioni e senza confini, aperta a ogni suono e a ogni singolarità dell’esperienza umana, in un ideale contatto con la stagione degli anni ‘70 cui pare rifarsi idealmente questo progetto.
C’è in questo finale commovente un contrasto fra lo spazio infinito e le contingenze frenetiche dei corpi sonori che Mariá Portugal riesce a ricreare anche cessando di suonare la batteria e limitandosi al canto, adattandolo ai bisogni emotivi di questo tempo, sospesi come siamo fra l’immobilità del distanziamento e il bruciante desiderio di una qualche vicinanza corporea che ci faccia almeno sentire ancora vivi.
LA PULSAZIONE DELLE PAROLE – Mariá Portugal e Robert Wyatt