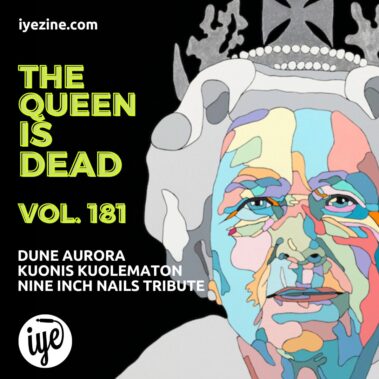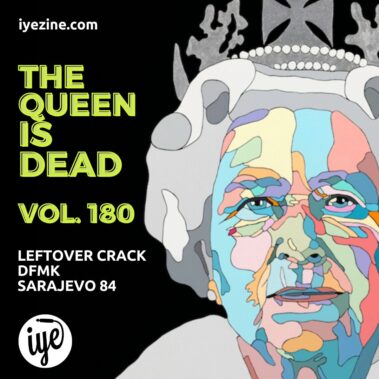Richard Matheson, scrittore e sceneggiatore statunitense conosciuto soprattutto per il romanzo Io sono leggenda (I Am Legend, 1954) trasposto nella versione cinematografica omonima dal regista Francis Lawrence nel 2007, negli anni Settanta scrisse un racconto che sarebbe stato una straordinaria musa per un regista d’eccezione: Steven Spielberg.
In realtà, la trasposizione di Lawrence è il terzo film basato su questo romanzo, i due precedenti furono L’ultimo uomo della Terra, The Last Man on Earth di Sidney Salkow e Ubaldo Ragona, 1964, e Occhi bianchi sul pianeta Terra, The Omega Man di Boris Sagal, 1975.
Il racconto in questione è Duel (Duello) che Matheson pubblicò nel 1971 sulla rivista Playboy.
In Italia comparve nel 1993 grazie a Garden Editoriale, in Brivido a 35 mm (Horror Story, 14) e, più di recente, nella bella antologia Duel e altri racconti (Collezione Immaginario, Dark, 24; Fanucci, 2005) con una introduzione di Ray Bradbury e su traduzione di Maurizio Nati – un’antologia che raccoglie 18 racconti a tematica fantascientifica, tutti degli anni Cinquanta ad eccezione di Duel.
Sull’antologia pubblicata da Fanucci, il cui titolo in inglese è Duel Terror Stories By Richard Matheson (2003), poche parole: Matheson è un maestro di storie brevi. In ogni singolo racconto dà prova di compiuta perfezione, sviluppa un’idea nuova, plastica, indimenticabile, e mondi e atmosfere originali. Si va dallo sconvolgente allo spiazzante, da una malinconica realtà a una desolata accettazione, dall’incredibilmente credibile alla previsione oscura, da futuribili distopie a calcolate pazzie.
L’eccezione del racconto Duel, che dà il titolo alla raccolta, non sta solo nel tempo in cui fu scritto, ma anche nel genere non prettamente fantascientifico comune invece a tutti gli altri racconti, ascrivibile piuttosto a una definizione di thriller orrorifico, e dove orrorifico non significa mostriciattoli splatterosi e grossolano timore, ma fa capo a quel sacro orrore per l’ignoto che sconvolge qualsiasi entità umana si sporga anche solo per vederne il riflesso.
Rappresentare l’ignoto non è mai cosa facile, e la metafora che Matheson sceglie di utilizzare per raccontarcelo si rivela tanto semplice quanto profonda.
Un uomo, il comunissimo signor Mann, è in viaggio per lavoro e si trova alla guida della sua berlina lungo la statale che porta a San Francisco. Ne avrà per parecchie ore. Intorno, l’onnipresente sfondo di un paesaggio desertico e abbandonato. Alle 11 e 32 decide di sorpassare una fastidiosa e maleodorante autocisterna, una banale decisione che non solo gli cambierà la giornata e i programmi precipitandolo in un incubo sempre più grande, ma anche l’attitudine alla vita.
La prima domanda che si impone e non lascia spazio ad altro è: perché? Questo continua a chiedersi all’inizio il signor Mann, con una incredulità che via via si fa sempre meno ingenua. Dopo, non ci sarà più il tempo.
Su Duel-film, designato come l’esordio di Steven Spielberg, allora venticinquenne, esiste una letteratura sterminata. La versione di Spielberg era inizialmente destinata al pubblico televisivo e fu girata con pochi mezzi e in soli tredici giorni (!), contro i dieci che addirittura gli aveva ordinato la produzione in ossequio ai tempi televisivi. Fu un successo tale che ne seguì quasi subito la versione cinematografica, distribuita anche in Europa, Australia e Giappone, aumentata da 74 minuti a 90.
Con questo lungometraggio, il regista statunitense segnò il debutto cinematografico e l’inizio del suo successo.
La sceneggiatura fu scritta dallo stesso Matheson e il film poco si discosta nei punti sostanziali dal racconto. Il protagonista, interpretato da Dennis Weaver (imposto a Spielberg, ma lui l’adorava e sapeva che era l’artista giusto), è anche l’unico vero attore perché gli altri personaggi sono del tutto secondari, seppure caratterizzati magistralmente. Un attore che incarna splendidamente il luogo comune del mite e onesto uomo americano a cui d’un tratto s’incrina il mondo, in un crescendo di tensione e violenza fisica e psicologica, acuite dal paesaggio o dai comportamenti in apparenza assurdi di coloro in cui si imbatte. Assurdi perché il punto di vista è sempre il suo, non c’è un’angolatura oggettiva nella regia di Spielberg. Lo spettatore è il signor David Mann, guarda con i suoi occhi. Perché Duel, più che un film da vedere, è un film da provare.
Per riuscire a fare questo, Spielberg arrivò perfino a installare delle telecamere sugli autoveicoli o sopra le ruote, sperimentando tecniche di inquadratura nuove per l’epoca e ottenendo effetti così dinamici e tangibili che al pubblico sembra di toccare con mano l’ansia crescente in cui si avviluppa l’azione.
L’autocisterna, un Peterbilt 281 del 1955, con il suo muso antropomorfo e il motore dalla sonorità aggressiva, fu una scelta ottimale per rendere il crescendo di inquadrature sempre più cupe e angoscianti, rese ancor più minacciose da particolari angolature di ripresa dal basso rispetto allo sfondo per aumentarne l’effetto dinamico.
Alla luce della filmografia successiva del regista, molto si è detto di Duel.
La critica lo ha spiegato in termini di inquietanti rapporti tra uomo e macchina e uomo-macchina, oppure nel complicato gioco che intercorre tra preda e predatore. Ha visto l’obiettivo di sfatare e ridicolizzare status symbol come quello dell’automobile o la mitologia dell’eroe western. Ha promosso paralleli con l’epica cavalleresca e i suoi codici di combattimento fatti di scambi e attese. Ha sollevato paragoni simbolici come quello biblico di Davide e Golia o letterari come lo scontro tra il capitano Achab e la balena bianca nel Moby Dick di Herman Melville. Addirittura mi è capitato di leggere, a proposito di Duel, di una supposta immaturità di Spielberg perché, certamente Spielberg ha saputo riconoscere la necessità della ribellione e di un uomo nuovo, ma non ha saputo identificare questo uomo nuovo nell’uomo che nasce dall’analisi e della lotta marxista.
Mah, nel Duel di Spielberg ci vedo ben poco di un homo politicus o oeconomicus. Perché li travalica senza pietà sapendo bene che, da qualsiasi parte si stia e a qualsiasi credo si sia votati o si faccia finta di aderire, esiste un momento comune nell’essere umano ed è quel momento in cui c’è un gesto da fare e lo si può fare solo in piena solitudine e autonomia.
È il momento in cui l’essere umano ha l’occasione di affrancarsi e diventare un uomo creativo, superando quello che sembra essere un ostacolo esterno e mortale, ma che in realtà si rivela per un superamento di se stessi. Ricco o povero, stupido o intelligente, furbo o sfortunato (e tutta l’immane sequenza di etichette affibbiate o autoaffibbiate), è quel momento assolutamente privato in cui si gioca una partita mortale con se stessi e, se superato, ci si evolve. Quel momento dopo del quale si potrà dire: sono vivo.
Non è l’aggregazione a un sistema o a un’idea che produce l’uomo nuovo, il processo di cambiamento è un atto di volontà interiore che, sperimentato, si riflette anche all’esterno. È un atto creativo di autodisciplina e non un’adesione a uno schema. Lo schema, semmai, viene dopo perché scelto deliberatamente, se scelto, o autoprodotto.
Spielberg spiazza fin dall’inizio tutta questa zavorra di consensi comuni, sovrastrutture e ideologie, con il suo perché che si riverbera sommesso per tutto il viaggio plasmando quell’ignoto di cui parlavo all’inizio, come un velo buttato per rivelare ciò che altrimenti resterebbe invisibile e impalpabile. Motore d’avvio e unico punto fermo nel non-catalogabile, dove la risposta non è importante. Perché il velo non è l’ignoto, è solo il mezzo che permette di farsene un’idea.
Anche per questo motivo il suo è un capolavoro che tiene il tempo, basta guardarlo (provarlo) con la facoltà sublime che hanno gli occhi semplici di un ragazzino.
Evitare di leggere i commenti, i commentatori hanno dato anteprime fondamentali.