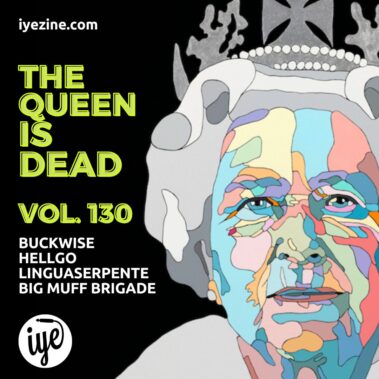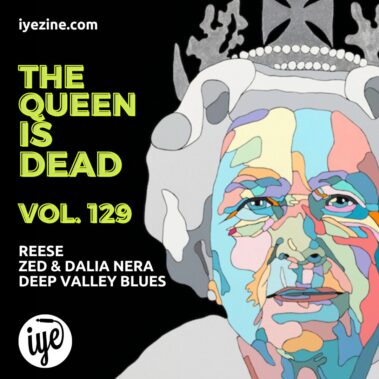Il panorama letterario che ci ha dispensato negli anni cronache di storie di tossicodipendenza, e in particolare sull’eroina, è vasto e ha la peculiarità, almeno nei titoli noti, di possedere timbri specifici per l’epoca e per l’ambiente in cui sono stati raccontati. Di quelli strettamente cronachistici, o dalla narrazione iperrealistica che dir si voglia, nei quali la maniacalità dell’esposizione delle azioni, degli accadimenti, delle peculiarità anche scabrose insite in una storia di droga, non possiamo non citarne qualcuno, ognuno distinto dagli altri da un luogo/città diverso, da un periodo storico differente, da tutte quelle sfumature distinte ma insieme anche gemelle che un resoconto di tal genere possiede, deve possedere, perché a conti fatti la dipendenza da stupefacenti, i drammi insiti e gli espedienti sono un filo rosso che collega lo sballo nel tempo e nello spazio. Quindi è doveroso citare il mostro sacro, El Hombre Invisible, il demiurgo della droga William S. Burroughs col suo “La scimmia sulla schiena” del ’53, vero e proprio primo sconvolgente resoconto della tossicodipendenza moderna. Una cronaca fredda e lucidissima e un’accusa al sistema socio-sanitario americano. Poi abbiamo “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino” del 1978 che è un must anche grazie al film di Uli Edel, e ci narra senza mezze misure l’eroina che dilagava nella Berlino di quegli anni. In “Drugstore cowboy” vengono narrati i deliri della droga e le rapine in un Oregon del ’70 tutta da saccheggiare per una dose senza fine e montagne di psicofarmaci. In “Traispotting” Irwin Welsh ci trasporta in Scozia, e con vena surreale e chirurgicamente sconcia ci trasmette l’apatia e l’orrore umano di una dipendenza scorticante, alienante. Ma come Burroughs ci ha detto: “La droga non è, come l’alcool o come la marijuana, un mezzo per intensificare il godimento della vita, la droga non è euforia. È un modo di vivere.”
Ecco dunque come il libro di Paolo Battista, “Siamo tutti figli di Caino”, si inserisce tra questa fiera letteraria che al posto dei denti possiede siringhe appuntite, con la disperazione di un modo di vivere che si ricicla continuamente, che con costanza si ripete nelle epoche, con gesti e assuefazioni identiche, con dannazioni della carne che fotocopiandosi nel tempo ci regalano però ambienti diversi, crude emozioni di un mondo occulto ai più seppur vivente alla luce del sole, quella terra di mezzo di una corte dei miracoli col vizio dello sballo.
“Siamo tutti figli di Caino” è un quadro di caratteri tossici in una Roma del 2000, caratteri cesellati nella rappresentazione accurata, nel modo di parlare autoctono che ci riporta in qualche modo ai ragazzi di vita pasoliniani, accomunati ad essi anche dalla vita disperata, dall’espediente come leitmotiv di giornata, dal conturbante randagismo caratteriale.
E di Pasolini, Battista ci regala anche il nome del protagonista, Pierpaolo per l’appunto, che poi non è altro che lo pseudonimo dell’autore stesso.
Pierpaolo vive la vita del tossicodipendente relegato nel proprio copione di buchi giornalieri, di bevute di birra al cospetto dei muri e del giardinetto adiacente al ser.T., di una relazione sentimentale importante, sessuale, tenera, ma anche difficile. E’ un viaggio, questo racconto, forse triste, e sicuramente crudo, un viaggio in un quadro ad alto contrasto tra spade risanatrici e sciroppi metadonici, alle spalle la turbolenta flora e fauna romanesca, con traffico transumante e caos generalizzato annessi.
“Siamo tutti figli di Caino” è un romanzo che scorre veloce, senza fraintendimenti, con un lessico dinamico e avvincente. Paolo Battista sa vivisezionare la realtà tossica capitolina esponendoci i suoi organi ancora pulsanti, questa battaglia di ogni giorno che si svolge per i cristi metropolitani la cui passione è lo sballo, donati al disinnesco della propria anima in quel campo minato che è quell’anima più grassa e marcia e avida della città e dei bisogni – della città del Bisogno.
Quindi forse questi ultimi, i tossicodipendenti, assurgono a veri antagonisti del Potere e dello status quo dominante, ma incanalati loro malgrado in un altro e più ghettizzante stato di dipendenza: la droga dunque come ribellione ma inevitabilmente come abisso. E tutto si gioca nella narrazione tra quei pochi metri d’asfalto tra un giardinetto e il ser.T (quello spazio quasi liturgico che nel libro viene chiamato “arena”), tra la ricerca del pusher e le pere sui bus e nel sottosuolo di un supermercato, tra i racconti delle rapine e i guai familiari, tra le callose e puttane vie di Roma, alla mercé di una bulimica bucomania, di una ricerca angosciata di una via di fuga.
“Guardo l’arena, oggi piena di reietti, tossici, stranieri, precari, e penso che sono gli ultimi rivoluzionari di questo inizio secolo. Anche se loro non se ne rendono conto, non lo sanno ancora e forse non lo sapranno mai. Colpiscono il sistema con la loro delusione, la loro rabbia, il loro disprezzo, il loro dolore: la loro, la nostra vita imperfetta!”
Non manca nel libro una forte denuncia al sistema sanitario del ser.T che somministra altra droga ma legalizzata creando solo riserve indiane criminali, alla follia di un carcere che ammassa gente come corpi senza speranza, agli abusi di potere delle forze di polizia, alla società del consumo che spappola i cervelli. Un sistema che forse cattura i balordi e lascia liberi i veri criminali istituzionalizzati.
“Ciò che rende fatalmente triste l’arena siamo noi stessi, costretti a vedere l’uno con l’altro il riflesso di una vita perduta, allo sbando, dove scetticismo, cinismo, violenza, rabbia sono presenti tra le rughe e il sudore che intarsia i nostri volti: fottuta vita vissuta, quel che resta di esistenze complicate, abbindolate per anni dalle promesse di una società controllata dal mercato senza capire che è proprio questo cercare di affermarsi, questa ricerca della perfezione e del potere a tutti i costi che porta allo sfacelo, quando tutti potremmo farne a meno e vivere con più serenità.”
Certo, la storia di Paolo Battista avrebbe potuto avere un più ampio respiro, dilatarsi tra le storie di queste vite allo sbando, tra le trame di questi protagonisti a cui ci si affeziona per la loro umanità delinquenziale ma in un certo modo pura, senza mezzi termini. Ma forse invece è anche giusto così: che una storia tossica si avviti su se stessa fa parte della sua natura, come l’affanno in un girone dantesco, come un ago che trafigge il derma giorno dopo giorno in maniera uguale, monotono e brutale.
Dunque un libro da leggere con diverse chiavi di lettura, un crudo resoconto di una storia moderna, uno squarcio semantico di lucida narrazione da bassifondi, la naturale lettura per chi è appassionato a quelle storie che non dicono bugie e che sono lì, per essere palpate