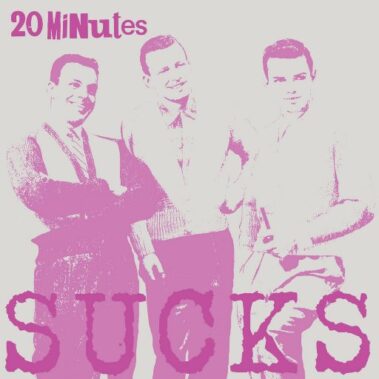Abbiamo recensito il nuovo disco di Path qualche tempo fa. Personalmente, lo seguo dai tempi del punk (ha suonato in band importanti per la scena come Automatica Aggregazione e Gli Ultimi), da quanto avevamo la testa rasata, le Dr Martens e ci scambiavamo le fanzine che scrivevamo e fotocopiavamo.
Questo quarto album del suo corso solista, diversissimo dai precedenti, è la riconferma che abbiamo a che fare con un artista di grande spessore, sensibilità e cultura.
Abbiamo fatto una chiacchierata assieme a lui e mi accorgo che abbiamo parlato dell’album, scavando letteralmente al suo interno e nel suo immaginario, senza quasi mai parlare direttamente dell’album e dei suoi pezzi.
Ne è venuto fuori un interessantissimo confronto sui riferimenti letterari, cinematografici, umani ed ovviamente musicali dell’artista.
1) Più che del cambio stilistico voglio iniziare parlando del cambio nella tua voce e nel tuo sguardo, perché mi sembra, correggimi se sbaglio, di sentire da ogni brano che la svolta c’è stata in Path come uomo.
Alla vigilia di questo disco ci sono stati un paio di cambiamenti personali importanti che hanno sconvolto tutto. Essendo questo un disco “aperto”, ovvero in continua modifica anche durante le registrazioni, credo che la transizione personale in qualche modo si avverta.
Ho inciso “Hombre Lobo Sessions” in condizioni psicologiche non adatte per la registrazione di un album, “Cinema” doveva essere il mio riscatto in studio: metriche sciolte, pezzi “in divenire”, musica piena di groove come quella che ascoltavo da ragazzino. Non mi sono mai divertito tanto a fare un disco, forse un’altra volta solamente con “Storie da un posto qualunque” de Gli Ultimi.
Quello che è diverso al livello di testi è appunto lo sguardo: non più confidenziale, ma “cinematografico”, non più raccontare una storia, ma descrivere una scena che immaginavo di vedere davanti agli occhi. Mi posso permettere di essere cosi preciso perché lo stile di narrazione l’ho deciso coscientemente.
Paradossalmente, in “Cinema”, sono stati tanto definiti gli intenti tematici, quanto istintivi quelli musicali.
2) Ti ho sempre associato ad un piccolo Martin Eden di provincia, costantemente in viaggio fisico e soprattutto culturale. Poi ascoltandoti mi vengono in mente altre letture importanti come “Il tallone di ferro” e “Il popolo dell’abisso” di cui sei e ti confermi essere una delle voce più delicate e profonde. Quanto Jack London c’è nella tua opera?
Meno di quanto vorrei, temo.
London è per me quello che un intellettuale dovrebbe essere, con la testa tra le nuvole ma attaccato alla vita cruda, un viaggiatore instancabile che assorbe esperienza come una spugna. E’ quello che dovrei essere, che ero e che non so se sarò più.
Il mio spirito d’avventura si è abbastanza inaridito nel tempo, ma continuo ad andare a tornare, forse perché è una delle poche cose che sono sicuro di saper fare.
Con Martin Eden condivido una storia: un figlio di nessuno dalle classi popolari impara da solo a scrivere testi, respinto e osteggiato dalla borghesia. Martin/Jack riesce nell’impresa, io ci sto ancora lavorando.
3) Gil Scott Heron e Sigaro. Non la voce di chi non ha voce, perché mi sembra quasi che chi non ha voce oggi non ha più coscienza. Loro sono stati, invece, la coscienza che l’artista proletario vuole risvegliare.
Personalmente faticherei a vedermi come la voce di qualcuno, non sempre riesco nemmeno ad essere la mia. Con la parola “artista” , nonostante non mi piaccia per niente, credo tu abbia centrato il punto. Quello che distingue un menestrello/cantacronache dai personaggi che hai citato è proprio il senso d’arte e di poesia, che permette loro di toccare corde di coscienza più profonde di un cantastorie classico, che racconta i fatti per come sono avvenuti, utilizzando un’armonia standard. E’ l’amore per la musica, oltre che per il messaggio, che ha reso unici Gil Scott Heron, Sigaro, Joe Strummer, Billy Bragg, Chris Dean.
L’urgenza di risvegliare coscienze non è la presunzione di aver capito tutto, ma semplicemente sapere di avere una corda sensibile che vibra più facilmente che nelle altre persone, e sentire il dovere di farlo notare.
Il prezzo che si paga per questo ruolo, spesso, è l’enorme sacrificio della vita stessa.
4) Lo squallore nel quale siamo immersi, di giorno per il lavoro, di notte per dimenticare il giorno precedente. Claudio Caligari.
“Muoio come uno stronzo, e ho fatto solo tre film”. Peccato che parliamo di “Amore Tossico”, “L’odore della notte”, “Non essere cattivo”. “Capolavori” lo lascio gridare agli esperti di cinema, fatto sta che parliamo di pellicole intense, crude, reali, commoventi.
E troppi narratori intensi, crudi, reali e commoventi abbiamo lasciato morire soli e abbandonati in questo paese.
I quartieri di notte sembrano esalare l’angoscia verso l’alto, come a formare una nuvola, ognuno l’ammazza come sa, come può, come e se ci riesce.
Poi c’e’ la sigla del TG5 delle 7 e tutto ricomincia.
Se Caligari avesse saputo a cosa andava incontro, avrebbe fatto tutto lo stesso, perché per quelli come lui conta la “storia”, conta il lavoro, prima di tutto, prima di se stessi anche.
5) Eccoci infatti ad un altro tema dei tuoi brani. Gli anti-eroi solitari che sembrano vivere solo per se stessi, come possono più che come vogliono. Sopra una bicicletta consegnando una pizza o su uno scooter andando “in città” a consegnare un curriculum. Sergio Leone e John Fante.
E’ quando li vedi ridere al bancone di un bar, mano nella mano con la figlioletta, che ti commuovi e non puoi capacitarti di dove prendano tutta la forza che hanno.
Uomini e donne fatti e finiti, trattati come ragazzini di bottega, corrono al buio in motorino di notte prendendo schiaffi e insulti a destra e sinistra. Eppure non li stai piegando, come il Clint Eastwood torturato da Mario Brega, stai infierendo su un corpo inerme, ma ti stai anche condannando a morte.
Il capitalismo toglie la faccia alle persone, diventano il ruolo che ricoprono: così il muratore che ha preso ordini tutto il giorno finisce che se la prende col rider del sushi, la sera, senza capire che sono perfettamente sulla stessa barca: la vittima del giorno diventa il carnefice della notte.
Poi c’è chi siede davanti a un foglio bianco ore ed ore per farsi venire un’idea, con due arance per cena come l’Arturo Bandini dei “Sogni di Bunker Hill”, ma questa è un’altra storia.
6) I ragazzi di vita, le borgate, Anguillara ed i palazzoni della 167, i baretti e le Peroni stappate per noia. Non c’è nulla di romantico o romanticizzato nei tuoi brani. Un Pasolini letto con gli occhi di Paul Weller.
E’ quello che accade quando il narratore è organico alla storia che racconta.
Non potrai mai trovare la fascinazione che Pasolini, De Andrè o De Gregori subivano dal proletariato, da estranei, in una storia mia.
Quello che vedo coi miei occhi ha già una gelatina di romanticismo attorno, basta e avanza, mi limito a descriverla per come la vedo.
Vedo fotografie, con questi occhi, che non ti lasciano il tempo di prendere la macchinetta e scattare, sono già lì, nessuno si è messo in posa.
Ogni cosa che faccio è fotografata e poi ricostruita in studio, come se fosse un’estrema e azzardata sintesi tra la poetica di Pasolini e quella di Fellini: è tutto vero, ma è tutto ricostruito.
Per questo, scherzando, dico sempre che farò la fine di Shellburn su “God’s Pocket” , il giornalista che per trent’anni aveva raccontato vizi e virtù del suo quartiere, linciato infine dalla folla inferocita per la sua indiscrezione.
7) L’America, come concetto ideale prima che geografico.
L’America è la contraddizione vivente, fascino puro, ho visto gente perdere la testa per l’America. E’ il paese che ha influenzato i cantautori italiani che preferisco, strappandoli al monopolio del modello chansonnier francese: il folk di Guccini e De Gregori ancorato a Dylan, Dalla e Battisti che azzardano la pista di Otis Redding e Wilson Pickett, Colle Der Fomento e James Senese che inseguendo gli americani inventano un nuovo linguaggio.
Le mie considerazioni sull’America sono confinate alla narrazione: mi ha dato le canzoni di Guthrie, Seeger, Dylan, Van Zandt, Springsteen; le parole di Steinbeck, Kerouac, Ellroy, Hemingway; il cinema di Scorsese, Coppola e Spike Lee.
E anche, perché no, la musica di Rancid, Social Distortion, Bad Religion, Avail.
L’America è il luogo dove un disastro di proporzioni colossali come la crisi del ’29 partorisce un’onda di cultura di cui tutto il mondo beneficia ancora oggi. E’ incredibile e sconvolgente.
8) E gli anni 80 inglesi, quel senso di decadenza e la disperazione nel riscatto.
A livello musicale l’Inghilterra è come la Giamaica, una continua rielaborazione dei suoni americani, ma disossati dalla pomposità, ridotti all’osso.
Volendo fare un disco – passatemi il termine – soul/ rhythm and blues, ci è venuto naturale guardare al Regno Unito dove Rod Stewart, Billy Bragg, The Redskins, Paul Weller, impregnati di musica statunitense ma proiettati alla canzone d’autore, rielaboravano quelle sonorità filtrandole attraverso un temperamento a bassa tensione, all’inglese.
Io sono da sempre appassionato di rhythm and blues USA, ma dischi come “Every Picture Tells A Story”, “Neither Washington Nor Moscow”, “Wild Wood” strappavano un compromesso tra black music, snellezza e politica dal basso assolutamente irresistibile, ci ha permesso di puntare ad un modello che eliminasse un’autoreferenzialità del genere, che non ci apparteneva.
9) In finale, qual è la morale di questo film, se ce l’ha?
Non c’è nessuna morale, se non quella che rivolgo contro chi comanda: se non cambia il modello sociale, un giorno tutto quello che avete fatto si rivolterà contro di voi, garantito.
Quanto al resto, il concept dell’album è riassunto tutto nella prima traccia, Lakon.
Non voglio insegnare a nessuno come vivere, sarebbe il colmo, mi limito a descrivere quello che vedo, quello che mi piace e quello che mi dà il voltastomaco, cercando di cambiare dalle piccole cose.
Non odio il genere umano, non tifo estinzione come va molto di moda oggi, credo ancora nelle persone.
10) Per chi canti? Qual è e quale vorresti fosse il tuo “pubblico”?
Non me lo sono mai chiesto. Finora sono come un pianista da saloon, la gente beve e io canto le mie canzoni, nessuno ha mai pagato un biglietto per venire a vedere me.
Potrebbe anche andare avanti così all’infinito per quello che mi riguarda, gente comune, anche se alle volte gli artisti “orientati” dimenticano cosa vuol dire suonare per un pubblico eterogeneo, cosa che implica disaccordi e critiche. A volte i locali non ti chiamano più, perché il loro pubblico non vuole sentire questo o quel tema trattato.
Questo non significa però che io desideri chiudermi nella “confort zone” di quelli che la pensano a grandi linee come me.
Le persone che mi seguono assiduamente me le porto dietro dall’ambiente punk, sono cresciute culturalmente insieme a me, accettando gli sbalzi di stile ed espressione che questo comporta.
In definitiva io voglio solo scrivere la mia roba, avere un tetto sulla testa e mangiare due volte al giorno, quello che eccede è tutto di guadagnato.
11) Un’ultima domanda, la meno importante probabilmente: vedi te stesso come un cantautore erede di quella tradizione o come un punk che suona bene e cura i testi?
Vedo me stesso come un uomo che scrive.
Ho attraversato il punk vivendolo come uno dei mondi più incredibili mai conosciuti, ma restavo e resto estraneo a parte dei suoi principi e del suo background.
Rimango legato fortemente alla scena, mi ha cresciuto da ragazzino e mi ha dato spazio per dire quello che volevo, a volte liberamente, a volte facendomi assumere la responsabilità delle mie parole, come è giusto che sia.
Questa scena contiene ancora molte tra le migliori persone che conosco.
“Cantautore” dovrebbe essere la traduzione di “songwriter”, ma la figura dell’autore folk è incastrata inesorabilmente nel passato, quella dei nuovi cantautori alla moda non mi permette di sentirmene parte. Sono un uomo che scrive, qualsiasi cosa, su qualsiasi supporto. Una volta scrivevo sulla carta del cemento, oggi sul MacBook. Adesso scrivo le canzoni, domani vai a capire che succede.
Quello che mi interessa è che questa giostra permetta a quello che scrivo – che lo faccia bene, male, giusto, sbagliato – di sopravvivere al mio corpo e di lasciare una traccia del mio cammino, come i dischi e i libri impolverati che trovo in fondo alla cassetta da frutta del rigattiere.
Che mi permetta, attraverso le parole, di vivere per sempre.