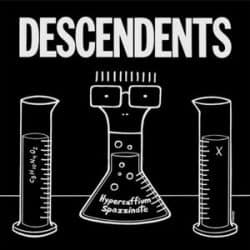Polly Jean Harvey non è più la signorina in stockings della quale vorremmo liberarci, e l’avvicinarsi della senilità le sta giocando un tiro abbastanza comune: dai temi scabrosi degli inizi l’inglesotta piega oggi, proseguendo le ipotesi del disco precedente, ad un approccio sociopolitico.
Il progetto Hope VI (sostanzialmente un repulisti delle zone ad alto tasso di criminalità, con successiva riediCicazione dei quartieri) non è una novità, ma parte del piano urbanistico statunitense dai primi ’90, che ha lasciato come strascico catene e catene di Walmart (The Community Of Hope) e povera gente sfollata e in condizioni di indigenza peggiori di quelle in cui versava in principio. “We set up tents, brought in water, air drops were dispersed. I saw people kill each other just to get there first”. La cantautrice confeziona un sinistro parallelismo con la situazione europea anche in forza dei suoi pellegrinaggi per il mondo: è un disco internazionale perchè diverse realtà sociali potrebbero sentirselo addosso, lo è pure sul versante musicale in quanto l’insieme di tutte le influenze non rampolla affettato ma è tutto un compenetrarsi ed insinuarsi, rendendo il lavoro per così dire intimo, di fabbrica marchiato: o si digerisce tutto il pacco, o tornate a To Bring You My Love.
Menzione d’onore alle occasionali percussioni di Mick Harvey, inconfondibili: suono pieno, riverberato, una marcia imperiosa e solenne scuola Bad Seeds che qui va a disperdersi e compattarsi con i colleghi di studio, primo fra tutti l’immancabile tuttofare John Parish, ormai strarodato cowriter/polistrumentista/produttore eccetera. Quasi ogni pezzo esce marziale, eticamente “punk”: ciao intro, ciao outro. Il blues si intravede attraverso spiragli, in primo piano è il nuovo approccio canoro della Harvey soffocato, ansante, da banshee scortata dagli spettri del resto del cimitero che sono i cori maschili d’accompagnamento (azzeccati); l’artista ha esorcizzato da tempo i propri démoni sessuali (già da Let England Shake) ed ora si dedica alle piaghe dell’essere in un gioco altruistico (seppur a tratti didascalico) forse più diretto che passivo, avendo lei avuto la possibilità di constatazione, che convince soprattutto negli episodi tipo The Wheel, singolo anticipatore senza dubbio efficace, ove il bailamme strumentale compatto degno dei primi Psychedelic Furs dà l’idea di un masso a velocità costante nella foresta amazzonica, una carica di quadrupedi impazziti che abbattono gli alberi e svuotano il greto del fiume al passaggio.
Intenzionalmente il disco è un indurimento del precedente, che aveva episodi simili ma soprattutto rarefatti, eterei; qui la disgrazia esce come una sberla grazie alla propulsione della voce e del folk rock stampede deviato dal noise del Taurus e dai sassofoni tenori che scorrazzano biechi e sinistri in una marcia scuola Bo Diddley (The Ministry Of Social Affairs), nonostante, come già accennato, la maturazione artistica abbia comunque dato un bel colpo alle tibie delle melodie viscerali alle quali la signora ci aveva abituato.
In breve: il mondo è sempre spaccato, il governo se ne fotte e la gente crepa. Nulla che non sappia di già sentito, ma il sentirlo dire da PJ Harvey è sempre un bel ripasso, via.
Tracklist:
1.The Community Of Hope
2.The Ministry Of Defence
3.A Line In The Sand
4.Chain Of Keys
5.River Anacostia
6.Near The Memorials To Vietnam And Lincoln
7.The Orange Monkey
8.Medicinals
9.The Ministry Of Social Affairs
10.The Wheel
11.Dollar, Dollar