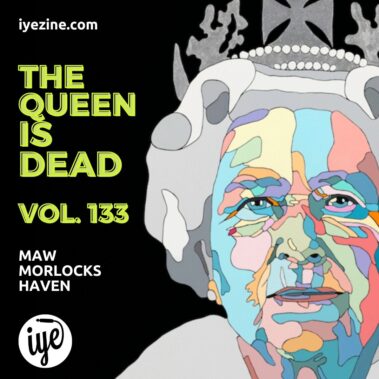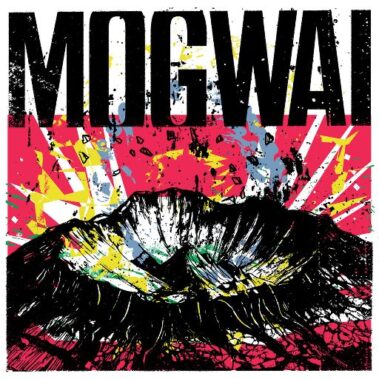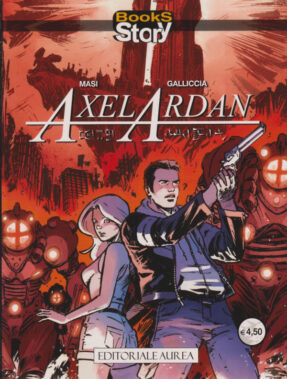Chiariamo subito: il Primavera Sound di Barcellona è sostanzialmente un festival di musica indie, ma non ha nulla a che fare con la moda dei Wayfarer, le camice a quadri e i pantaloni stretti alle caviglie. Come i Built to Spill sono emo-core ma non hanno a che fare con frangette viola e vene tagliate.
La parola d’ordine è ascoltare musica, al Parc del Forum. 204 artisti in 5 giorni di live, suddivisi in 10 palchi. Questa è la questione, e la grande differenza tra il Primavera Sound e gli altri festival. Nessun campeggio con grill, giocolieri e simili amenità che poco c’entrano con la musica suonata.
Arrivati alla decima edizione, gli organizzatori di questo splendido evento perseverano nella la loro politica di non sprecare il loro budget in nomoni altisonanti ma piuttosto ricercare la qualità in gruppi di minor fama (o farli emergere dandogli la possibilità di esibirsi), riscuotendo un successo crescente di appassionati. Il trenta per cento degli abbonamenti si vende prima ancora di annunciare gli headliners, una vera e propria fidelizzazione del cliente. Cinque giorni di rock, electro e pop in tutte le possibili sfumature, più due serate di contorno nell’intimo scenario della Sala Apolo, (mercoledì e domenica) con ospiti del calibro di Los Campesinos e Black Lips
.
Primo giorno – Giovedi 27/05
Le band più convincenti del giovedì pomeriggio appaiono sicuramente i giovanissimi Surfer Blood, figli illegittimi di Weezer e Sonic Youth, che attraverso un surf rock compatto e spensierato inaugurano l’ancora tiepido palco Pitchfork nel migliore dei modi. I Titus Andronicus, poco dopo, hanno sicuramente qualche carta da giocare in più, divincolandosi tra un garage folk filtrato da cori orchestrali alla Arcade Fire e riff dei primi Dinosaur Jr. Capitanati dal leader carismatico Patrick Stickles, presentano l’assoluto capolavoro del 2010 The Monitor rivisitando in chiave punk le vicende della guerra di indipendenza americana. L’ingresso con A More Perfect Union è folgorante, gli strazianti cori folk sospesi tra i Pogues e gli Husker Du di The Battle of Hampton Roads e Four Score and Seven accompagnano per un’ora il pubblico estasiato da quello che sarà considerato uno dei concerti più elettrizzanti del festival.
Gli XX invece confermano tutti i pregi e difetti notati su disco: se da una parte le seducenti atmosfere costruite su groove minimali colpiscono per la loro dolcezza e coerenza, alla lunga la monotonia di una drum sound troppo poco penetrante tende ad appiattire un’esibizione che poteva trasformarsi in un viaggio delicato e nebuloso, in tono con la finissima pioggia che lo ha accompagnato. Invece non deludono (e come potrebbero) i post rockers di Chicago Tortoise, che all’arrivo del palco ATP impressionano già dalla loro disposizione on stage: due batterie disposte una di fronte all’altra al centro del palco, due xilofoni, due bassi e una tastiera. La sezione ritmica è il punto focale del loro show, che spazia tra il jazz e l’ambient di Swung from the Gutter e le atmosfere morriconiane di I set my Face to the Hillside, creando un tappeto di suono che si dilata sempre più col crescere del concerto, fino alla epica ed esplosiva Prepare Your Coffin tratta dal recente Beacons of Ancestorships.
A questo punto compio un errore imperdonabile: lasciare a metà il concerto per dirigermi verso quello dei Broken Social Scene. A dispetto delle mie previsioni, lo spettacolo appare sterile, scontato e di nessuno spessore. Fanno il loro, per carità, ma gli manca quella lucida follia, per intenderci, degli show dei Flaming Lips, che dovrebbe essere poi l’anima di un concerto dal vivo. Sembra invece più un compitino a casa che a stento rasenta la sufficienza. Mi consolo abbondantemente con i Big Pink, i quali stravolgono l’album d’esordio rivelazione del 2009, A Brief History of Love, preferendo coraggiosamente puntare su uno show tipicamente shoegaze, alla My Bloody Valentine, piuttosto che sulla quadratura della sezione ritmica.
Una parte del pubblico, a dir il vero, sembra non apprezzare troppo, forse pensando a delle mancanze nell’impianto sonoro. A me invece piacciono tanto, perché dimostrano di avere interiorizzato nella maniera migliore i propri brani, con belle idee e tanto coraggio. Tutt’altro discorso per i Pavement, da troppo tempo orfani di un palco causa scioglimento. Le loro canzoni, complice il lungo periodo di silenzio, hanno assunto l’aura di hit, e l’effetto si capisce già sui primi riff di Cut Your Hair: trentamila fortunati astanti in adorazione che cantano all’unisono per due ore scarse di spettacolo. E’ chiaro che si tratti di una esibizione epica, sia dal punto di vista qualitativo che emozionale, nonostante il disincanto e la leggerezza con cui Malkmus e soci sembrano affrontare il palco. Dalla festante Shady Lane all’intima Stop Breathing, seguendo sostanzialmente la raccolta di successi appena uscita, Quarantine the Past, ci si immerge nella gioiosa celebrazione di una band che solo ora raccoglie i frutti di una carriera memorabile.
Secondo giorno – Venerdì 28/05
Il venerdì non inizia nella maniera migliore: alla tenda Myspace si esibiscono i Mujeres, gruppo barcellonese ultimamente molto hype in Spagna e non solo. Il tentativo è chiaramente quello di clonare i Black Lips attraverso motivetti catchy ma di un livello qualitativo aberrante. Se li vedete dal vivo, fatemi sapere. Menomale che i Black Lips, quelli veri, suonano fra due giorni. Le cose si fanno serie quando alle 23:00 salgono sul palco Pitchfork i Japandroids, un duo canadese noise/rock ‘n’ roll composto solo da chitarra e batteria. Ammetto di avere avuto un approccio al concerto estremamente critico, dato dalla mia intolleranza atavica verso la formula del duo.
Pensavo non riuscissero in alcun modo a riprodurre l’ottimo Post-Nothing dal vivo. Beh, non avevo capito nulla. I Japandroids sono due e suonano come fossero cinque, forse sei elementi. L’ardore adolescenziale delle melodie di voce si fonde con riff alla Minutemen e Fugazi, violenti ma incredibilmente diretti (The Boys are Leaving Town, Wet Hair), stonati e disillusi (“We used to dream/ Now we worry about dying”, da Young Hearts Speak Fire). La voce di Brian King annega sotto il riverbero di un muro di chitarra, da cui la batteria hardcore punk di David Prowse emerge in uno spastico ritmo rock ‘n’ roll. Il concerto più riuscito del venerdì, senza ombra di dubbio.
Accorro al palco ATP dove già hanno iniziato i Les Savy Fav, che forse traditi da un’acustica pessima, non vanno a segno, anche per la pochezza dell’ultimo album Let’s Stay Friends, le cui aperture al post hardcore washingtoniano non convincono neppure dal vivo. Per farla breve, Post & Pans e The Equestrian non valgono la metà di The Sweat Descends. Peccato. Arrivano gli Shellac ed è tutta un’altra cosa. Steve Albini e soci, alla quarta presenza in cinque anni al Primavera Sound, imbastiscono un muro di suono nervoso, un suono che, sia chiaro, nessun gruppo al mondo ha. Il mio terzo concerto degli Shellac, probabilmente il più intenso e convincente.
La serata si conclude con i Pixies, che sostanzialmente fanno i Pixies e nulla di più. Pezzi storici, adorabili, che vivono dentro di ognuno di noi. Ma perché riproporli da sei anni senza cambiarne una virgola? L’idea del baraccone è lì dietro l’angolo, ma di questo gruppo non posso parlare male. Se non li avete mai visti, andateci. In caso contrario, scegliete qualcosa di nuovo.
Terzo giorno – Sabato 30/05
Il sabato si apre molto meglio del venerdì, con i Real Estate ed il loro sognante indie pop di stampo psichedelico. Una perla rara, delicati arrangiamenti alla Beach Boys che senza grossi sconvolgimenti avvolgono gli ascoltatori in una lieve spensieratezza che allevia i vari acciacchi muscolari dovuti alle fatiche dei giorni precedenti. Da rimarcare la splendida Black Lake e la dolcissima Fake Blues, che ricorda tanto i Born Ruffians.
Florence and The Machine è invece solo una bellissima ragazza conciata da vestale che fa di tutto per appassionare un pubblico distratto, che aspetta giusto il singolone You’ve got to Love per smettere di chiacchierare. Poi riprende a chiacchierare, e ne ha ben d’onde. Se Lady Gaga fa il pienone a Glastonbury, qui MTV non attacca. Anche perché a poca distanza stanno per iniziare gli eterei, tanto attesi Grizzly Bear.
Che superano le pur notevoli aspettative date dall’eccelso Vekatimest, inserendo in trame e strutture musicali intricate delle semplicissime melodie vocali. Quello che riescono a fare solo i Radiohead, per intenderci. Progressive stratificazioni di rilanci armonici, in una matrice folk resa funzionale dalla coralità di quattro strumentisti/cantanti che lasciano letteralmente senza fiato, tra echi di Sigur Ròs e Animal Collective, meritandosi un posto d’onore nella scena indipendente del momento.
Scappo per deliziare le mie orecchie con Doug Marsh e i suoi Built to Spill, il cui concerto non nascondo essere entusiasmante, per quanto il palco sia quello maledetto in cui li vidi tre anni or sono, quando ebbi dei forti istinti omicidi nei confronti del fonico. Esibizione intima, i cui picchi appaiono sicuramente una dilatata Wherever you Go, le cantatissime Carry the Zero, Goldsoundz e In the Morning.
Evito per pura pietà di parlare delle Dum Dum Girls, scontate e stonate (in tutti i sensi), ed arrivo al gran finale, ovvero lo spettacolo offerto dagli HEALTH, band noise/industrial di Los Angeles. Potenti, compatti, mostruosi, per come propongono e stravolgono il loro ultimo lavoro Get Colour, fatto di tribalismi elettronici selvaggi. Come se gli Holy Fuck facessero uno split con gli ZzZ, o coi Pan Sonic. Una sorta di tecno rock in perenne tensione, un capolavoro per semplicità e coerenza.
E’ il gran finale di un festival perfetto, nella location quanto nelle scelte artistiche. Da cui molti grandi festival italiani hanno tanto da imparare.