Forse non ci si fa caso ma, a pensarci bene, Spielberg è innanzitutto un regista di film di fantascienza.
In passato ci ha parlato degli alieni buoni (E.T., Incontri ravvicinati del III tipo) e di quelli cattivi (La guerra dei mondi), ha creato distopie in cui vige il processo preventivo alle intenzioni (Minority report) o altre nelle quali i robot diventano i servi buoni di una società in disfacimento (A.I.), grazie alla saga di Jurassic Park ci ha mostrato l’avveniristico ritorno dei dinosauri sul nostro pianeta. Con quest’ultima pellicola ci porta ora in un futuro prossimo, quando l’umanità avrà definitivamente rinunciato alla vita reale per rinchiudersi in una dimensione parallela, seppure legata in maniera immanente a quella attuale: la cosiddetta “realtà virtuale”.
C’è questo Halliday, di professione game designer (la cui interpretazione ricorda in maniera inquietante, sia per atteggiamenti che per aspetto fisico, la figura di Casaleggio, magari con un tocco aggiuntivo di Andy Warhol): un inetto alla vita, genio informatico, eccellente mente creativa, bamboccione invincibilmente segregato all’interno della propria sfera infantile e prepuberale, che, intorno agli anni ‘20 del secolo corrente, progetta la madre di tutti i videogame: Oasis. Un gioco immersivo pieno zeppo di tutta la cultura popolare degli ‘80 e dei ‘90. Il buen retiro, la vita reduplicata e sublimata, un immaginario solipsistico reso collettivo, entro cui i tapini del mondo a venire si rifugeranno, preferendolo alla loro modesta realtà quotidiana.
Tempi in cui gli esseri umani «hanno smesso di risolvere problemi e si accontentano di tirare avanti», come spiega la voce narrante del protagonista all’inizio del film.
Ma funziona veramente così?
Allargando per un attimo il discorso, il cervello umano, lungo tutto il suo processo di sviluppo corticale, si è evoluto per risolvere problemi, per l’appunto. Il primo problema da risolvere (primo sia in senso logico che cronologico) è stato quello che potremmo definire “la caccia all’antilope”, ossia il giornaliero procacciamento di cibo e di sussistenza fisica. Ora che per nutrirci ci basta andare ad acquistare il nostro succoso pezzo di carne rossa al supermarket più vicino e che il progresso sociale ci ha resa di facile disbrigo anche la maggior parte delle incombenze che occupavano l’esistenza dei nostri remoti antenati, spesso fatichiamo a trovare ambiti cui applicare queste nostre facoltà euristiche. È così che subentra la noia, il male oscuro, la melancolia e le altre forme di disadattamento psichico tipiche dell’era in cui viviamo (difficile infatti pensare a un australopiteco che trovasse il lusso di piangersi addosso, impegnato com’era a inseguire nella savana il suo auspicabile pasto serale, tuttora semovente sopra le sue quattro agili zampe, o, per converso, a rifuggire un grande felino che lo avesse scelto come succulenta preda). Ecco che, per rimediare a una tale penuria di obiettivi concreti, subentrano palliativi e ripieghi di vario genere.
Sherlock Holmes, com’è noto, quando si trovava a corto di casi da risolvere, si iniettava in vena cocaina in soluzione al sette per cento, tanto per tenere la mente occupata. Qualcosa di non molto dissimile compiono i videogiocatori: un’evasione dal reale alla portata di tutti la cui sostanziale fascinazione risiede forse proprio nel fatto che, durante il suo svolgimento, il videogioco sottopone i suoi fruitori a una serie di missioni e traguardi che valgono per la nostra mente quali surrogati di quei target che i nostri progenitori ritrovavano nel primordiale stato di natura (in una proporzione simile a quella che vige tra metadone ed eroina).
Ogni qual volta ci imbattiamo in un problema, in un rompicapo, in una qualsiasi bega e li risolviamo (a partire dall’abbattimento dell’antilope in fuga per giungere sino alla cattura del “Cecchino Leggendario” in una chest di Fort Knight) l’apparato cerebrale si autogratifica con una scarica di endorfine e anfetamine naturali. Il piacere che ne traiamo innesca un regime di assuefazione che ci costringe a ripetere l’esperienza, risolvendo nuovi problemi, così da godere ancora di quella dolce secrezione drogacea.
Ecco spiegato il premiante meccanismo che (per adoperare una terminologia aziendalista) il problem solving ci procura e che, per contro, l’assenza di preoccupazioni ci sottrae (non è un caso che i nobili dei secoli scorsi, che vivevano di rendita, tra lussi e mollezze, ignari del benché minimo affanno, finissero per suicidarsi verso la quarantina, per mancanza di stimoli…).
Non di meno ogni qual volta superiamo un determinato livello di gioco la ghiandola pituitaria, facilmente ingannata dalla simulazione, che prende per buona, sancisce quel successo videoludico liberando le suddette sostanze ormonali esattamente come se fosse accaduto nella realtà, ovvero sia allo stesso modo che se davvero avessimo conquistato un qualche utile traguardo nella vita vera. Su questo appunto si basa il piacere di giocare ai videogame, che è facile si trasformi in una dipendenza compulsiva (come sanno bene tutti i genitori di teenager). Probabilmente qui sta la ragione per cui soprattutto i giovani più dotati intellettualmente sovente preferiscano le sfide irreali lanciate loro da un dispositivo elettronico alla vita reale, da questo punto di vista non di rado meno stimolante.
Ma, per tornare alla trama del film, a un certo punto si viene a sapere che Halliday, prima di morire, ha inserito in Oasis tre chiavi, collezionate le quali il giocatore diventerà il legittimo proprietario dell’intero videogioco, che spopola in ogni angolo del pianeta.
La fortuna arriderà a una figura quasi cristologica: un giovanotto proveniente dai bassifondi, il cui nickname, non a caso, è Parsifal (il cavaliere della tavola rotonda che, in solitaria, riuscì a brandire il Sacro Graal). Sarà lui a beffare i “Poteri Forti”, qui rappresentati dall’agguerrita squadra di giocatori messi in campo dalla multinazionale IOI, le cui mire sono quelle di dominare a fini pubblicitari il mega-videogioco in questione e i suoi utenti (una curiosa critica se posta da un’effettiva multinazionale dell’intrattenimento come la Warner Bros…).
Non ricordo chi, paragonando il cinema di David Lynch a quello di Steven Spielberg, affermasse che quella del primo è la visione del mondo che ha un bambino, mentre quella di Spielberg è la visione di un adolescente (quindi maggiormente sfruttabile in campo commerciale con un pubblico, come quello nordamericano, sostanzialmente contraddistinto da una mentalità da adolescenti), ma chiunque l’abbia detto aveva ragione: il Weltanschauung spielberghiano è quello di un ragazzino da scuole medie. Ossia di quando tutte le paure e i sacri stupori del mondo dell’infanzia sembrano essersi dissipati e, nel frattempo, non è ancora sorta quella nuova erotizzata visione del mondo, indotta dalla piena pubertà. È perciò una percezione a suo modo eroica e immacolata, in cui il buono, se ce la mette tutta, vince sempre, in cui l’amicizia (ben prima dei legami affettivi e amorosi) è il collante esistenziale, in cui ci si aggrappa a nuovi referenti culturali per provare a capire di cosa e come sia fatto il mondo che ci circonda.
E questi referenti costituiscono in larga parte la cosiddetta cultura pop di cui il videogame di Halliday, e più in generale il film di Spielberg, è un tripudio.
Si è parlato, a buon diritto, di consacrazione del “nerdismo” per quanto riguarda Ready player one. Ma chi sono precisamente i nerd, al di là del cliché dell’ultraquarantenne amante di una vita sedentaria e di pasti ipercalorici consumati sul divano col joystick della Playstation 4 in pugno?
Spesso i più ferrati in materie scientifiche e tecnologiche lamentano la scarsa preparazione degli umanisti a tal proposito. Ebbene i nerd sono il corrispettivo speculare dell’umanista che poco si intende di scienza: preparatissimi sugli ultimi ritrovati tecnologici e sulle più recenti conquiste interspaziali, si perdono poi nel culto di b-movie, di brutti telefilm, di manga e anime giapponesi di scarso valore.
Si è iniziato con il legittimo intento di contrastare una certa critica pedante e professorale, sdoganando correnti artistiche innovative e underground, poi, generazione dopo generazione, si è finito con l’idolatrare robaccia inconsistente, per il solo (inconfesso) motivo che ci piaceva tanto a dieci anni e che ora ha su di noi un effetto peterpanesco simile a quello della madeleine proustiana. Con l’aggravante che nei tempi correnti un apparato critico capace di dirimere tra prodotti di cattivo gusto e creazioni di oggettiva qualità (o che quell’oggettività perlomeno rasentano) sembra essere quasi del tutto scomparso. Così da lasciare i giudizi estetici in balia del più arbitrario, e quasi sempre poco coltivato, gusto personale.
La grandezza di un’opera certamente non dipende dalla sua collocazione commerciale o dal target che le sia stato assegnato dall’ufficio marketing, bensì da prerogative intrinseche sue proprie, che giusto un occhio capace e allenato sa cogliere con sufficiente sicurezza. Il flauto magico di Mozart o La cappella sistina dipinta da Michelangelo sono lavori che nascono per la fruizione più ampia possibile. È il loro indiscutibile valore ad averle poi imposte quale supremo canone dell’ingegno artistico. Per fare un esempio personale, io adoro i fumetti di Batman, non me ne perdo un numero, ma mai mi verrebbe in mente di equipararli a un romanzo di Gadda (mentre – proprio per far capire come il merito di un’opera non dipenda dal medium o dal tipo di pubblico pensato per essa – mi viene naturale paragonare le grandezze di Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza e di La cognizione del dolore).
Il nerd par excellence, da questo punto di vista, è stato Umberto Eco. Fu lui il primo a sdoganare la cultura popolare con il celebre Apocalittici e integrati e da lì in poi continuò ad accostare indistintamente Mandrake e la Recherche di Proust, I tre moschettieri e Finnegans Wake, sia nelle vesti di semiologo che applicando una tale sospensione del giudizio critico nella materia narrativa quale fortunato romanziere. Il rischio è che dalle sue pagine venga fuori, più che un crogiolo culturale, un salad bowl di citazioni colte e riferimenti del tutto ininfluenti…
Tornando al film, entrare in Oasis si rivela un viaggio all’interno della testa del suo autore – un nerd nato, a conti fatti, negli anni ‘80 del ‘900 – e di tutto ciò che la ingombra (un po’ come guardare le trasmissioni Fininvest degli esordi – come si sarebbe arguito in seguito – equivaleva a immergersi nelle fissazioni soft-porno e nei gusti ricreativi del suo inventore): un’accozzaglia di programmi, giochini, film, telefilm, citazioni varie in cui tutto ha lo stesso peso, senza alcun tipo di assiologia morale o estetica. Gundam, Minecraft, Mega-Godzilla, Kubrick, Ritorno al futuro, King Kong, il ciclo arturiano, i fumetti della DC Comics: tutto messo insieme, e giustapposto, senza distinzione e a rischio di evidenti stridori. Questa, del resto, è l’essenza della cultura pop.
Il pericolo, come si sa, è che il brutto attiri a sé ciò che è bello, tendendo ad annullarlo.
E in un’epoca in cui il colto ha lasciato il posto al nerd e il critico al blogger quest’eventualità si fa ancora più preoccupante.
Domanda: Spielberg, con un’operazione del genere, ha consacrato (o stigmatizzato con una certa velata ironia) la cultura pop come forse si augurava programmaticamente o non ha finito piuttosto per esserne fagocitato a sua volta, costruendo un film che non riesce a elevarsi dalla piattezza avalutativa che identifica proprio quel tipo di sottocultura?
Il film si conclude con un monito che tende a ridimensionare l’epicità dei giochi virtuali (fino a quel punto così potentemente abbozzata) e, più in generale, di quel mondo finzionale e privo di concretezza entro cui l’archetipo nerd pare calarsi tanto volentieri: «Solo la realtà è veramente reale» avverte Halliday stesso, con una tautologia anti-hegeliana che ci riporta alla mente quel che ci diceva mamma, nei pomeriggi di primavera: «Ora basta con ‘sti videogiochi. Esci a giocare in cortile, che c’è un bel sole.»










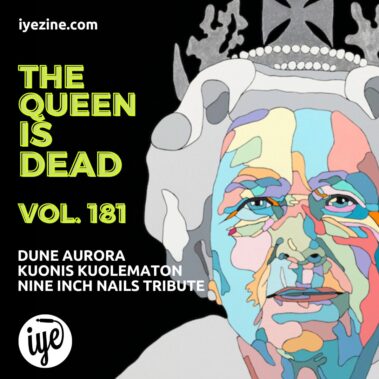

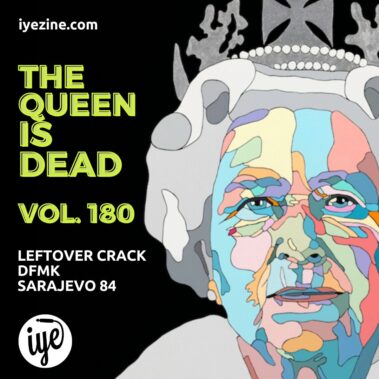
5 risposte
E’ giusto che un articolo ogni tanto spari a zero, mostrandosi convinto, per partito preso o per provocare un commento, generare un’attenzione con conseguente discussione che possa essere costruttiva; tanto più che qui c’è anche un tocco di ironia che rende umano anche il peggior critico.
Ma quanti anni avrà adesso Spielberg, basta andare su gugol e controllare: e del dicembre 1946. 71 anni suonati ed una mente che al pari di un videogioco accetta una sfida, quella di risultare vincente ancora una volta.
Se un 71enne decide di portare avanti un film del genere, credo che non si sia stufato (come quei ricchi nobili che pur nell’agio sfrenato si suicidavano a 40 anni per aver fatto di tutto e di più) di questa vita, ma è probabile, per insistere sul paragone di classe, che Spielberg pur avendo bruciato le tappe terrene, si sia per forza dovuto affacciare ad altro, appunto al mondo dei drogati, dei Junkies pesanti. E avendone i cospicui mezzi, ogni esperienza fatta dal nostro può essere tramutata in una macchina mangiasoldi, così eccoci a sorbirci un ennesima adolescenziata del nostro bambinone milionario.
D’altronde il pubblico che va al cinema è anche e soprattutto quello giovane, quello che può determinare e generare un marketing sull’emulazione di ciò che vede. Sì, d’accordo, esistono gli adulti 40enni che ancora sbavano dietro un joystick al posto di rincorrere gonnelline fuori dalle università, e il giudizio critico si è perso nelle ezine o nelle riviste on line zeppe pure di ciarlatani (compresi quelli che hanno studiato). Il soggettivismo ha la meglio sull’accademismo ed è pur vero che una cultura occorre farsela sui libri ma neppure contando solo su quelli, almeno finché parliamo di umanesimo.
Mi fanno invidia i quarantenni che sono innamorati del Joystick e non devono pensare a null’altro che a ricaricarire e scaricare le loro endorfine attraverso la simulazione, io invece, che devo andare a caccia tutti i santi i giorni per procurarmi almeno una pollastrella da mettere sotto i denti, devo sudare sette camicie e devo anche lavorare in un’industria spenna polletti da supermercato. Sicuramente ancora il ceto, i privilegi di classe, o la malattia mentale, fa sì che qualcuno paghi le utenze e il cibo ipercalorico da trangugiare avidamente ruttando ad ogni sorso di birra frizzantissima fatto da sti trogloditi del joystick.
E pensare che le mie nipotine vanno in piscina, i miei nipoti giocano a calcio, io tiro con l’arco e il mondo pullula pure di associazioni ludicosportive: ma chi ci andrà mai a tirare due calci al pallone ai giardinetti, oramai? Svolgere tali attività forse si possono conciliare, dico forse perché voglio lasciare il forte dubbio, con i videogame? Fare tutt’e due le cose insieme, come sarebbe? E magari anche studiare per la scuola? Tre cose insieme: INCREDIBILE pure per Spielberg pensare una cosa così articolata (le tre chiavi)!
E’ pure normale che ‘sti giovinastri e quarantenni scoreggioni non trovino spazi stimolanti che li facciano primeggiare nella competizione frutto del problem solving strategico direttamente in the street, proprio come quella canzone “Street Fightin’ Man” degli Stones, i quali pure loro si sono rincitrulliti come Spielberg del rest; colpa dei soldi si dirà, ma anche dell’età che non consente di avere le stesse molle ed impulsi proprie di un giovinastro. Ed è triste vedere ancora questi vecchietti parlare e vendere i loro prodottucoli ai ragazzini, pischelli che si comprano con 4 gadget o storielle d’accatto come quelle propinate fantascientificamente da Spielberg.
Magari i giovani hanno bisogno di storielle, ma non di quelle castranti raccontate dai grandi volponi hollywoodiani. E forse un buon libro saltuariamente letto salverebbe il giovane dallo Zucchero e dall’azione cattolica, e soprattutto dalla pubblicità!
Infine spero solo una cosa, che non nasca un regista stellare che giri film che vadano oltre i contenuti del target adolescenziale, a quel punto, dio ce ne scampi e liberi, tornerà a tutti la voglia di amoreggiare nel buio dei cinema.
Un’aggiunta che mi sono perso, pardon: ” E’ pure normale che ‘sti giovinastri e quarantenni scoreggioni non trovino spazi stimolanti che li facciano primeggiare nella competizione frutto del problem solving strategico direttamente in the street, perché stanno sempre in cameretta davanti allo schermo a videogiocare.”…
Commento bello, argomentato e ben strutturato. Per quanto mi riguarda, ciò che mi premeva non era certo demonizzare il film, che, come tutte le pellicole spielberghiane, si presenta come una divertentissima esperienza visiva (altre volte Spielberg ci ha dato anche molto altro, ma questo aspetto qui riveste un’importanza relativa). Mi interessava più che altro condividere le riflessioni “a margine” che il film mi ha suscitato (e già una tale capacità suggestiva è cosa rara). Neppure era mia premura demonizzare i videogames (che anzi in qualche modo qui sopra giustifico) o la cultura pop e nerd. Semplicemente mi piaceva cercare di investigarne i rispettivi meccanismi
Ho letto il tuo commento Pee Gee. Belle le tue riflessioni nell’articolo (che ho usato di riflesso). Spero di aver io demolito un po’ Spielberg, perché mi sta antipatico, mi ricorda per qualche ragione Michael Jackson in iperbarica.
Ciao, spero di rileggerti presto.
bella l’ immagine “Michael Jackson in iperbarica”, molto cyperPUNK