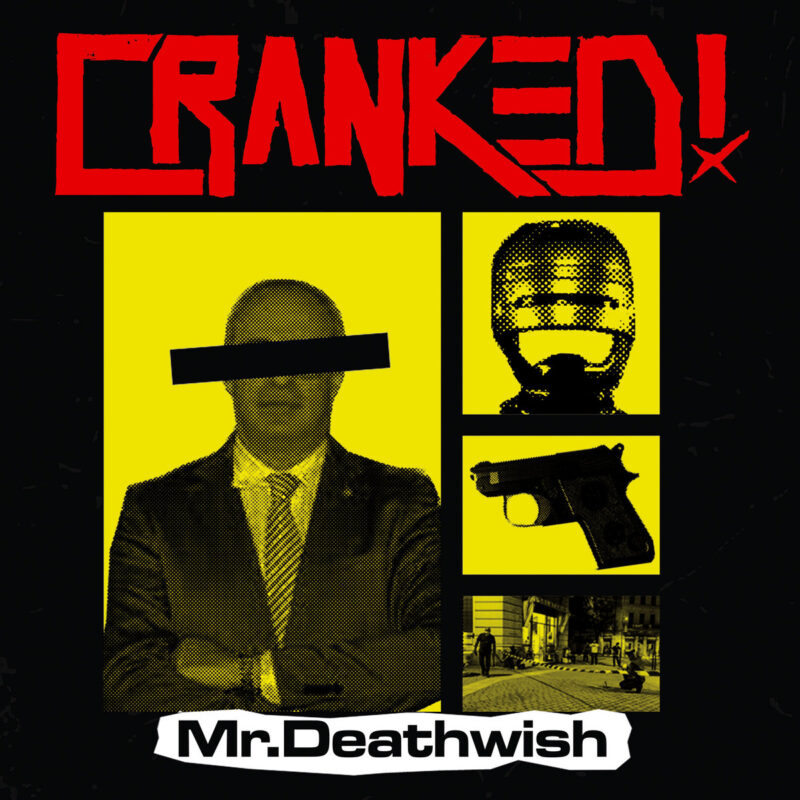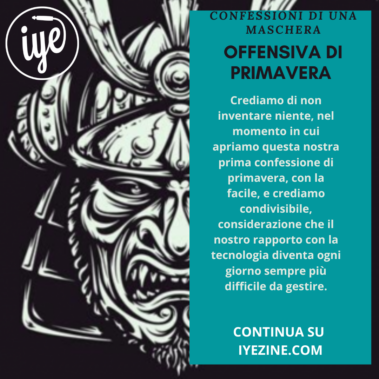“Un destino ridicolo” di Fabrizio De André e Federico Gennari (Einaudi)
Può suonare strano parlare oggi di un romanzo uscito nel millenovecentonovantasei. Ma non è così. Non è questo il caso. La storia ci insegna a guardare sempre indietro, per capire che cosa ci siamo perduti e dove abbiamo sbagliato. In ogni ambito. Per cui, oggi duemilaventuno, andare a rispolverare un qualcosa di cui si sono [forse troppo presto] perse le tracce nei meandri della memoria, deve essere visto come un tentativo differente di approcciare la realtà contemporanea. Tentativo che merita di essere messo in atto anche solo per provare a modificare il nostro punto di vista su quello che sta accadendo. Se poi l’autore si chiama Fabrizio De André capite bene che si tratta di un qualcosa di assolutamente doveroso.
I tempi sempre più tristi che stiamo vivendo impongono la riscoperta e la riproposizione di valori desueti da un punto di vista cronologico ma mai dimenticati del tutto. Soprattutto eticamente. E quale maestro migliore di De André per riprovare a ripartire da quelle che dovrebbero essere le dinamiche su cui erigere le nostre vite? Condizionato forse dai ripetuti ascolti dell’intera discografia del maestro Faber con cui ho scelto di allentare la morsa stringente dell’idiozia dei nostri giorni, ho deciso di andare a riprendere questo suo “Un destino ridicolo” scritto a quattro mani insieme a Federico Gennari nel lontano millenovecentonovantasei e uscito quasi in contemporanea al suo ultimo album “Anime Salve”.
Come detto in apertura, il romanzo scivolò frettolosamente nel dimenticatoio, schiacciato da un album strepitoso come “Anime Salve” e dalla prematura scomparsa dello stesso De André avvenuta nel giro di un paio d’anni. Ma non per questo dobbiamo esimerci dal sottolinearne l’impatto emotivo e culturale che ancora oggi suscita alla lettura. Dentro c’è tutto il mondo di De André, con il suo carico di emarginazione, voglia di rivalsa, orgoglio e dignità. Un mondo che abbiamo imparato a conoscere e ad amare con le sue canzoni. Un mondo torbido, degradato, in cui si muovono però anime candide, pure, caratterizzate da quell’umanità che oggi non riusciamo più a trovare. Se scrivi De André automaticamente leggi Genova. E difatti la grande protagonista del romanzo è proprio la città ligure. Ambiente ideale in cui far muovere i personaggi che non fatichiamo a riconoscere nelle figure che hanno animato le sue canzoni più famose. C’è tutto quello che ci ha sempre raccontato con i suoi dischi. Ci sono tutti i rumori dei carruggi, che si mescolano con quelli del mare e di una malavita silenziosa ma presente ad ogni livello sociale. I quartieri del centro storico a ridosso del porto, con il loro carico di colori, calore e speranza sono la culla del romanzo, che, occorre precisarlo, è tutt’altro che una serie di autocitazioni che sfociano nell’autoerotismo con cui compiacersi. Al contrario, la trama è forte e lineare, che non perde mai di coerenza, e che anzi, man mano che si prosegue nella lettura acquista forza.
De André canta la vita e scrive la vita. Quella vera, quella vissuta sulla propria pelle. Nel romanzo “canta” un trio di personaggi che in apparenza possono sembrare distanti ma che con il passare delle pagine si rivelano molto più vicini e legati da un destino ineluttabile, per certi versi “ridicolo”. Un intellettuale marsigliese passato dalla Resistenza alla malavita, un pappone sognatore e indolente e un pastore sardo che ha alle spalle una pesante condanna da cui è fuggito. Tre uomini lontanissimi che il destino riunisce a Genova per il colpo che sognano da sempre come viatico per svoltare. Intorno a loro si muovono le “princese”, le “bocche di rosa” e tutte quelle figure che conosciamo. Siamo nel 1963, Genova, ma non solo, l’Italia intera si sta lentamente scrollando di dosso le scorie e le miserie di un dopoguerra che ancora non è stato metabolizzato del tutto. Lo scenario è quello di un paese ancora fortemente rurale che sta rialzando la testa, ma lo fa con fatica.
Che cosa ci resta alla fine del libro? La consapevolezza che ognuno di noi, ha saputo fare fronte ai suoi fallimenti, piccoli o grandi che siano. E che al tempo stesso siamo consapevoli del fatto che il destino sia in parte indirizzabile da quelle che sono le nostre scelte. Mai come oggi siamo certi di esserci “spiati illuderci e fallire” e che gli ultimi non saranno mai i primi.
«A cosa serve tutto questo? Vivere, soffrire e tutto il resto». «A niente. Non a niente in assoluto ma a niente per quanto ci riguarda come individui che comprendono solo ciò che possono distruggere. E in questa infinita gratuità intravedo quello che ho sempre cercato nell’anarchia: una libertà assoluta, incomprensibile ed estranea alle nostre spiegazioni, qualcosa che mi viene spontaneo chiamare Dio».