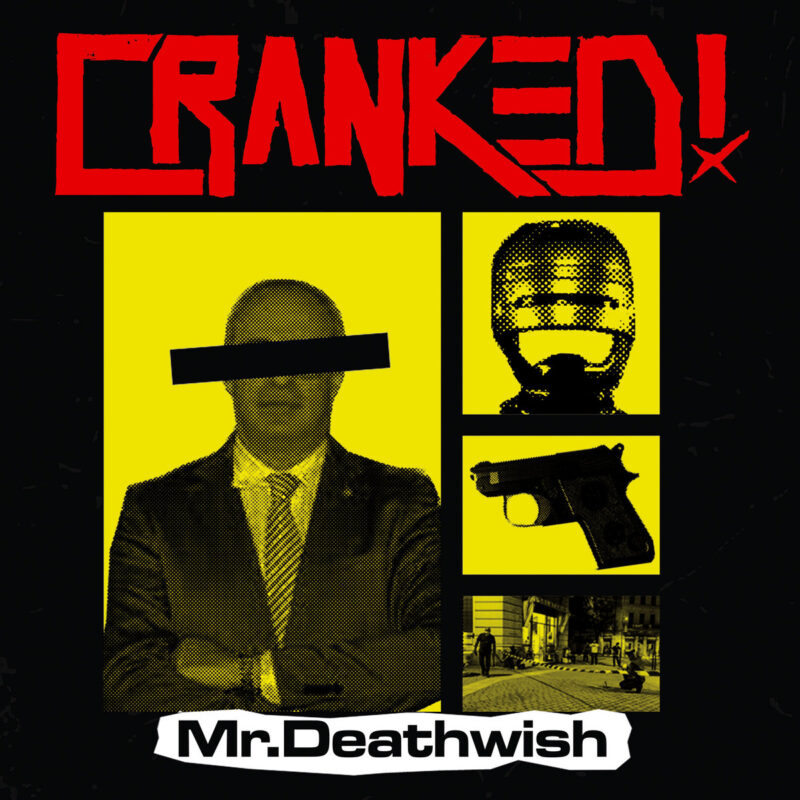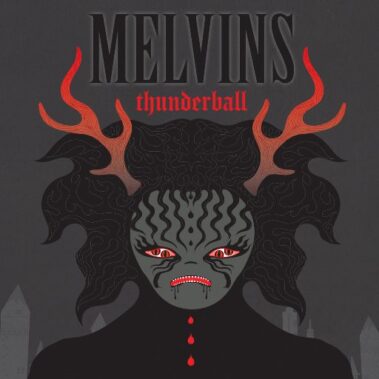Se anche voi, come me, non ne potete più del business modaiolo delle maxiristampe commemorative “anniversary edition” degli album (pensate esclusivamente per spennare i feticisti del collezionismo discografico, con la scusa della retromania nostalgica/celebrativa) nei formati “super deluxe boxset” di otto vinili da 180 grammi, che per comprarli bisogna quasi accendere un mutuo, e contenenti la “bellezza” di cinquanta b-sides e tracce bonus (in cui sono stati rimasterizzati, dai nastri analogici originari, anche i rutti e i peti dei musicisti e dell’ingegnere del suono) allora per voi può rivelarsi salvifico aprirsi ad altre strade meno battute dalle masse (e dalle multinazionali) e tornare a esplorare o scoprire gemme nascoste del rock ‘n’ roll. Una di queste è sicuramente rappresentata dai californiani Yawning Man, seminale band stoner/psych, padrini del “desert rock“, uno dei segreti meglio custoditi in ambito di “musica alternativa(e)” statunitense, nonché uno dei suoi tesori meglio conservati e da (ri)valorizzare.
Alfieri della scena di Palm Desert, i Yawning Man si formano nel 1986 e sono (stati) tra i principali fautori e agitatori del movimento ribattezzato, come scritto qualche riga più su, desert rock, un cocktail sonoro – corroborato da un uso ricreativo e ispirazionale di erba, peyote, LSD e funghi magici – che mescola elementi hard/heavy rock/metal, psichedelia, punk, blues e alternative rock (non a caso lo “stoner rock” sbocciato in California è sempre stato visto come una sorta di cugino meno famoso e meno celebrato della scena “grunge” sviluppatasi a Seattle e nel Nordovest degli States più o meno nello stesso periodo, e soprattutto avendo praticamente le stesse influenze musicali in comune) con una spiccata attitudine alla jam e al gusto per l’improvvisazione, e caratterizzata da una mutua collaborazione tra i musicisti della scena coinvolti in varie band e progetti comuni. La peculiarità di questa epopea “sotterranea” era data dalla sua stessa definizione, in quanto il “rock del deserto”, letteralmente, si è forgiato nel rovente deserto della California meridionale, irrorato dalle speziate atmosfere latinas provenienti dal vicino Messico: all’infuori del piccolo circuito di bar, i gruppi della scena di Palm Desert (con in testa alla carovana, ovviamente, i Kyuss, la punta di diamante del magma stonato emerso da quelle terre aride, e che poi in seguito ha partorito, da una sua costola, i Queens of the Stone Age, la creatura di maggior successo commerciale figlia di quell’esperienza “desertica”) non avendo club in cui suonare, si inventarono l’esperienza dei “generator parties” (il cui nome prendeva spunto dai generatori di corrente che alimentavano ampli e strumenti) cioè dei concerti, spesso dalla durata di svariate ore, tenuti all’area aperta per una manciata di fan e appassionati (gonfi di birre e sostanze stupefacenti) nelle aree desertiche di paesi e città della California meridionale.
Ma, se tutti ricordano e adorano, giustamente, i Kyuss, è altrettanto giusto (riba)dire che, senza prime movers come i Yawning Man, difficilmente questo sottogenere avrebbe preso piede e si sarebbe sviluppato, a macchia d’olio, in giro per gli States e, poi, per il mondo. Dediti a lunghe jam nei “locali” disponibili nella seconda metà degli Eighties (cioè i garage e il caldo spazio aperto desertico della Coachella valley) i nostri hanno forgiato un sound che poi avrebbe ispirato proprio i Kyuss che, nel loro album del 1995 “…And the circus leaves town“, avrebbero coverizzato un loro brano, “Catamaran” (nel quale ha suonato il batterista Alfredo Hernandez, già drummer e membro fondatore proprio dei Yawning Man insieme a Gary Arce e ai cugini Larry e Mario Lalli) e hanno registrato, su due demo, una manciata di pezzi (poi recuperati nella raccolta “postuma” del 2009, “The birth of Sol (the demo tapes)“) ma per vedere pubblicato materiale ufficiale si è dovuto aspettare fino al 2005, anno della release del loro primo vero album, composto da dieci brani registrati l’anno precedente, “Rock Formations” (a metà Nineties i ragazzi si erano persino cimentati in una avventura chiamata The Sort of Quartet, realizzando quattro dischi all’insegna di sperimentazioni e trame free jazz) mentre iniziavano a guadagnarsi pubblici attestati di stima e riconoscimenti da parte di “colleghi” come Brant Bjork (che insieme ai cugini Lalli ci ha suonato nei Fatso Jetson) a cui hanno fatto seguito l’Ep “Pot head“, alcuni progetti collaborativi/split album, il secondo Lp “Nomadic pursuits“, poi un terzo, “Historical graffiti“, un quarto long playing, “The revolt against tired noises” (in cui è stata incisa ufficialmente “Catamaran”) e il quinto, “Macedonian lines“, uscito nel 2019, e tutti connotati da sonorità space rock/stoner/psichedeliche quasi interamente strumentali.
Nel giugno di quest’anno L’Uomo Sbadigliante ha partorito il suo sesto disco, “Long walk of the Navajo“, uscito sulla label italiana Heavy Pysch Sounds, registrato (e missato da Steve Kille) da una line up a tre membri: Gary Arce alla chitarra, Billy Cordell al basso e Bill Stinson alla batteria. Le sessioni di incisione sono state ispirate da una tempesta di sabbia che ha colpito Joshua Tree e dintorni e ha fatto da cupo sfondo alle jam creative del trio, che ne offre una prova convincente già nella title track, posta in apertura, quindici minuti in cui la chitarra ipnotica di Arce si lacera in un lungo lamento straziato (quasi una trasposizione in musica dell’urlo degli indigeni perseguitati) e imperversa lungo tutto il mood drammatico del pezzo, tra distorsioni e feeling “apocalittico”, ma di lucida bellezza. La successiva “Respiratory Pause” è un’altra struggente suite space-pysch dall’incedere pesante e caratterizzata da un taglio artistico malinconico. La conclusiva “Blood Sand“, frutto di una jam completamente improvvisata, è un resoconto di “caos calmo” di nove minuti incastonati nel vortice di polvere e sabbia desertica che travolge l’atmosfera e incendia gli spiriti indomiti.
Tre soli brani, tutti strumentali, ma quasi quaranta minuti di durata in cui, però, non ci si annoia mai, e questo è un pregio abbastanza raro per un disco non cantato. In questi tempi tremendi in cui i concetti di genocidio razziale e di “pulizia etnica” dei popoli, purtroppo, sono tornati a essere di stretta attualità ed essere usati con sconsiderata leggerezza/follia dal Leviatano a stelle e strisce – e sodali – che tiene in ostaggio il mondo con le sue politiche guerrafondaie (e che nulla ha imparato dagli errori del passato) un disco come “Long walk of the Navajo” risulta essere, suo malgrado, sul pezzo, affrontando la dolorosa tematica della pratica criminale di sterminio dei nativi americani (nel caso specifico, della fiera comunità Navajo e della campagna di guerra mossa, ai loro danni, dal governo yankee nel biennio 1863-64, che costrinse migliaia di nativi indiani a combattere, essere uccisi in battaglia e a essere sradicati dai loro luoghi a causa di una forzata deportazione di massa imposta dalle autorità) perpetrata dall’uomo bianco/colonizzatore europeo nei secoli scorsi, e che oggi si ripropone in scenari più vicini a noi, non lontani dal “nostro” mar Mediterraneo, in cui i popoli oppressori impongono ancora l’apartheid ai popoli oppressi (derubati di terre e dignità e rinchiusi in una Striscia di terra che è un carcere a cielo aperto, quasi alla stregua delle odierne riserve indiane negli States) e i mass media, controllati dal suddetto Leviatano, mistificano la realtà facendo passare l’aggressore per aggredito e viceversa. LWOTN è un album che fa cantare visioni, immagini, storia, identità e natura, riesce a essere più espressivo di tanta musica verbosa e fa riflettere più di quanto ci si possa immaginare.